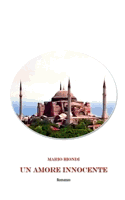Scrive di: Tiziano Terzani
1. Lettura editoriale: "La porta proibita" (1984)
2. Intervista: “Lettere contro la guerra” (2002)
3. Un ricordo a proposito di: “Un mondo che non esiste più” (2010)
1. Lettura editoriale: "La porta proibita" (1984)
2. Intervista: “Lettere contro la guerra” (2002)
3. Un ricordo a proposito di: “Un mondo che non esiste più” (2010)
© Mario Biondi
Divieto di riproduzione integrale
e obbligo di citazione (per cortesia...)
Il primo febbraio 1984 Tiziano Terzani venne arrestato a Pechino, perquisito, sottoposto a penosi interrogatori, dichiarato “non adatto a vivere in Cina” e finalmente espulso dal paese. Vi era risieduto per quattro anni, con moglie e figli, esercitando la propria professione di giornalista, attiratovi dal "mito dell'altro", dal fascino della "diversità" che l'esperimento comunista cinese aveva irradiato sui giovani di tutto il mondo. In quei quattro anni aveva voluto guardare oltre il "mito".
Aveva visto (e scritto di) cose assai diverse da quelle che in superficie appaiono all'incantato viaggiatore accompagnato in Cina dalle agenzie turistiche. Aveva scritto delle immense contraddizioni del socialismo cinese, dal primo Mao, attraverso la cosiddetta Banda dei Quattro, fino al nuovo corso di Deng Xiaoping; degli irreparabili guasti provocati dalla Rivoluzione Culturale; dell'apparente (e tacitamente accettato) sopravvento ripreso dal "capitalismo" in certe zone di confine; della situazione delle minoranze - uighur, kazak, tibetani - in altre zone di confine. Aveva visto splendidi tesori della multimillenaria storia e cultura cinese distrutti in nome di un "nuovo" spesso colpevole di edificare pletoriche e inutili cattedrali nel deserto.
Aveva percorso il paese servendosi di tutti i mezzi possibìli, non ultima la bicicletta, per uscire dagli itinerari canonici e parlare sul serio con la gente. Aveva, per tre anni, mandato i propri figli in una scuola cinese. Aveva voluto vivere da "cinese" per arrivare, tuttavia, a sentirsi veramente cinese soltanto negli ultimi giorni di permanenza in Cina, quelli dell’arresto, del confronto con la polizia, dell'autocritica scritta a comando. Ricco di notizie e dati, di considerazioni e umori, questo libro in cui Tiziano Terzani — in Cina, Deng Tiennuo — racconta la propria esperienza cinese è al tempo stesso un reportage giornalistico, una cronaca di viaggio, un trattato di sinologia contemporanea l’appassionato romanzo di un’avventura umana.
2
L'11 settembre del 2002 è una data che rimarrà incisa a caratteri di sangue negli annali di questo primo secolo del Terzo Millennio, come altre date lo sono negli annali di altri secoli. Tiziano Terzani, che ormai vive abitualmente in Asia dove passa "gran parte del tempo nell'Himalaya", era in Italia, ha visto come tutti noi i terribili eventi alla televisione, ha provato l'insopprimibile impulso a scrivere una "lettera" su quegli eventi, da rivolgere al più ampio pubblico possibile attraverso il grande quotidiano italiano a cui collabora. Pochi giorni dopo era già ai confini del Pakistan con l'Afghanistan, nel febbrile tentativo di capire il "perché" di quanto avvenuto, le ragioni degli uni e quelle degli altri. Da lì è riuscito a entrare in Afghanistan, a raggiungere Kabul e a muoversi per il martoriato paese con tutti gli scarsissimi mezzi possibili, non ultima la bicicletta. Di nuovo, per vedere, per capire. Ne sono nate altre "lettere", da Peshawar, da Quetta, dalla stessa Kabul, da Delhi, dal suo rifugio sull'Himalaya. Per cercare di far "vedere" agli altri attraverso le sue parole, di aiutare a capire. Ne è nato Lettere contro la guerra. Terzani è di nuovo in Italia per l'uscita del libro e ha cortesemente accettato di parlarne con noi.
D. Possiamo definire queste sue "lettere" un appassionato "grido di avvertimento"? Rivolto a chi, in particolare?
R. Sì, un grido d'allarme, col cuore in mano, ma anche un incoraggiamento alla speranza. Mi rivolgo soprattutto ai giovani, a quelli che ora possono avere l'impressione che il mondo non è loro, che non si può far niente per cambiarlo. Ed io dico: il mondo è di tutti, specie dei giovani; ed il mondo lo si può cambiare. Come? Lentamente cominciando a cambiare noi stessi. Le lettere sono dedicate a mio nipote Novalis, che ha due anni e mezzo, perché, quando io non ci sarò più e anche a lui toccherà scegliere, sappia che la non violenza è una vera alternativa. Le lettere sono una risposta allo sgomento, alla paura, al senso di insicurezza che ha preso tutti dopo i fatti dell'11 settembre. Io dico: questa è la buona occasione per riflettere su tutto, per rifondare il futuro, per fare un bel passo avanti nell'evoluzione. L'uomo - quello che oggi siamo - non è un prodotto definitivo, siamo un essere in via di transizione. Eravamo scimmie. Cosa saremo? Bene, usiamo della nostra coscienza per evitare di tornare ad essere scimmie tecnologiche. Abbiamo sempre più sofisticati mezzi di comunicazione (accidenti ai telefonini!), ma comunichiamo sempre di meno; abbiamo sempre più inesauribili fonti di informazione e sappiamo sempre di meno. Siamo sempre più in mezzo a tanta gente e siamo sempre più soli. Abbiamo conquistato in tantissimi sensi la natura, ma non abbiamo fatto alcun progresso noi stessi: abbiamo forse meno paura della morte? abbiamo forse meno bisogno di essere amati? No. Questo perché al progresso materiale non è andato di pari passo un progresso spirituale di questa specie chiamata umanità. Ecco secondo me dinanzi all'orrore dell'11 settembre e di quel che è seguito (e seguirà !!) abbiamo una bella occasione per fare un grande passo in avanti in questa evoluzione. Come? Rendendoci conto una volta per tutte che la violenza genera solo violenza, che la guerra non risolve i grandi problemi dell'umanità e che dobbiamo rinunciare alla violenza.
D. Durante la Grande Guerra gli inglesi riuscirono a far insorgere la nazione araba contro l'impero ottomano, promettendo varie indipendenze locali. Ne seguì quello che Lawrence d'Arabia, nei "Sette pilastri della saggezza", denunciò con durezza come un grande "tradimento" da parte inglese e occidentale in genere. Le cose sono poi proseguite in quel senso? Con sempre nuovi "tradimenti"? Quello nei confronti del variegato popolo curdo, per esempio, sempre tenuto sui margini della rivolta e mai ascoltato in seri termini politici. Sta avvenendo la stessa cosa per i diversi popoli orientali ora in profondo fermento, se non vera e propria ribellione?
R. Verissimo. E non ci sono dubbi - a mio parere - che al fondo dell'attacco contro le Torri Gemelle, al fondo dell'ideologia di Osama bin Laden c'è questo senso del "tradimento" da parte dell'Occidente. Guardiamo i fatti: nel 1979, dopo l'invasione sovietica dell'Afghanistan gli Stati Uniti finanziano e addestrano decine di migliaia di giovani di tutti il mondo mussulmano perché combattano la "guerra santa" contro l'Impero del Male, che aveva allora la sua capitale a Mosca. Una volta che la guerra è vinta, gli Stati Uniti si disinteressano di tutta quella gente che, a parte l'Afghanistan, non ha più un posto dove andare, visto che nei loro paesi, retti per lo più da regimi reazionari filo-americani, ora non sono più benvenuti. Questo è il primo "tradimento". Il secondo "tradimento" è nel fatto che gli Stati Uniti, dopo la Guerra del Golfo, non si ritirano dall'Arabia Saudita, ma lasciano basi militari e loro soldati nei luoghi sacri dell'Islam.
D. Anche Freya Stark, grande viaggiatrice e osservatrice dei costumi vicino e medio orientali, nel suo "Effendi" (East is West), scriveva già negli anni Quaranta lunghe e intense pagine sull'equazione Est = Ovest, cioè sulla ormai avvenuta (secondo lei) omologazione delle classi dirigenti di queste due aree cruciali dello scacchiere internazionale. Alla luce di quanto è avvenuto in seguito, questa equazione non sembra però reggere. Le diversità ci sono, eccome.
R. La Stark è bravissima, ma il contatto privilegiato che un viaggiatore occidentale finisce spesso per avere con chi parla l'inglese, cioè con le elite "occidentalizzate", le aveva dato una visione parziale del problema. Anch'io, forse, avessi incontrato Osama Bin Laden, o alcuni dei suoi uomini, vent'anni fa, quando avevano ancora trent'anni, avrei potuto credere di aver dinanzi dei futuri leader omologati, o omologabili. Osama nella foto di famiglia durante il viaggio nel Nord Europa non fa pensare ad Osama col Kalashnikov dinanzi alla caverna. Il fatto è che oggi nel mondo c'è un "mondo" di gente - non solo mussulmana - che non vuole essere e non vuol diventare come noi occidentali. Che fare? Bombardarli tutti fino all'estinzione? Forse meglio capire le loro ragioni e cercare un dialogo di civiltà invece che uno scontro.
D. Vi è senza dubbio una forte difficoltà per l'Ovest a capire l'Est, ma si può dire che l'Est faccia autentici sforzi per capire l'Ovest e stabilire con esso rapporti politici veramente dialettici o, se vogliamo, interattivi? Insomma: davvero le colpe risiedono soltanto da una parte?
R. Non è una questione di "colpa", e questa stessa idea di voler che gli altri siano come noi - in questo caso che facciano uno sforzo per capire noi come noi diciamo di farne uno per capire loro - è tipica dell'atteggiamento occidentale. In fondo ci sentiremmo più sicuri e tranquilli se tutti fossero come noi. Il fatto è che questo non sarà mai possibile, e voler fare di tutti UNO è assurdo come l'uomo che voleva eliminare la sua ombra. Il bello del mondo, la sua armonia, sta nell'unità delle diversità non nell'appiattimento di tutto. Il nostro problema è trovare quell'unità e goderne.
D. Con "rapporti politici veramente dialettici" intendevo appunto l'impegno a realizzare una vera parità delle culture, da cui far emergere una sintesi politica positiva per tutta l'umanità. Un altro autore di una zona che conosco molto bene - per esempio —, il turco Orhan Pamuk, continua nei suoi romanzi a elevare vibranti e accorate accuse all'invadenza della cultura occidentale nei confronti se non altro di quella turca. Non mi sembra peraltro che la classe dirigente di quel paese faccia grandi sforzi, non soltanto per resistere a una simile penetrazione ma nemmeno, come dicevo sopra, per reagire in maniera dialettica. E lo stesso temo accada per alcune classi dirigenti dei paesi vicino e medio orientali. C'è forse troppa furbizia, da entrambe le parti.
R. Non conosco l'autore turco di cui lei parla, ma essendo vissuto in Asia per 30 anni, conosco il dramma di tutte le grandi, vecchie culture di quel mondo una volta che han dovuto affrontare non solo l'invadenza culturale dell'occidente a cui fa riferimento lei, ma il colonialismo e l'imperialismo occidentale. Ridurre questa storia di aggressione e di violenza da parte dell'occidente e le reazioni rivoluzionarie (Mao Tse-tung, Ho Chi Minh) o meno delle classi dirigenti degli aggrediti ad una questione di "furbizia", mi pare troppo semplice.
D. Le rivoluzioni sono eventi catartici che non possono in nessun modo essere definiti "furbizia", ma le classi dirigenti dei paesi "culturalmente" aggrediti non mi pare che rispondano sempre con la necessaria fermezza e anche durezza (senza arrivare alla "rivoluzione"), ma spesso con la furbizia (il vantaggio personale) dell'accomodamento. Quelli che rimangono in ogni caso tagliati fuori sono i popoli, la gente comune, sempre chiamata a pagare le spese delle decisioni prese sopra la sua testa, con prezzi che ai nostri presunti "occhi civili" dovrebbero comunque apparire inaccettabili.
R. Sì. Anche in guerra ormai sono sempre più i civili a morire.
D. La domanda può apparire semplicistica e forse senza risposta, ma: "Che fare?"
R. È una domanda sacrosanta, e non a caso ho intitolato proprio così la mia ultima lettera, quella che ho scritto dal mio rifugio nell'Himalaya, dove sono tornato per qualche giorno a cercare di mettere ordine "dall'alto" a quel che avevo visto viaggiando per due mesi lungo la frontiera fra Pakistan ed Afghanistan e poi passando tre settimane a Kabul. La domanda me la sono posta, e credo, a mio modo, di aver risposto. Ho indicato "il cammino" da fare, e fatto un grande augurio, a me stesso ed a chi mi leggerà: Buon Viaggio, sia fuori... che dentro.
3.
Cinque anni di vita a Firenze nei Settanta del Novecento, e mai che in giro per il mondo io — accanito viaggiatore automobilistico in quegli anni — incontrassi un'auto targata FI. Tantissime TO, dal cuore del Sahara ai confini dell'Iran al Golfo di Aqaba, un'infinità di MO - BO, ovunque. Ma FI mai. Con gli anni sarei arrivato a capire che la frenesia di viaggio su quattro ruote di torinesi ed emiliani era dovuta a passione per i motori mista a concretezza industriale: Fiat, Lancia, Pininfarina, Abarth, Ferrari, Maserati, Lamborghini… Se non viaggiavano in auto loro, che di auto in larga misura vivevano…
Mi sembrava dunque che i fiorentini fossero la negazione del viaggio, e li prendevo in giro dicendo che il loro mondo confinava con l'Elba e l'Abetone. E loro si infastidivano. Ma a alla fine ho dovuto ammettere che avevo torto, se è vero che i due più importanti autori italiani recenti di cronache giornalistiche da paesi e popoli lontani sono venuti entrambi da Firenze: Oriana Fallaci e Tiziano Terzani.
Considerazioni che mi tornano attuali adesso, davanti al nuovo libro di Terzani, Un mondo che non esiste più, una composizione di sue foto e suoi testi montata dal figlio Folco, a cui il padre aveva affidato le immagini, non avendo avuto tempo di occuparsene in modo organico, con l'esortazione: "se hai voglia un giorno lo puoi fare tu". Folco ha avuto voglia e lo ha fatto molto bene, aggiungendovi una nota conclusiva ricca di commozione.
Alcune di queste foto (o loro immediate parenti) ho avuto la fortuna di vederle in quei primi anni Settanta a Firenze: ne era depositario un comune amico, Paolo Pecile, che ce le mostrava pieno di orgoglio per l'amicizia e la fiducia accordatagli da questo non ancora quarantenne che stava emergendo di prepotenza a livello internazionale come uno dei più spavaldi e informati (di più: "curiosi", "ansiosi di indagare") corrispondenti giornalistici da "teatri "caldi (di più: "roventi") a partire dal Vietnam di tutta la contestazione giovanile.
Strumenti di essenziale importanza, le foto, per chi viaggia e poi deve per professione (o anche soltanto vuole per passione) raccontare ciò che ha visto. Appunti, scarabocchiati su taccuini; gracchianti annotazioni o riflessioni a voce, frettolosamente affidate a registratori portatili: tutto bene, ma se vuoi rievocare fino in fondo "la cosa vera" non puoi fare a meno delle foto: tutto l'universo di un istante, fatto di dettagli che possono anche essere fondamentali nella loro infinitesima piccolezza, racchiuso in un'immagine in cui puoi scavare sempre più a fondo, ingrandendo, ingrandendo, ingrandendo fino ai limiti del possibile. Un tempo in bianco e nero, poi in un autentico festival di colori. Non so come facciano certi autori di viaggio a dichiarare programmaticamente che loro "non fanno foto". Come fanno a ricordarsi tutto fino in fondo? Mah.
Ecco, allora, in Un mondo che non esiste più, dipanarsi ancora una volta con sfaccettature e angolazioni diverse la straordinaria esperienza di vita (professionale ma soprattutto personale) di Tiziano Terzani, dal Vietnam appunto al suo ultimo rifugio celato nell'Himalaya indiano, attraverso tantissima Cina, tanto Giappone, l'India, la Russia più lontana, e Thailandia e Cambogia, con tenerissime pagine riservate a luoghi remoti ancora adesso non semplici da percorrere come il Tibet, o assai difficili da raggiungere come il nepalese-tibetano Mustang.
Non sempre sono d'accordo con le sue letture di luoghi, eventi e situazioni storico-politiche. Vedi, per esempio, in Un mondo che non esiste più, lo struggente interrogativo su che cosa fare per il tracoma dei bambini nel Mustang nepalese (e per altro in tutte le zone di etnia tibetana): lo provoca il pungente fumo dello sterco degli yak usato per generare fuoco e luce nelle tende e capanne dei nomadi. È un interrogativo drammatico, che non può essere lasciato sospeso nel dubbio ma deve essere vinto con un formidabile impegno politico, sociale e culturale di progresso: portare a tappe forzate la corrente elettrica a quelle genti dimenticate.
Una volta avemmo anche un minimo attrito perché in un'intervista per questo portale avevo confrontato una sua analisi del rapporto Occidente - Oriente con quella di un giovane scrittore "vicino-orientale" che io conoscevo bene e lui — "estremo-orientalista" — no. In effetti Orhan Pamuk era ancora quasi sconosciuto, ma lo aspettava il Premio Nobel, dopo di che tutti si sarebbero sperticati con il senno di poi ad "avere scoperto da tempo" la sua scrittura e le sue opinioni appunto sul rapporto Occidente - Oriente.
D'altra parte la polemica — suscitarla, rintuzzarla e animarla — era uno dei pigmenti del carattere di Tiziano Terzani. Fa molta tenerezza, in chiusura di libro, vederlo così pacioso al termine della vita, ritratto lassù nel suo eremo himalayano, con un computerino alimentato da un minuscolo pannello solare. Ce ne sono a decine, da quelle parti, posati per terra davanti alle tende dei pastori nomadi: li usano per scaldare l'acqua del tè, che per loro è l'essenza del nutrimento e quindi della vita, e per ridurre almeno un po' il consumo del famigerato sterco di yak. A Terzani il pannellino solare serviva per qualcosa di altrettanto personalmente vitale: lasciarci gli ultimi segni del suo passaggio.
Tiziano Terzani, “Lettere contro la guerra”, Longanesi
Tiziano Terzani, “Un mondo che non esiste più”, Longanesi
Aveva visto (e scritto di) cose assai diverse da quelle che in superficie appaiono all'incantato viaggiatore accompagnato in Cina dalle agenzie turistiche. Aveva scritto delle immense contraddizioni del socialismo cinese, dal primo Mao, attraverso la cosiddetta Banda dei Quattro, fino al nuovo corso di Deng Xiaoping; degli irreparabili guasti provocati dalla Rivoluzione Culturale; dell'apparente (e tacitamente accettato) sopravvento ripreso dal "capitalismo" in certe zone di confine; della situazione delle minoranze - uighur, kazak, tibetani - in altre zone di confine. Aveva visto splendidi tesori della multimillenaria storia e cultura cinese distrutti in nome di un "nuovo" spesso colpevole di edificare pletoriche e inutili cattedrali nel deserto.
Aveva percorso il paese servendosi di tutti i mezzi possibìli, non ultima la bicicletta, per uscire dagli itinerari canonici e parlare sul serio con la gente. Aveva, per tre anni, mandato i propri figli in una scuola cinese. Aveva voluto vivere da "cinese" per arrivare, tuttavia, a sentirsi veramente cinese soltanto negli ultimi giorni di permanenza in Cina, quelli dell’arresto, del confronto con la polizia, dell'autocritica scritta a comando. Ricco di notizie e dati, di considerazioni e umori, questo libro in cui Tiziano Terzani — in Cina, Deng Tiennuo — racconta la propria esperienza cinese è al tempo stesso un reportage giornalistico, una cronaca di viaggio, un trattato di sinologia contemporanea l’appassionato romanzo di un’avventura umana.
2
L'11 settembre del 2002 è una data che rimarrà incisa a caratteri di sangue negli annali di questo primo secolo del Terzo Millennio, come altre date lo sono negli annali di altri secoli. Tiziano Terzani, che ormai vive abitualmente in Asia dove passa "gran parte del tempo nell'Himalaya", era in Italia, ha visto come tutti noi i terribili eventi alla televisione, ha provato l'insopprimibile impulso a scrivere una "lettera" su quegli eventi, da rivolgere al più ampio pubblico possibile attraverso il grande quotidiano italiano a cui collabora. Pochi giorni dopo era già ai confini del Pakistan con l'Afghanistan, nel febbrile tentativo di capire il "perché" di quanto avvenuto, le ragioni degli uni e quelle degli altri. Da lì è riuscito a entrare in Afghanistan, a raggiungere Kabul e a muoversi per il martoriato paese con tutti gli scarsissimi mezzi possibili, non ultima la bicicletta. Di nuovo, per vedere, per capire. Ne sono nate altre "lettere", da Peshawar, da Quetta, dalla stessa Kabul, da Delhi, dal suo rifugio sull'Himalaya. Per cercare di far "vedere" agli altri attraverso le sue parole, di aiutare a capire. Ne è nato Lettere contro la guerra. Terzani è di nuovo in Italia per l'uscita del libro e ha cortesemente accettato di parlarne con noi.
D. Possiamo definire queste sue "lettere" un appassionato "grido di avvertimento"? Rivolto a chi, in particolare?
R. Sì, un grido d'allarme, col cuore in mano, ma anche un incoraggiamento alla speranza. Mi rivolgo soprattutto ai giovani, a quelli che ora possono avere l'impressione che il mondo non è loro, che non si può far niente per cambiarlo. Ed io dico: il mondo è di tutti, specie dei giovani; ed il mondo lo si può cambiare. Come? Lentamente cominciando a cambiare noi stessi. Le lettere sono dedicate a mio nipote Novalis, che ha due anni e mezzo, perché, quando io non ci sarò più e anche a lui toccherà scegliere, sappia che la non violenza è una vera alternativa. Le lettere sono una risposta allo sgomento, alla paura, al senso di insicurezza che ha preso tutti dopo i fatti dell'11 settembre. Io dico: questa è la buona occasione per riflettere su tutto, per rifondare il futuro, per fare un bel passo avanti nell'evoluzione. L'uomo - quello che oggi siamo - non è un prodotto definitivo, siamo un essere in via di transizione. Eravamo scimmie. Cosa saremo? Bene, usiamo della nostra coscienza per evitare di tornare ad essere scimmie tecnologiche. Abbiamo sempre più sofisticati mezzi di comunicazione (accidenti ai telefonini!), ma comunichiamo sempre di meno; abbiamo sempre più inesauribili fonti di informazione e sappiamo sempre di meno. Siamo sempre più in mezzo a tanta gente e siamo sempre più soli. Abbiamo conquistato in tantissimi sensi la natura, ma non abbiamo fatto alcun progresso noi stessi: abbiamo forse meno paura della morte? abbiamo forse meno bisogno di essere amati? No. Questo perché al progresso materiale non è andato di pari passo un progresso spirituale di questa specie chiamata umanità. Ecco secondo me dinanzi all'orrore dell'11 settembre e di quel che è seguito (e seguirà !!) abbiamo una bella occasione per fare un grande passo in avanti in questa evoluzione. Come? Rendendoci conto una volta per tutte che la violenza genera solo violenza, che la guerra non risolve i grandi problemi dell'umanità e che dobbiamo rinunciare alla violenza.
D. Durante la Grande Guerra gli inglesi riuscirono a far insorgere la nazione araba contro l'impero ottomano, promettendo varie indipendenze locali. Ne seguì quello che Lawrence d'Arabia, nei "Sette pilastri della saggezza", denunciò con durezza come un grande "tradimento" da parte inglese e occidentale in genere. Le cose sono poi proseguite in quel senso? Con sempre nuovi "tradimenti"? Quello nei confronti del variegato popolo curdo, per esempio, sempre tenuto sui margini della rivolta e mai ascoltato in seri termini politici. Sta avvenendo la stessa cosa per i diversi popoli orientali ora in profondo fermento, se non vera e propria ribellione?
R. Verissimo. E non ci sono dubbi - a mio parere - che al fondo dell'attacco contro le Torri Gemelle, al fondo dell'ideologia di Osama bin Laden c'è questo senso del "tradimento" da parte dell'Occidente. Guardiamo i fatti: nel 1979, dopo l'invasione sovietica dell'Afghanistan gli Stati Uniti finanziano e addestrano decine di migliaia di giovani di tutti il mondo mussulmano perché combattano la "guerra santa" contro l'Impero del Male, che aveva allora la sua capitale a Mosca. Una volta che la guerra è vinta, gli Stati Uniti si disinteressano di tutta quella gente che, a parte l'Afghanistan, non ha più un posto dove andare, visto che nei loro paesi, retti per lo più da regimi reazionari filo-americani, ora non sono più benvenuti. Questo è il primo "tradimento". Il secondo "tradimento" è nel fatto che gli Stati Uniti, dopo la Guerra del Golfo, non si ritirano dall'Arabia Saudita, ma lasciano basi militari e loro soldati nei luoghi sacri dell'Islam.
D. Anche Freya Stark, grande viaggiatrice e osservatrice dei costumi vicino e medio orientali, nel suo "Effendi" (East is West), scriveva già negli anni Quaranta lunghe e intense pagine sull'equazione Est = Ovest, cioè sulla ormai avvenuta (secondo lei) omologazione delle classi dirigenti di queste due aree cruciali dello scacchiere internazionale. Alla luce di quanto è avvenuto in seguito, questa equazione non sembra però reggere. Le diversità ci sono, eccome.
R. La Stark è bravissima, ma il contatto privilegiato che un viaggiatore occidentale finisce spesso per avere con chi parla l'inglese, cioè con le elite "occidentalizzate", le aveva dato una visione parziale del problema. Anch'io, forse, avessi incontrato Osama Bin Laden, o alcuni dei suoi uomini, vent'anni fa, quando avevano ancora trent'anni, avrei potuto credere di aver dinanzi dei futuri leader omologati, o omologabili. Osama nella foto di famiglia durante il viaggio nel Nord Europa non fa pensare ad Osama col Kalashnikov dinanzi alla caverna. Il fatto è che oggi nel mondo c'è un "mondo" di gente - non solo mussulmana - che non vuole essere e non vuol diventare come noi occidentali. Che fare? Bombardarli tutti fino all'estinzione? Forse meglio capire le loro ragioni e cercare un dialogo di civiltà invece che uno scontro.
D. Vi è senza dubbio una forte difficoltà per l'Ovest a capire l'Est, ma si può dire che l'Est faccia autentici sforzi per capire l'Ovest e stabilire con esso rapporti politici veramente dialettici o, se vogliamo, interattivi? Insomma: davvero le colpe risiedono soltanto da una parte?
R. Non è una questione di "colpa", e questa stessa idea di voler che gli altri siano come noi - in questo caso che facciano uno sforzo per capire noi come noi diciamo di farne uno per capire loro - è tipica dell'atteggiamento occidentale. In fondo ci sentiremmo più sicuri e tranquilli se tutti fossero come noi. Il fatto è che questo non sarà mai possibile, e voler fare di tutti UNO è assurdo come l'uomo che voleva eliminare la sua ombra. Il bello del mondo, la sua armonia, sta nell'unità delle diversità non nell'appiattimento di tutto. Il nostro problema è trovare quell'unità e goderne.
D. Con "rapporti politici veramente dialettici" intendevo appunto l'impegno a realizzare una vera parità delle culture, da cui far emergere una sintesi politica positiva per tutta l'umanità. Un altro autore di una zona che conosco molto bene - per esempio —, il turco Orhan Pamuk, continua nei suoi romanzi a elevare vibranti e accorate accuse all'invadenza della cultura occidentale nei confronti se non altro di quella turca. Non mi sembra peraltro che la classe dirigente di quel paese faccia grandi sforzi, non soltanto per resistere a una simile penetrazione ma nemmeno, come dicevo sopra, per reagire in maniera dialettica. E lo stesso temo accada per alcune classi dirigenti dei paesi vicino e medio orientali. C'è forse troppa furbizia, da entrambe le parti.
R. Non conosco l'autore turco di cui lei parla, ma essendo vissuto in Asia per 30 anni, conosco il dramma di tutte le grandi, vecchie culture di quel mondo una volta che han dovuto affrontare non solo l'invadenza culturale dell'occidente a cui fa riferimento lei, ma il colonialismo e l'imperialismo occidentale. Ridurre questa storia di aggressione e di violenza da parte dell'occidente e le reazioni rivoluzionarie (Mao Tse-tung, Ho Chi Minh) o meno delle classi dirigenti degli aggrediti ad una questione di "furbizia", mi pare troppo semplice.
D. Le rivoluzioni sono eventi catartici che non possono in nessun modo essere definiti "furbizia", ma le classi dirigenti dei paesi "culturalmente" aggrediti non mi pare che rispondano sempre con la necessaria fermezza e anche durezza (senza arrivare alla "rivoluzione"), ma spesso con la furbizia (il vantaggio personale) dell'accomodamento. Quelli che rimangono in ogni caso tagliati fuori sono i popoli, la gente comune, sempre chiamata a pagare le spese delle decisioni prese sopra la sua testa, con prezzi che ai nostri presunti "occhi civili" dovrebbero comunque apparire inaccettabili.
R. Sì. Anche in guerra ormai sono sempre più i civili a morire.
D. La domanda può apparire semplicistica e forse senza risposta, ma: "Che fare?"
R. È una domanda sacrosanta, e non a caso ho intitolato proprio così la mia ultima lettera, quella che ho scritto dal mio rifugio nell'Himalaya, dove sono tornato per qualche giorno a cercare di mettere ordine "dall'alto" a quel che avevo visto viaggiando per due mesi lungo la frontiera fra Pakistan ed Afghanistan e poi passando tre settimane a Kabul. La domanda me la sono posta, e credo, a mio modo, di aver risposto. Ho indicato "il cammino" da fare, e fatto un grande augurio, a me stesso ed a chi mi leggerà: Buon Viaggio, sia fuori... che dentro.
3.
Cinque anni di vita a Firenze nei Settanta del Novecento, e mai che in giro per il mondo io — accanito viaggiatore automobilistico in quegli anni — incontrassi un'auto targata FI. Tantissime TO, dal cuore del Sahara ai confini dell'Iran al Golfo di Aqaba, un'infinità di MO - BO, ovunque. Ma FI mai. Con gli anni sarei arrivato a capire che la frenesia di viaggio su quattro ruote di torinesi ed emiliani era dovuta a passione per i motori mista a concretezza industriale: Fiat, Lancia, Pininfarina, Abarth, Ferrari, Maserati, Lamborghini… Se non viaggiavano in auto loro, che di auto in larga misura vivevano…
Mi sembrava dunque che i fiorentini fossero la negazione del viaggio, e li prendevo in giro dicendo che il loro mondo confinava con l'Elba e l'Abetone. E loro si infastidivano. Ma a alla fine ho dovuto ammettere che avevo torto, se è vero che i due più importanti autori italiani recenti di cronache giornalistiche da paesi e popoli lontani sono venuti entrambi da Firenze: Oriana Fallaci e Tiziano Terzani.
Considerazioni che mi tornano attuali adesso, davanti al nuovo libro di Terzani, Un mondo che non esiste più, una composizione di sue foto e suoi testi montata dal figlio Folco, a cui il padre aveva affidato le immagini, non avendo avuto tempo di occuparsene in modo organico, con l'esortazione: "se hai voglia un giorno lo puoi fare tu". Folco ha avuto voglia e lo ha fatto molto bene, aggiungendovi una nota conclusiva ricca di commozione.
Alcune di queste foto (o loro immediate parenti) ho avuto la fortuna di vederle in quei primi anni Settanta a Firenze: ne era depositario un comune amico, Paolo Pecile, che ce le mostrava pieno di orgoglio per l'amicizia e la fiducia accordatagli da questo non ancora quarantenne che stava emergendo di prepotenza a livello internazionale come uno dei più spavaldi e informati (di più: "curiosi", "ansiosi di indagare") corrispondenti giornalistici da "teatri "caldi (di più: "roventi") a partire dal Vietnam di tutta la contestazione giovanile.
Strumenti di essenziale importanza, le foto, per chi viaggia e poi deve per professione (o anche soltanto vuole per passione) raccontare ciò che ha visto. Appunti, scarabocchiati su taccuini; gracchianti annotazioni o riflessioni a voce, frettolosamente affidate a registratori portatili: tutto bene, ma se vuoi rievocare fino in fondo "la cosa vera" non puoi fare a meno delle foto: tutto l'universo di un istante, fatto di dettagli che possono anche essere fondamentali nella loro infinitesima piccolezza, racchiuso in un'immagine in cui puoi scavare sempre più a fondo, ingrandendo, ingrandendo, ingrandendo fino ai limiti del possibile. Un tempo in bianco e nero, poi in un autentico festival di colori. Non so come facciano certi autori di viaggio a dichiarare programmaticamente che loro "non fanno foto". Come fanno a ricordarsi tutto fino in fondo? Mah.
Ecco, allora, in Un mondo che non esiste più, dipanarsi ancora una volta con sfaccettature e angolazioni diverse la straordinaria esperienza di vita (professionale ma soprattutto personale) di Tiziano Terzani, dal Vietnam appunto al suo ultimo rifugio celato nell'Himalaya indiano, attraverso tantissima Cina, tanto Giappone, l'India, la Russia più lontana, e Thailandia e Cambogia, con tenerissime pagine riservate a luoghi remoti ancora adesso non semplici da percorrere come il Tibet, o assai difficili da raggiungere come il nepalese-tibetano Mustang.
Non sempre sono d'accordo con le sue letture di luoghi, eventi e situazioni storico-politiche. Vedi, per esempio, in Un mondo che non esiste più, lo struggente interrogativo su che cosa fare per il tracoma dei bambini nel Mustang nepalese (e per altro in tutte le zone di etnia tibetana): lo provoca il pungente fumo dello sterco degli yak usato per generare fuoco e luce nelle tende e capanne dei nomadi. È un interrogativo drammatico, che non può essere lasciato sospeso nel dubbio ma deve essere vinto con un formidabile impegno politico, sociale e culturale di progresso: portare a tappe forzate la corrente elettrica a quelle genti dimenticate.
Una volta avemmo anche un minimo attrito perché in un'intervista per questo portale avevo confrontato una sua analisi del rapporto Occidente - Oriente con quella di un giovane scrittore "vicino-orientale" che io conoscevo bene e lui — "estremo-orientalista" — no. In effetti Orhan Pamuk era ancora quasi sconosciuto, ma lo aspettava il Premio Nobel, dopo di che tutti si sarebbero sperticati con il senno di poi ad "avere scoperto da tempo" la sua scrittura e le sue opinioni appunto sul rapporto Occidente - Oriente.
D'altra parte la polemica — suscitarla, rintuzzarla e animarla — era uno dei pigmenti del carattere di Tiziano Terzani. Fa molta tenerezza, in chiusura di libro, vederlo così pacioso al termine della vita, ritratto lassù nel suo eremo himalayano, con un computerino alimentato da un minuscolo pannello solare. Ce ne sono a decine, da quelle parti, posati per terra davanti alle tende dei pastori nomadi: li usano per scaldare l'acqua del tè, che per loro è l'essenza del nutrimento e quindi della vita, e per ridurre almeno un po' il consumo del famigerato sterco di yak. A Terzani il pannellino solare serviva per qualcosa di altrettanto personalmente vitale: lasciarci gli ultimi segni del suo passaggio.
Tiziano Terzani, “Lettere contro la guerra”, Longanesi
Tiziano Terzani, “Un mondo che non esiste più”, Longanesi