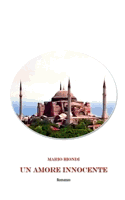Scrive di: Renata Pisu
Intervista su “Mille anni a Pechino” (2008)
Intervista su “Mille anni a Pechino” (2008)
© Mario Biondi
Divieto di riproduzione integrale
e obbligo di citazione (per cortesia...)
Renata Pisu è stata probabilmente una dei primi italiani a vedere la Pechino divenuta capitale della Repubblica Popolare Cinese, certamente una dei primi a raccontarcela. La vide per la prima volta nel 1957, quando vi andò per studiare all'università e incontravi personaggi destinati alla leggenda: uno fra tutti, Ernesto Che Guevara, arrivatovi per una visita esplorativa al Grande Timoniere Mao Zedong. Da allora vi è andata e tornata tante volte, risiedendovi per lunghi periodi, via via in veste di studentessa, di sinologa, di studiosa, di giornalista, di amica. Ed è la sua Pechino quella che ci racconta ancora una volta in Mille anni a Pechino, la Pechino di allora e quella di oggi, dei vecchi quartieri popolari e dei grattacieli postmoderni, del popolino paziente di un tempo, persino forse un po' pigro, e della nuova borghesia ultra rampante, delle bottegucce all'angolo e dei centri commerciali nel grattacielo. Il direttore di infinite Storie, Mario Biondi, a sua volta appassionato frequentatore di Pechino, sia pure da una data molto più recente, ne ha parlato con lei.
Mario Biondi: Perché Mille anni a Pechino? La città non ha un millennio.
Renata Pisu: No, certo, fu fatta costruire nel XIII secolo dal mongolo Kublai Khan come capitale per la dinastia imperiale della Cina da lui fondata, i conquistatori Yuan scesi dalle steppe del nord. Si chiamava Cambaluc — ovvero Khanbaliq (la citta del Khan) —, come la chiamava Marco Polo, che la visitò allora e vi abitò per tanti anni. Ma il mio Mille anni a Pechino non vuole significare un lasso temporale, è una formula che credo non sia propria soltanto dei cinesi: significa "Lunga vita a Pechino", "Evviva Pechino".
M. B. Ah, è vero, la usavano anche i turchi ottomani (che dei cinesi sono cugini alla lontana) come formula augurale per i loro sultani. Possiamo dunque dire che questo libro-augurio è una lettera, un atto, un canto d'amore per Pechino?
R. P. Possiamo anche chiamarlo così, ma con un distinguo fondamentale. È un canto per un amore un po' perduto, un addio alla Pechino che ho conosciuto tanti anni fa e che purtroppo non esiste più. Addio, Pechino: sorgevi in una pianura limpida e adesso sei avvolta dallo smog. Al punto che i Giochi olimpici potrebbero essere a rischio. Nell'immediata periferia sorgono le acciaierie. E il traffico automobilistico continua a crescere a un ritmo vertiginoso. È passato da due a quattro milioni di automezzi in soli cinque anni, mentre per arrivare a un milione ce ne aveva messi trenta. Il mio augurio di Mille anni è rivolto a quella città lì.
M. B. E com'era quella città?
R. P. Nel mio ricordo può sembrare un luogo idilliaco, anche se poi, rimettendo bene a fuoco il tutto, mi rendo conto benissimo che non era così. Ma il mio libro non riguarda soltanto la città in sé, riguarda la gente che vi viveva, le storie che vi ho visto vivere e ho vissuto io stessa. Quando vi sono arrivata, conservava tutti i caratteri tipici della città tradizionale e feudale cinese, diversamente da Shanghai, che per la sua storia, quasi per i suoi cromosomi, è sempre stata più proiettata verso l'Europa, anzi, quasi un pezzo d'Europa. Per carità, le trasformazioni sono avvenute ovunque, ma quello che colpisce in Pechino è la velocità con cui si sono verificate. Ciò che altrove ci ha messo almeno cent'anni, a Pechino è successo in una trentina.
M. B. Qual era la cosa più straordinaria di quella Pechino?
R. P. Uno dei ricordi più vivi del tempo che fu sono proprio i suoi cieli limpidi, la luna. Ma, soprattutto, noi che venivamo da città occidentali, quindi moderne, ci siamo trovati catapultati di colpo in un luogo cinese antico, non un luogo della rivoluzione di Mao, non un luogo delle dinastie imperiali: la Pechino di sempre. Si viaggiava su autobus traballanti, ma soprattutto con i "san lun che", i risciò a pedali. E le biciclette...
M. B. Anch'io le ho viste quasi scomparire nel giro di pochissimi anni.
R. P. Un disastro dal punto di vista ecologico, anche se, certo, se dicessimo ai pechinesi, dopo che hanno fatto tanta fatica per avere l'automobile, di tornare ad andare in bici, ci risponderebbero senz'altro: andateci voi.
M. B. E la cosa più spiacevole della Pechino di oggi?
R. P. Se non spiacevole, per lo meno frastornante è il fatto che non ci sono più confronti. Fra una trentina di anni, chissà, i giovani di oggi vi troveranno un nuovo equilibrio, con nuove coordinate, ma adesso c'è soltanto una grande frattura con un passato che non esiste più. Gli stessi pechinesi faticano a ritrovarcisi: voglio andare là, nella tale strada, quindi devo passare di lì. Ma questo "lì" non esiste più. Interi quartieri popolari, gli "hutong", sono stati letteralmente cancellati dalle ruspe.
M. B. Però erano vere e proprie bombe ecologiche, di malasanità, con quella terribile carenza di igiene, tutti quei gabinetti pubblici di quartiere, pesantemente avvertibili già da lontano, anche senza vederli...
R. P. Sì, ma si poteva sventrare un po' meno e risanare un po' di più. Invece la logica del profitto immobiliare è quasi sempre prevalsa. Non c'è stata una coscienza urbanistica, ma un semplice dilagare di shopping center e grattacieli. Gli antichi templi, che nonostante tutto erano sopravvissuti ai tempi di Mao, adesso sono semplicemente scomparsi.
M. B. Però, se uno è arrivato per la prima volta a Pechino nei primi anni Duemila, come me, non può non trovarla tuttora una città straordinaria.
R. P. Ma è un'altra cosa, completamente diversa, senza riferimenti con il prima. Era una città per così dire "nana", tutta di edifici bassi, a un piano, e di botto si è convertita in una selva di grattacieli. Simboli di quella potenza nuovissima, di quel contraltare agli USA che il potere cinese aspira a diventare. Racconto in Mille anni a Pechino la reazione sbalordita di una delegazione cinese che ho accompagnato a visitare Lucca. «Ma che cosa ve ne fate di tutto questo vecchiume? Buttatelo giù.» Al cinese non viene in mente di andare a vedere le "cose vecchie": è passato di colpo dall'immobilismo al turismo frenetico di massa, con tutti i suoi surrogati di Disneyland.
M. B. Sì, cose tremende, sparse ovunque. Si scia sulle dune del deserto, si scorrazza all'impazzata in jeep tra enormi castelli di sabbia, se non addirittura tra finte piramidi e sfingi, a quattro passi dall'Esercito di Terracotta di Xi'an. Ma a Pechino non mi pare che ci sa roba del genere: si rema romanticamente sui laghetti, si balla il liscio sotto le piante, si fa ginnastica nei parchi, si canta in coro. Tutte cose ingenuamente naturali che a me piacciono molto. E per le quali loro vanno pazzi.
R. P. Ne vanno pazzi, certo, si divertono moltissimo perché stanno uscendo contemporaneamente dal grigiore puritano del comunismo e dalle durezze del feudalesimo. Ma una coscienza del viaggio come arricchimento culturale è ancora di là da venire.
M. B. Forse però non nei giovani, che sono meno ingenui, più informati, più colti. Io ne ho incontrati tanti in puntigliosa, quasi religiosa ricerca dei loro luoghi storici, per esempio le tante, bellissime Grotte dei Buddha che ci sono su tutta la Via della Seta. Sapevano benissimo dove stavano andando e che cosa stavano cercando.
R. P. Be', certo, sono quei giovani di cui parlavo prima, quelli che troveranno il nuovo equilibrio. Speriamo che lo trovino davvero. Mille anni anche a loro.
Renata Pisu, “Mille anni a Pechino”, Sperling & Kupfer
Mario Biondi: Perché Mille anni a Pechino? La città non ha un millennio.
Renata Pisu: No, certo, fu fatta costruire nel XIII secolo dal mongolo Kublai Khan come capitale per la dinastia imperiale della Cina da lui fondata, i conquistatori Yuan scesi dalle steppe del nord. Si chiamava Cambaluc — ovvero Khanbaliq (la citta del Khan) —, come la chiamava Marco Polo, che la visitò allora e vi abitò per tanti anni. Ma il mio Mille anni a Pechino non vuole significare un lasso temporale, è una formula che credo non sia propria soltanto dei cinesi: significa "Lunga vita a Pechino", "Evviva Pechino".
M. B. Ah, è vero, la usavano anche i turchi ottomani (che dei cinesi sono cugini alla lontana) come formula augurale per i loro sultani. Possiamo dunque dire che questo libro-augurio è una lettera, un atto, un canto d'amore per Pechino?
R. P. Possiamo anche chiamarlo così, ma con un distinguo fondamentale. È un canto per un amore un po' perduto, un addio alla Pechino che ho conosciuto tanti anni fa e che purtroppo non esiste più. Addio, Pechino: sorgevi in una pianura limpida e adesso sei avvolta dallo smog. Al punto che i Giochi olimpici potrebbero essere a rischio. Nell'immediata periferia sorgono le acciaierie. E il traffico automobilistico continua a crescere a un ritmo vertiginoso. È passato da due a quattro milioni di automezzi in soli cinque anni, mentre per arrivare a un milione ce ne aveva messi trenta. Il mio augurio di Mille anni è rivolto a quella città lì.
M. B. E com'era quella città?
R. P. Nel mio ricordo può sembrare un luogo idilliaco, anche se poi, rimettendo bene a fuoco il tutto, mi rendo conto benissimo che non era così. Ma il mio libro non riguarda soltanto la città in sé, riguarda la gente che vi viveva, le storie che vi ho visto vivere e ho vissuto io stessa. Quando vi sono arrivata, conservava tutti i caratteri tipici della città tradizionale e feudale cinese, diversamente da Shanghai, che per la sua storia, quasi per i suoi cromosomi, è sempre stata più proiettata verso l'Europa, anzi, quasi un pezzo d'Europa. Per carità, le trasformazioni sono avvenute ovunque, ma quello che colpisce in Pechino è la velocità con cui si sono verificate. Ciò che altrove ci ha messo almeno cent'anni, a Pechino è successo in una trentina.
M. B. Qual era la cosa più straordinaria di quella Pechino?
R. P. Uno dei ricordi più vivi del tempo che fu sono proprio i suoi cieli limpidi, la luna. Ma, soprattutto, noi che venivamo da città occidentali, quindi moderne, ci siamo trovati catapultati di colpo in un luogo cinese antico, non un luogo della rivoluzione di Mao, non un luogo delle dinastie imperiali: la Pechino di sempre. Si viaggiava su autobus traballanti, ma soprattutto con i "san lun che", i risciò a pedali. E le biciclette...
M. B. Anch'io le ho viste quasi scomparire nel giro di pochissimi anni.
R. P. Un disastro dal punto di vista ecologico, anche se, certo, se dicessimo ai pechinesi, dopo che hanno fatto tanta fatica per avere l'automobile, di tornare ad andare in bici, ci risponderebbero senz'altro: andateci voi.
M. B. E la cosa più spiacevole della Pechino di oggi?
R. P. Se non spiacevole, per lo meno frastornante è il fatto che non ci sono più confronti. Fra una trentina di anni, chissà, i giovani di oggi vi troveranno un nuovo equilibrio, con nuove coordinate, ma adesso c'è soltanto una grande frattura con un passato che non esiste più. Gli stessi pechinesi faticano a ritrovarcisi: voglio andare là, nella tale strada, quindi devo passare di lì. Ma questo "lì" non esiste più. Interi quartieri popolari, gli "hutong", sono stati letteralmente cancellati dalle ruspe.
M. B. Però erano vere e proprie bombe ecologiche, di malasanità, con quella terribile carenza di igiene, tutti quei gabinetti pubblici di quartiere, pesantemente avvertibili già da lontano, anche senza vederli...
R. P. Sì, ma si poteva sventrare un po' meno e risanare un po' di più. Invece la logica del profitto immobiliare è quasi sempre prevalsa. Non c'è stata una coscienza urbanistica, ma un semplice dilagare di shopping center e grattacieli. Gli antichi templi, che nonostante tutto erano sopravvissuti ai tempi di Mao, adesso sono semplicemente scomparsi.
M. B. Però, se uno è arrivato per la prima volta a Pechino nei primi anni Duemila, come me, non può non trovarla tuttora una città straordinaria.
R. P. Ma è un'altra cosa, completamente diversa, senza riferimenti con il prima. Era una città per così dire "nana", tutta di edifici bassi, a un piano, e di botto si è convertita in una selva di grattacieli. Simboli di quella potenza nuovissima, di quel contraltare agli USA che il potere cinese aspira a diventare. Racconto in Mille anni a Pechino la reazione sbalordita di una delegazione cinese che ho accompagnato a visitare Lucca. «Ma che cosa ve ne fate di tutto questo vecchiume? Buttatelo giù.» Al cinese non viene in mente di andare a vedere le "cose vecchie": è passato di colpo dall'immobilismo al turismo frenetico di massa, con tutti i suoi surrogati di Disneyland.
M. B. Sì, cose tremende, sparse ovunque. Si scia sulle dune del deserto, si scorrazza all'impazzata in jeep tra enormi castelli di sabbia, se non addirittura tra finte piramidi e sfingi, a quattro passi dall'Esercito di Terracotta di Xi'an. Ma a Pechino non mi pare che ci sa roba del genere: si rema romanticamente sui laghetti, si balla il liscio sotto le piante, si fa ginnastica nei parchi, si canta in coro. Tutte cose ingenuamente naturali che a me piacciono molto. E per le quali loro vanno pazzi.
R. P. Ne vanno pazzi, certo, si divertono moltissimo perché stanno uscendo contemporaneamente dal grigiore puritano del comunismo e dalle durezze del feudalesimo. Ma una coscienza del viaggio come arricchimento culturale è ancora di là da venire.
M. B. Forse però non nei giovani, che sono meno ingenui, più informati, più colti. Io ne ho incontrati tanti in puntigliosa, quasi religiosa ricerca dei loro luoghi storici, per esempio le tante, bellissime Grotte dei Buddha che ci sono su tutta la Via della Seta. Sapevano benissimo dove stavano andando e che cosa stavano cercando.
R. P. Be', certo, sono quei giovani di cui parlavo prima, quelli che troveranno il nuovo equilibrio. Speriamo che lo trovino davvero. Mille anni anche a loro.
Renata Pisu, “Mille anni a Pechino”, Sperling & Kupfer