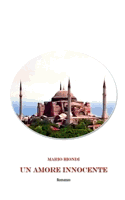Scrive di: Peter Hopkirk
1. Recensione: “Il grande gioco” (2004)
2. Recensione: “Diavoli stranieri sulla Via della Seta” (2006)
1. Recensione: “Il grande gioco” (2004)
2. Recensione: “Diavoli stranieri sulla Via della Seta” (2006)
© Mario Biondi
Divieto di riproduzione integrale
e obbligo di citazione (per cortesia...)
«Rule Britannia», cantavano da decenni i britannici. Parole di James Thompson, musica di Thomas Augustine Arne (1740). Alla metà del XIX secolo dominavano sulle “onde” e sui continenti. Colui che aveva cercato di opporsi e di rimodellare il mondo secondo suoi diversi criteri di libertà e cultura, il francese Napoleone, giaceva immobile da un pezzo. Londra mirava a congiungersi con Calcutta (e viceversa) per un itinerario meno interminabile e meno legato ai venti stagionali di quello attraverso gli oceani, un itinerario terrestre che la portasse (per così dire) rapidamente al Mediterraneo dal suo Impero in India e viceversa. Vi si opponevano due potenze: l’impero ottomano e quello russo.
Sulle loro terre si dipanava l’intricato ma collaudatissimo reticolo di strade, piste e tratturi detto “Via della Seta”. E sulla Via della Seta correvano, nelle due opposte direzioni, merci preziosissime. La cosa irritava profondamente i britannici, consacrati come si sentivano per volere divino a controllare il mondo e soprattutto i suoi commerci. Per di più, al di là di ottomani e russi, in Europa, stavano facendo capolino i superindustrializzati ed efficientissimi prussiani…
Il Sultano di Costantinopoli, il cosiddetto “Tacchino”, “Il malato d’Europa”, non sembrava rappresentare un grosso problema, ma i russi erano un’altra cosa. Ed era attraverso le loro terre che si compiva il viaggio più rapido da Londra (o dalla Prussia, oltre che ovviamente dalla stessa Mosca) verso l’Asia Centrale. Gli studiosi britannici del Grande Gioco, nelle loro incrollabili certezze circa la sacrosanta validità delle pretese di Londra sull’Asia Centrale e la conseguente smaccata infondatezza di quelle di Mosca, non si pongono mai nemmeno l’ombra del problema di queste distanze.
Comunque, una volta arrivati in Asia Centrale, giù a capofitto, valicando alcuni vertiginosi passi tra i più alti al mondo, verso l’India. Tuttavia, che uomini e merci arrivassero in quelle zone da Londra (o ne partissero sotto l’egida commerciale e politica di Londra), a chi governava l’Inghilterra sarebbe andato benissimo, e se andava bene a loro andava di sicuro bene anche a Dio. Ma che quelle merci arrivassero da o partissero per Mosca, no, questo non andava affatto bene.
Per cercare di evitare tanta iattura fu organizzato un losco sport, che gli stessi inglesi chiamarono “Grande Gioco” e i russi “Torneo delle Ombre”. Una guerra di spie che costò la vita a moltissimi esseri umani, ma soprattutto impedì quasi ogni possibilità di uno sviluppo ordinato e rapido per i paesi dell’Asia Centrale e del Medio Oriente.
Quest’ultimo, poi (Iran, Afghanistan e Pakistan), da non confondere con il Vicino Oriente, dove i britannici avrebbero avuto modo qualche decennio più tardi di mettere in opera tutto il loro contorto genio politico creando la più ingovernabile delle polveriere transnazionali: l’Iraq, impietoso assemblaggio di antiche culture, religioni e popoli, tanto civili quanto sfortunati, messi insieme con la forza in nome degli interessi di Londra. La storia di questa tragedia (e dei suoi postumi) si può leggere in Tariq Ali, Bush in Babilonia. La ricolonizzazione dell'Iraq.
E a suo tempo se ne indignò persino l’ultrabritannico Robert Byron sulla via per l’Oxiana, definendolo “un altro, insigne episodio dell’Era del Tradimento nella politica estera britannica”. Ma i britannici avevano dovuto inventare in tutta fretta un regno per il loro alleato Feisal (arabo sunnita), il grande ribelle amico di Lawrence, spedito via precipitosamente da Damasco dove era arrivato da vincitore fin dal cuore dell’Arabia, e non intendevano sottilizzare sulle promesse fatte e sui diritti delle altre popolazioni locali, sciiti, curdi e cristiani assiri (una storia che, appunto, dura ancora oggi e chissà quando finirà…)
Così, per praticare il Grande Gioco fu organizzata una fittissima rete di finti archeologi, finti studiosi, finti scrittori, finti viaggiatori, finti commercianti di cavalli, finti esperti di lavorazione della seta, e chi più ne ha più ne metta, per andare a raccogliere informazioni tra Karakoram, Pamir, Tien Shan e deserti rossi e neri, e intanto piantare una zizzania possibilmente eterna. Quasi tutti tornarono con dettagliatissimi memoriali, accolti a braccia aperte e pubblicati a spese della Geographical Society, diversi tornarono dopo aver depredato di inestimabili tesori artistici antichissimi monasteri e intere valli buddiste, alcuni infine rimasero là per sempre, parce sepultis.
Per superare le terre dei russi e avvicinarsi alle grandi montagne che bordano l’India di allora (adesso è per lo più Pakistan, oltre al contesissimo Kashmir) bisognava superare tremendi deserti tra Caspio e Aral e soprattutto l’occhiuta attenzione dei predoni nomadi turkmeni e quella non meno occhiuta del Khan di Khiva e dell’Emiro di Bukhara, che campavano remoti in un lusso medievale, da un lato imponendo pedaggio sulla loro parte di Via della Seta e dall’altro lasciando depredare le carovane e vendere sui loro mercati merci rapinate ed esseri umani catturati.
E molti britannici (o assimilati) ci lasciarono le penne, non di rado ficcati in un pozzo buio e pieno di parassiti davanti alle mura di Bukhara (Connolly e Stoddart). Ma bukharioti e khivani sapevano fin troppo bene com’erano stati straziati dai soldati britannici i regni Moghul dell’India, e non avevano nessuna intenzione di fare la stessa fine. Era soltanto naturale che cercassero di difendersi, anche se poi l’indipendenza la persero lo stesso sotto il premere dei soldati zaristi. Anche questi ultimi, però, dopo aver pagato un impressionante tributo di sofferenze e sangue nei deserti infuocati e gelati tra Caspio, Aral, Amu Darya e giù giù fino ai confini iraniani.
Il Grande Gioco non ha interessato se non molto marginalmente l’Italia (un po’ con la guerra di Crimea, magari, ma da lontanissimo), per cui da noi non se ne sa quasi niente, ma studi e saggi e relazioni e resoconti e memorie e pistolotti e narrazioni di russi e britannici sono autentiche caterve, e se ne aggiungono di sempre nuovi. Tra di essi, un tempo, il probabilmente sopravvalutato Kim di Kipling e, adesso, i saggi giornalistico-storici di Peter Hopkirk e in particolare Il grande gioco.
Hopkirk è internazionalmente noto come esperto della questione, e nel suo grosso libro passa rigorosamente in rassegna tutto il Grande Gioco sui due fronti contrapposti, dai primordiali tempi di Napoleone e Lord Wellesley (vedi al proposito persino i corruschi romanzoni del soldato Sharpe di B. Cornwell…) Come in ogni partita che si rispetti, alle mosse di Alexander Burns si contrappongono quelle del “misterioso” Vitchevich, alle trame del conte Simonich quelle di John McNeill, alle conquiste del generale Kaufman le contromisure del viceré John Lawrence e giù giù, fino a quel George Macartney, console di Kashgar — la cui moglie ci ha lasciato le sue deliziose memorie di dama inglese nel Turkestan [vedi] — nella sua sottile guerra di nervi con il console russo Nikolai Petrovsky. Eccetera eccetera, fino alla fine, dopo oltre un secolo, segnata dallo scoppio della Rivoluzione Sovietica.
A quel punto, nonostante tutto, i russi avevano vinto. L’Asia Centrale era loro e lo sarebbe rimasta per oltre quarant’anni dopo che la Gran Bretagna si sarebbe dovuta ritirare dai possedimenti imperiali governati da Calcutta. Quanto all’Afghanistan, be’, continua a non apparire particolarmente morbido nei confronti delle presunte buone intenzioni civilizzatrici di chi viene da fuori.
La più tragica tra le pagine del Grande Gioco fu infatti proprio il tentativo dei britannici di imporre il loro controllo su quell’orgogliosissimo paese usando un fantoccio locale. L’occupazione dell’Afghanistan tra il 1839 e il 1842 si risolse in una disfatta che significò la morte di migliaia di esseri umani, prima a Kabul e poi in più riprese durante la rovinosa ritirata verso il Pakistan. Si sostiene che le truppe occidentali oggi impegnate in Afghanistan userebbero ancora le informazioni raccolte da quei Grandi Giocatori, ma sarebbe forse meglio se i loro governi avessero tenuto e tenessero conto di quanto successo allora, tra il 1839 e il 1842, oltre che naturalmente tra il 1979 e il 1989 sul confine opposto.
L’opera di Hopkirk, pur non di rado carente del presunto fair play britannico nei confronti dell’altro lato della scacchiera — quello russo, troppo spesso presentato come rozzo, malfido e pasticcione, mentre è lecito nutrire più di qualche dubbio —, è tuttavia di straripante e ferrea documentazione e impeccabile nella costruzione: il vero e proprio romanzo (britannico) del Grande Gioco.
2.
I Monti del Cielo (Tien Shan) che si levano sempre innevati a nord di Kuqa dal deserto del Taklamakan (Turkestan cinese ovvero Sinkiang uiguro), segnando il confine tra Cina e Khazakstan (e Kyrgyzstan), sono uno spettacolo da togliere il fiato. Altrettanto le “Montagne fiammeggianti” di loess che fanno da contorno alla depressione di Turpan, 80 metri sotto il livello del mare. Ma le città della “Via Settentrionale della Seta”, ovvero appunto Kuqa e Turpan con le loro Grotte dei Mille Bhudda, sono deludenti. Se lo sono non è tuttavia colpa delle grotte in sé, quanto piuttosto degli avventurieri internazionali - detti «esploratori», «archeologi», «storici», «studiosi» eccetera - alla Albert von Le Coq e Aurel Stein che le hanno spogliate di affreschi, sculture e preziosissimi documenti, onoratissimi nelle patrie a cui hanno regalato le tonnellate di bottino, ma in realtà ladri di antichità. Laggiù tra le sabbie non è rimasto quasi niente di ciò che esse proteggevano in qualche caso da ben più di un millennio (il primo libro stampato al mondo), e a molto poco vale l’indignazione postuma dei cinesi, che si vendicano non facendo vedere quasi niente al malcapitato turista occidentale di oggi, impedito di fotografare alcunché e tenuto al guinzaglio da petulanti guide che pigolano notizie a caso nel loro “chinglish” (chinese-english) meccanico e incomprensibile. Per aggiungere al danno le beffe, alle Grotte di Turpan (Bezeklik) il rampante neo-turismo interno cinese ha imposto di preporre una sorta di raccapricciante Buddhaland con musicaccia e giochi da luna park. Un orrore.
Molto meglio Dunhuang, alle cui Grotte fanno peraltro da preambolo incredibili, altissime dune desertiche, costellate di bottigliette e lattine abbandonate ovunque dal suddetto cordiale ma ineducatissimo turismo nazionale, con slitte per discenderle a rotta di collo come fossero di neve, torme di pazienti cammelli bardati per inoltrarvisi, parapendii per svolazzarci sopra. Comunque le dune sono di impressionante bellezza, e magnifiche, finalmente, sono le grotte: almeno i Buddha giganteschi nessuno è riuscito a rubarli, anche se tra inglesi, tedeschi, russi, francesi, giapponesi e americani sono riusciti agli inizi del Ventesimo secolo a fare un’autentica strage di documenti preziosissimi quanto antichissimi in un numero infinito di lingue note e ignote, a testimonianza di buddismo indiano, gandhariano e protocinese, più nestorianesimo, manicheismo e chissà che cosa ancora.
Una strage nel vero senso della parola, visto che una grossa parte della refurtiva è andata distrutta a Berlino sotto i bombardamenti della Seconda guerra mondiale o dispersa tra Giappone, Corea, Manciuria ed ex Unione Sovietica, se non abbandonata a languire in svariate cantine di grandi musei internazionali. Qualcuno continua tuttavia a sostenere che quei furti sono serviti a salvare almeno buona parte di preziosi reperti altrimenti destinati a essere distrutti dagli eserciti invasori o dalle soldataglie dei locali signori della guerra, se non da orde di iconoclasti musulmano-cinesi, più gli accaniti tombaroli locali, più le intemperanze delle Guardie Rosse. Abbastanza vero, ma i cinesi continuano a parlare di furto e a essere indignati, e non si può dar loro torto, soprattutto se si pensa al disastro di Berlino. Ma agli inizi del Novecento l’impero manciù era in disfacimento, e a quelle remote lontananze dal centro i governatori “amban”) pensavano più che altro a difenderlo dalle mire irredentiste dei khan locali, se non semplicemente a mettersi al sicuro. E i “diavoli stranieri”, per i quali i cinesi ancora adesso “digrignano i denti”, facevano il bello e il brutto tempo. Non furtarelli: carrettate e carrettate di roba di inestimabile valore.
Di tutto quanto sopra e di coloro che hanno praticato il discutibile sport, a partire dal grande esploratore svedese-nazista Sven Hedin (che tuttavia più che rubare ha mappato per primo il deserto Taklamakan e passato la palla agli archeologi), attraverso l’ungherese-britannico Aurel Stein, l’ugonotto-germanico Albert von Le Coq, il francese Paul Pelliot, diversi russi, il giapponese conte Otani fino all’americano Langdon Warner (credo di averli citati tutti) ha tracciato un ormai invecchiato (anche nella grafia dei nomi) ma appassionante e documentatissimo resoconto - Diavoli stranieri sulla Via della Seta - l’inglese Peter Hopkirk, specialista di quelle aree, cui ha dedicato anche il ponderoso saggio sul torbido “Grande gioco” praticato sempre da quelle parti (Sinkiang e dintorni) da britannici e russi sul finale del Diciannovesimo secolo. Un testo apparentemente molto documentato, ma che può suscitare più di qualche irritazione per il suo taglio ultranazionalistico: i britannici avevano sempre ragione, i russi erano bestie, e stop. Si può avere più di qualche dubbio, visto che comunque il Grande gioco i britannici lo hanno perso alla grande.
Il saggio sulle razzie di antichità tra le sabbie di Taklamakan e dintorni, invece, è molto meno schierato, anche se alla fine non riesce a trattenersi: l’unico veramente bravo era l’ungherese naturalizzato britannico Aurel Stein, quasi tutti gli altri lasciavano in un modo o nell’altro a desiderare. Sarà senz’altro stato così.
Diavoli stranieri sulla Via della Seta è un libro di oltre 25 anni fa, quindi inevitabilmente datato nelle conclusioni (oltre che nella grafia dei luoghi): a quei tempi di frontiere cinesi (e sovietiche) ancora quasi chiuse e di primissimi visitatori britannici con tutta la loro albagia, Hopkirk non poteva di sicuro prevedere le entusiastiche e ottimistiche truppe di turisti cinesi con le loro ululanti guide armate di altoparlante, i luna park buddhisti e le bottigliette buttate dappertutto. Ma per chi ama quelle remote e affascinanti zone centro asiatiche con la loro fusione di antiche culture orientali e l’abbagliante misto di deserti infuocati e montagne altissime, è una lettura di grande interesse, oltre che di sicuro propedeutica per una più ragionata visita a Kuqa, Turpan e Dunhuang.
Peter Hopkirk, “Il grande gioco”, Adelphi
Peter Hopkirk, “Diavoli stranieri sulla Via della Seta”, Adelphi
Sulle loro terre si dipanava l’intricato ma collaudatissimo reticolo di strade, piste e tratturi detto “Via della Seta”. E sulla Via della Seta correvano, nelle due opposte direzioni, merci preziosissime. La cosa irritava profondamente i britannici, consacrati come si sentivano per volere divino a controllare il mondo e soprattutto i suoi commerci. Per di più, al di là di ottomani e russi, in Europa, stavano facendo capolino i superindustrializzati ed efficientissimi prussiani…
Il Sultano di Costantinopoli, il cosiddetto “Tacchino”, “Il malato d’Europa”, non sembrava rappresentare un grosso problema, ma i russi erano un’altra cosa. Ed era attraverso le loro terre che si compiva il viaggio più rapido da Londra (o dalla Prussia, oltre che ovviamente dalla stessa Mosca) verso l’Asia Centrale. Gli studiosi britannici del Grande Gioco, nelle loro incrollabili certezze circa la sacrosanta validità delle pretese di Londra sull’Asia Centrale e la conseguente smaccata infondatezza di quelle di Mosca, non si pongono mai nemmeno l’ombra del problema di queste distanze.
Comunque, una volta arrivati in Asia Centrale, giù a capofitto, valicando alcuni vertiginosi passi tra i più alti al mondo, verso l’India. Tuttavia, che uomini e merci arrivassero in quelle zone da Londra (o ne partissero sotto l’egida commerciale e politica di Londra), a chi governava l’Inghilterra sarebbe andato benissimo, e se andava bene a loro andava di sicuro bene anche a Dio. Ma che quelle merci arrivassero da o partissero per Mosca, no, questo non andava affatto bene.
Per cercare di evitare tanta iattura fu organizzato un losco sport, che gli stessi inglesi chiamarono “Grande Gioco” e i russi “Torneo delle Ombre”. Una guerra di spie che costò la vita a moltissimi esseri umani, ma soprattutto impedì quasi ogni possibilità di uno sviluppo ordinato e rapido per i paesi dell’Asia Centrale e del Medio Oriente.
Quest’ultimo, poi (Iran, Afghanistan e Pakistan), da non confondere con il Vicino Oriente, dove i britannici avrebbero avuto modo qualche decennio più tardi di mettere in opera tutto il loro contorto genio politico creando la più ingovernabile delle polveriere transnazionali: l’Iraq, impietoso assemblaggio di antiche culture, religioni e popoli, tanto civili quanto sfortunati, messi insieme con la forza in nome degli interessi di Londra. La storia di questa tragedia (e dei suoi postumi) si può leggere in Tariq Ali, Bush in Babilonia. La ricolonizzazione dell'Iraq.
E a suo tempo se ne indignò persino l’ultrabritannico Robert Byron sulla via per l’Oxiana, definendolo “un altro, insigne episodio dell’Era del Tradimento nella politica estera britannica”. Ma i britannici avevano dovuto inventare in tutta fretta un regno per il loro alleato Feisal (arabo sunnita), il grande ribelle amico di Lawrence, spedito via precipitosamente da Damasco dove era arrivato da vincitore fin dal cuore dell’Arabia, e non intendevano sottilizzare sulle promesse fatte e sui diritti delle altre popolazioni locali, sciiti, curdi e cristiani assiri (una storia che, appunto, dura ancora oggi e chissà quando finirà…)
Così, per praticare il Grande Gioco fu organizzata una fittissima rete di finti archeologi, finti studiosi, finti scrittori, finti viaggiatori, finti commercianti di cavalli, finti esperti di lavorazione della seta, e chi più ne ha più ne metta, per andare a raccogliere informazioni tra Karakoram, Pamir, Tien Shan e deserti rossi e neri, e intanto piantare una zizzania possibilmente eterna. Quasi tutti tornarono con dettagliatissimi memoriali, accolti a braccia aperte e pubblicati a spese della Geographical Society, diversi tornarono dopo aver depredato di inestimabili tesori artistici antichissimi monasteri e intere valli buddiste, alcuni infine rimasero là per sempre, parce sepultis.
Per superare le terre dei russi e avvicinarsi alle grandi montagne che bordano l’India di allora (adesso è per lo più Pakistan, oltre al contesissimo Kashmir) bisognava superare tremendi deserti tra Caspio e Aral e soprattutto l’occhiuta attenzione dei predoni nomadi turkmeni e quella non meno occhiuta del Khan di Khiva e dell’Emiro di Bukhara, che campavano remoti in un lusso medievale, da un lato imponendo pedaggio sulla loro parte di Via della Seta e dall’altro lasciando depredare le carovane e vendere sui loro mercati merci rapinate ed esseri umani catturati.
E molti britannici (o assimilati) ci lasciarono le penne, non di rado ficcati in un pozzo buio e pieno di parassiti davanti alle mura di Bukhara (Connolly e Stoddart). Ma bukharioti e khivani sapevano fin troppo bene com’erano stati straziati dai soldati britannici i regni Moghul dell’India, e non avevano nessuna intenzione di fare la stessa fine. Era soltanto naturale che cercassero di difendersi, anche se poi l’indipendenza la persero lo stesso sotto il premere dei soldati zaristi. Anche questi ultimi, però, dopo aver pagato un impressionante tributo di sofferenze e sangue nei deserti infuocati e gelati tra Caspio, Aral, Amu Darya e giù giù fino ai confini iraniani.
Il Grande Gioco non ha interessato se non molto marginalmente l’Italia (un po’ con la guerra di Crimea, magari, ma da lontanissimo), per cui da noi non se ne sa quasi niente, ma studi e saggi e relazioni e resoconti e memorie e pistolotti e narrazioni di russi e britannici sono autentiche caterve, e se ne aggiungono di sempre nuovi. Tra di essi, un tempo, il probabilmente sopravvalutato Kim di Kipling e, adesso, i saggi giornalistico-storici di Peter Hopkirk e in particolare Il grande gioco.
Hopkirk è internazionalmente noto come esperto della questione, e nel suo grosso libro passa rigorosamente in rassegna tutto il Grande Gioco sui due fronti contrapposti, dai primordiali tempi di Napoleone e Lord Wellesley (vedi al proposito persino i corruschi romanzoni del soldato Sharpe di B. Cornwell…) Come in ogni partita che si rispetti, alle mosse di Alexander Burns si contrappongono quelle del “misterioso” Vitchevich, alle trame del conte Simonich quelle di John McNeill, alle conquiste del generale Kaufman le contromisure del viceré John Lawrence e giù giù, fino a quel George Macartney, console di Kashgar — la cui moglie ci ha lasciato le sue deliziose memorie di dama inglese nel Turkestan [vedi] — nella sua sottile guerra di nervi con il console russo Nikolai Petrovsky. Eccetera eccetera, fino alla fine, dopo oltre un secolo, segnata dallo scoppio della Rivoluzione Sovietica.
A quel punto, nonostante tutto, i russi avevano vinto. L’Asia Centrale era loro e lo sarebbe rimasta per oltre quarant’anni dopo che la Gran Bretagna si sarebbe dovuta ritirare dai possedimenti imperiali governati da Calcutta. Quanto all’Afghanistan, be’, continua a non apparire particolarmente morbido nei confronti delle presunte buone intenzioni civilizzatrici di chi viene da fuori.
La più tragica tra le pagine del Grande Gioco fu infatti proprio il tentativo dei britannici di imporre il loro controllo su quell’orgogliosissimo paese usando un fantoccio locale. L’occupazione dell’Afghanistan tra il 1839 e il 1842 si risolse in una disfatta che significò la morte di migliaia di esseri umani, prima a Kabul e poi in più riprese durante la rovinosa ritirata verso il Pakistan. Si sostiene che le truppe occidentali oggi impegnate in Afghanistan userebbero ancora le informazioni raccolte da quei Grandi Giocatori, ma sarebbe forse meglio se i loro governi avessero tenuto e tenessero conto di quanto successo allora, tra il 1839 e il 1842, oltre che naturalmente tra il 1979 e il 1989 sul confine opposto.
L’opera di Hopkirk, pur non di rado carente del presunto fair play britannico nei confronti dell’altro lato della scacchiera — quello russo, troppo spesso presentato come rozzo, malfido e pasticcione, mentre è lecito nutrire più di qualche dubbio —, è tuttavia di straripante e ferrea documentazione e impeccabile nella costruzione: il vero e proprio romanzo (britannico) del Grande Gioco.
2.
I Monti del Cielo (Tien Shan) che si levano sempre innevati a nord di Kuqa dal deserto del Taklamakan (Turkestan cinese ovvero Sinkiang uiguro), segnando il confine tra Cina e Khazakstan (e Kyrgyzstan), sono uno spettacolo da togliere il fiato. Altrettanto le “Montagne fiammeggianti” di loess che fanno da contorno alla depressione di Turpan, 80 metri sotto il livello del mare. Ma le città della “Via Settentrionale della Seta”, ovvero appunto Kuqa e Turpan con le loro Grotte dei Mille Bhudda, sono deludenti. Se lo sono non è tuttavia colpa delle grotte in sé, quanto piuttosto degli avventurieri internazionali - detti «esploratori», «archeologi», «storici», «studiosi» eccetera - alla Albert von Le Coq e Aurel Stein che le hanno spogliate di affreschi, sculture e preziosissimi documenti, onoratissimi nelle patrie a cui hanno regalato le tonnellate di bottino, ma in realtà ladri di antichità. Laggiù tra le sabbie non è rimasto quasi niente di ciò che esse proteggevano in qualche caso da ben più di un millennio (il primo libro stampato al mondo), e a molto poco vale l’indignazione postuma dei cinesi, che si vendicano non facendo vedere quasi niente al malcapitato turista occidentale di oggi, impedito di fotografare alcunché e tenuto al guinzaglio da petulanti guide che pigolano notizie a caso nel loro “chinglish” (chinese-english) meccanico e incomprensibile. Per aggiungere al danno le beffe, alle Grotte di Turpan (Bezeklik) il rampante neo-turismo interno cinese ha imposto di preporre una sorta di raccapricciante Buddhaland con musicaccia e giochi da luna park. Un orrore.
Molto meglio Dunhuang, alle cui Grotte fanno peraltro da preambolo incredibili, altissime dune desertiche, costellate di bottigliette e lattine abbandonate ovunque dal suddetto cordiale ma ineducatissimo turismo nazionale, con slitte per discenderle a rotta di collo come fossero di neve, torme di pazienti cammelli bardati per inoltrarvisi, parapendii per svolazzarci sopra. Comunque le dune sono di impressionante bellezza, e magnifiche, finalmente, sono le grotte: almeno i Buddha giganteschi nessuno è riuscito a rubarli, anche se tra inglesi, tedeschi, russi, francesi, giapponesi e americani sono riusciti agli inizi del Ventesimo secolo a fare un’autentica strage di documenti preziosissimi quanto antichissimi in un numero infinito di lingue note e ignote, a testimonianza di buddismo indiano, gandhariano e protocinese, più nestorianesimo, manicheismo e chissà che cosa ancora.
Una strage nel vero senso della parola, visto che una grossa parte della refurtiva è andata distrutta a Berlino sotto i bombardamenti della Seconda guerra mondiale o dispersa tra Giappone, Corea, Manciuria ed ex Unione Sovietica, se non abbandonata a languire in svariate cantine di grandi musei internazionali. Qualcuno continua tuttavia a sostenere che quei furti sono serviti a salvare almeno buona parte di preziosi reperti altrimenti destinati a essere distrutti dagli eserciti invasori o dalle soldataglie dei locali signori della guerra, se non da orde di iconoclasti musulmano-cinesi, più gli accaniti tombaroli locali, più le intemperanze delle Guardie Rosse. Abbastanza vero, ma i cinesi continuano a parlare di furto e a essere indignati, e non si può dar loro torto, soprattutto se si pensa al disastro di Berlino. Ma agli inizi del Novecento l’impero manciù era in disfacimento, e a quelle remote lontananze dal centro i governatori “amban”) pensavano più che altro a difenderlo dalle mire irredentiste dei khan locali, se non semplicemente a mettersi al sicuro. E i “diavoli stranieri”, per i quali i cinesi ancora adesso “digrignano i denti”, facevano il bello e il brutto tempo. Non furtarelli: carrettate e carrettate di roba di inestimabile valore.
Di tutto quanto sopra e di coloro che hanno praticato il discutibile sport, a partire dal grande esploratore svedese-nazista Sven Hedin (che tuttavia più che rubare ha mappato per primo il deserto Taklamakan e passato la palla agli archeologi), attraverso l’ungherese-britannico Aurel Stein, l’ugonotto-germanico Albert von Le Coq, il francese Paul Pelliot, diversi russi, il giapponese conte Otani fino all’americano Langdon Warner (credo di averli citati tutti) ha tracciato un ormai invecchiato (anche nella grafia dei nomi) ma appassionante e documentatissimo resoconto - Diavoli stranieri sulla Via della Seta - l’inglese Peter Hopkirk, specialista di quelle aree, cui ha dedicato anche il ponderoso saggio sul torbido “Grande gioco” praticato sempre da quelle parti (Sinkiang e dintorni) da britannici e russi sul finale del Diciannovesimo secolo. Un testo apparentemente molto documentato, ma che può suscitare più di qualche irritazione per il suo taglio ultranazionalistico: i britannici avevano sempre ragione, i russi erano bestie, e stop. Si può avere più di qualche dubbio, visto che comunque il Grande gioco i britannici lo hanno perso alla grande.
Il saggio sulle razzie di antichità tra le sabbie di Taklamakan e dintorni, invece, è molto meno schierato, anche se alla fine non riesce a trattenersi: l’unico veramente bravo era l’ungherese naturalizzato britannico Aurel Stein, quasi tutti gli altri lasciavano in un modo o nell’altro a desiderare. Sarà senz’altro stato così.
Diavoli stranieri sulla Via della Seta è un libro di oltre 25 anni fa, quindi inevitabilmente datato nelle conclusioni (oltre che nella grafia dei luoghi): a quei tempi di frontiere cinesi (e sovietiche) ancora quasi chiuse e di primissimi visitatori britannici con tutta la loro albagia, Hopkirk non poteva di sicuro prevedere le entusiastiche e ottimistiche truppe di turisti cinesi con le loro ululanti guide armate di altoparlante, i luna park buddhisti e le bottigliette buttate dappertutto. Ma per chi ama quelle remote e affascinanti zone centro asiatiche con la loro fusione di antiche culture orientali e l’abbagliante misto di deserti infuocati e montagne altissime, è una lettura di grande interesse, oltre che di sicuro propedeutica per una più ragionata visita a Kuqa, Turpan e Dunhuang.
Peter Hopkirk, “Il grande gioco”, Adelphi
Peter Hopkirk, “Diavoli stranieri sulla Via della Seta”, Adelphi