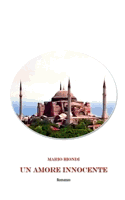I cento anni di I. B. Singer (2004)
«La morte è il Messia. Ecco la verità.» Così risponde per tutti Hertz Yanovar nell'ultima riga di La famiglia Moskat: su Varsavia in fiamme sta per abbattersi la distruzione nazista. La morte. Quella morte che, in condizioni simili, non può essere altro che il Messia. Una morte vista come momento di catarsi definitiva, come conquista della pace per una folla di anime che su questa terra, tra noi mortali, la pace sembrano destinate a non trovarla mai. «Date agli ebrei una rivoluzione. Ne pretenderanno un'altra. Date loro un Messia. Ne chiederanno un altro», scrive lo stesso Singer (suscitando tra l'altro furie incomprensibili, facendolo addirittura definire ”antisemita“). Date loro, vien fatto cupamente di aggiungere, una morte. Nel loro perenne sradicamento, nella loro eterna inquietudine, ne chiederanno un'altra.
In questi tredici anni trascorsi dalla sua morte, Isaac Bashevis Singer ne avrà certamente già chiesto chissà quante altre. Avrà chiesto di continuare a rimanere fra noi, tramutato in dybbuk, sotto le spoglie di folletto, di spiritello, di lantuch, di poltergeist, di capra parlante, di cavallo saggio, di carpa irriverente. E di sicuro rimarrà sempre tra noi nelle infinite trasfigurazioni che di se stesso ci ha dato nella sua opera. Nelle vesti di Asa Heshel Katzenellenbogen, protagonista della citata Famiglia Moskat. Oppure in quelle di Aaron Greidinger, protagonista di Shosha. Magari in quelle di Herman Broder, protagonista di Nemici. Una storia d'amore, o del suo omologo Hertz Grein, protagonista dell'impareggiabile Ombre sull'Hudson, sommo capolavoro. E naturalmente in quelle del protagonista — bambino, fanciullo, giovane uomo e poi uomo maturo — delle storie contenute in Alla corte di mio padre (le prime e le Nuove) e in Un giorno di felicità, oltre che nella sua autobiografia, Ricerca e perdizione: la ricerca di Dio e dell'amore, ma soprattutto di se stesso, e la perdizione in questo mondo contemporaneo, uno dei tanti mondi possibili.
Quanti saranno mai i mondi? si chiede ansiosamente, sfogliando proibitissimi libri di ”scienza“, prima della Grande Guerra, il piccolo figlio del rabbino di Via Krochmalna, a Varsavia — capelli rossi, occhi azzurri, gabbanello da chassid — che compare in decine di storie del Nostro. In ciascuno di questi mondi I. B. Singer ha sicuramente cercato o cercherà nel tempo il proprio posto. Qui nel nostro rimarrà a osservare con il suo sguardo carico di ironia — un po' velato dall'inguaribile febbre da fieno — lo stralunarsi degli ismi, lo scavalcarsi e svanire delle mode. Quelle mode che hanno sempre teso a trascurarlo, a chiuderlo in un angolo, a non lasciargli spazio. Persino a calunniarlo.
Uno scrittore all'antica, prevedibile, capace al più di scrivere qualche romanzo tradizionale, qualche racconto folcloristico. Anche un po' osceno, non di rado. Così veniva generalmente considerato. In Italia, nel 1978, scoperto da quasi un quindicennio, non si trovava nemmeno più chi volesse tradurlo (o, meglio, si fingeva di non trovarlo). Lo fece imponendosi a forza chi scrive questo pezzo, in condizioni tremende di angustia, persino di ostilità. Dovette tra l'altro farlo non sul libro definitivo ma su bozze ”uncorrected“, piene di refusi fuorvianti. E poi, all'assegnazione del Premio Nobel nel novembre di quell'anno — evento del tutto imprevedibile —, i fogli vennero sfilati altrettanto a forza dal carrello della macchina per scrivere del traduttore, a uno a uno, per essere spediti pari pari in tipografia, senza un'ombra di revisione, pieni di tutto il cascame che per forza c'è nelle primissime versioni di qualsiasi testo. Il romanzo doveva uscire SUBITO, non c'era tempo di rivedere niente e ancora meno di aspettare il libro definitivo dall'America. Vita dura del traduttore, soprattutto se è stato lui a voler tradurre a tutti i costi. Colpa sua...
Persino davanti all'assegnazione del Nobel, comunque, dal coro dei presunti sapienti si levarono voci a discettare, a dubitare. Non sulla traduzione, no, no: sull'arte di Singer in sé e sul suo probabile non esser degno del premio. E lui, semplicità fatta monumento alla scrittura, replicò con disarmante modestia spiegando che si trattava di un Premio Nobel assegnato non già alla sua umile arte di raccontatore di storie ma a una comunità tristemente destinata a perdere la propria identità, la voce, la lingua. La comunità di lingua yiddish, dispersa come cenere.
Nel cuore di quella comunità, nel villaggio di Radzymin, in Polonia, da una ”casta figlia di ebrei“ di nome Betsabea e da un rabbino chassidico, nacque 100 anni fa, il 14 luglio 1904, Isaac Bashevis Singer, fratello minore di Israel Joshua, anch'egli grande scrittore, sempre guardato dal cadetto come insuperabile maestro. Abbeverato al pozzo senza fondo di storie popolari raccontate da indimenticabili narratori orali di ”cucina“, di ”cortile“ o di ”casa di studio“ — zia Yentl, Levi Yitzchock, Zalman il vetraio, Meyer l'eunuco —, depositari dell'immenso accumulo di invenzioni del folclore ebraico e yiddish, già a sedici anni il ragazzo Isaac, proclamatosi ”libero pensatore“, affronta l'arte dello scrivere nella lingua formale degli eruditi, l'ebraico. Ma la voce del suo popolo gli è irresistibile. Nel suo sangue canta il retaggio di un lungo albero genealogico di rabbini chassidici. Deve indagare il loro mondo mitico e meraviglioso, raccontare storie popolari. Dunque deve usare la lingua del popolo, il ”giudeo“, lo yiddish.
Trentunenne, nel 1935, in tale lingua pubblica a Varsavia il primo romanzo: Satana a Goray. Non lo vedrà mai in quella veste: è già riparato nel Nuovo Mondo, in America, in cerca di se stesso e della ”perdizione“. Per anni campa in maniera grama, collaborando al quotidiano di Manhattan in lingua yiddish — il Jewish Daily Forward —, redigendo rubriche di consigli pratici, tenendo conferenze, scrivendo per conto terzi. È una vicenda che descrive troppe volte nei propri racconti perché non sia vera: insomma, facendo il ghost writer per altri. Attività che i presunti sapienti dalla penna stitica non gli hanno mai perdonato, quasi che scrivere per guadagnarsi da vivere fosse un'offesa alla decenza. Ancora adesso, tanti anni dopo la sua morte e nel centenario della nascita, c'è chi non trova di meglio che spargere veleno su di lui. Gente, tra l'altro, mai sentita nominare.
Tutto questo e ben di più ci ricorda la bella biografia di Florence Noiville, studiosa che ama Singer e lo presenta per ciò che è stato, facendo fondamentalmente ricorso ai suoi testi autobiografici, che come è noto, a leggerli bene, rappresentano circa il cento per cento della sua opera.
Importante, tra l'altro, il documentato approfondimento della questione della doppia redazione dei testi di Singer, una vera e propria doppia identità: quella in yiddish e quella in americano. Due versioni ”originali“ a pieno titolo, insomma, come le definiva lui stesso, che curava di persona con estenuante puntiglio quella americana (anche se non di rado con l'ausilio di traduttori ameryiddish che sapevano l'americano meno di lui), e su quest'ultima esigeva che fossero basate le traduzioni nelle altre lingue, vietando addirittura che si usasse la versione yiddish, spesso del tutto diversa in quanto buttata giù per le esigenze della pubblicazione a puntate sul Forward o poi tagliuzzata o adeguata a tali esigenze.
Faticando in quel modo per campare, Singer accumulava ed elaborava il meraviglioso materiale dei suoi grandi romanzi: La fortezza, La famiglia Moskat, Il mago di Lublino, Ombre sull'Hudson. E per la straordinaria fioritura dei suoi circa (o oltre? quanti saranno?) duecento racconti, creando un mondo variopinto, «meraviglioso, terribile e splendido» — come ha scritto Henry Miller —, che quello reale e limitato degli uomini non potrà dimenticare mai, a dispetto delle inappellabili decisioni dell'Angelo della Morte.