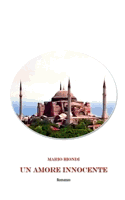Scrive di: Joseph Roth
Recensione: “Giobbe” (1977)
Recensione: “Il profeta muto” (1979)
Recensione: “Giobbe” (1977)
Recensione: “Il profeta muto” (1979)
© Mario Biondi
Divieto di riproduzione integrale
e obbligo di citazione (per cortesia...)
Joseph Roth, ebreo assimilato, figlio per parte di padre della grande tradizione asburgica e soprattutto per parte di madre della grande tradizione ebraico-slava, grande scrittore troppo tardi rivelato davvero al largo pubblico italiano: più di trent’anni dopo la morte, avvenuta nel 1939. Grande deluso e grande negatore: deluso dei fermenti di novità bruciatisi con la tragedia di Weimar (come vi furono i grandi delusi del 1848, come vi sono già i delusi del 1968, per esempio), negatore della storia, ma del presente e del futuro come storia, non di quella del passato, e dunque malinconico indagatore del proprio passato storico e delle proprie radici: quel passato in cui l’imperatore Francesco Giuseppe era l'ordine del mondo e rivolgeva le proprie allocuzioni aprendole con le parole «Ai miei popoli», quelle radici ebraico-slave che erano patrimonio di larga parte di quei «popoli».
Al versante della nostalgia asburgica appartiene La marcia di Radetzky (che mi ostino a considerare il suo capolavoro); al versante della nostalgia ebraica appartiene Giobbe. che è il capolavoro di questo lato della produzione rothiana e che viene ora presentato in libreria nella splendida nuova traduzione di Laura Terreni.
Il Giobbe di Roth è Mendel Singer, umilissimo e timoroso fedele della legge ebraica, che vive in un villaggio russo e campa con la famiglia delle poche monete che gli dà la sua professione di maestro. La miseria e la sventura aleggiano sulla sua povera testa di discendente di Giobbe, ma egli crede: sia fatta la volontà di Dio.
La sua famiglia si trasferisce in America seguendo il figlio che ha fatto fortuna: Mendel considera anche questo volontà di Dio e parte, accettando di abbandonare al suo destino il figlio malato. Se Dio vuole, guarirà. Anche in America la sventura si accanisce sulla sua testa sempre più povera, gli annienta la famiglia, lo getta nella disperazione: allora Giobbe si ribella grida che vuole bruciare. A chi gli chiede cosa vuole bruciare risponde: voglio bruciare Dio. Ma Dio, per voce del rabbino, aveva detto che il piccolo malato sarebbe guarito, e il figlio ricompare, non più malato, ma bello, ricco, importante.
Unico romanzo “positivo” di Roth, ha scritto di Giobbe Claudio Magris: sì, positivo, ma ancora una volta nel senso di chi si è rifugiato a credere nella superiorità della tradizione rispetto al nuovo.
Joseph Roth, Giobbe, Adelphi
Corriere d’informazione, 26 novembre 1977
Il romanzo è, credo, esattamente la struttura letteraria del recupero del passato dell’autore, o del suo ipotizzare un presente possibile, fantastico o no. Ora questo recupero (o conservazione) del passato o questo ipotizzare un possibile presente, letteralmente, attraverso lo strumento del romanzo, può avvenire in maniere diverse. Secondo la logica compiaciuta di chi in questo passato o in questo possibile presente si riconosce totalmente, limitandosi a rimpiangerlo nostalgicamente, ad amarlo idillicamente, a decantarlo acriticamente. Oppure secondo la logica (che amo particolarmente ed è propria di tanto romanzo moderno e contemporaneo) della ’’malinconia”, per la quale è d’obbligo il rinvio al citatissimo saggio di Benjamin sul “narratore”. “Malinconia” come coscienza di aver vissuto o di rivivere un periodo della storia e di esserselo visto o vederselo scivolare di dosso senza avervi saputo influire, incidere abbastanza a fondo. Senza essere stato capace, l’autore, di lasciarvi l’impronta che avrebbe voluto (non tanto in quanto autore, ma in quanto “uomo civile”), per cui nel romanzo può arrivare a ipotizzare di avervela comunque in qualche modo lasciata.
Oppure, ancora, secondo una logica che in questo caso indico come terza, funzionalmente all’autore di cui intendo parlare: la logica del “lontano da dove”, espressione coniata da Claudio Magris per definire la poetica di Joseph Roth, poetica del rimpianto del tempo passato, del tempo che precede la storia contemporanea all’autore, come tempo-stato-luogo di certezze, da contrapporre alle incertezze, alla confusione, al repentino mutare di valori del tempo in cui l’autore vive senza più raccapezzarsi. Per Joseph Roth, grande anarchico della conservazione e individualista della disperazione, il “tempo” delle certezze è quello dell’impero absburgico, il suo ’’stato” quello pre-borghese, il suo “luogo” (il “dove”) l’Europa orientale ipoteticamente pre-borghese della comunità ebraica yiddish (ma per contraltare si legga la saga ebraico-borghese dell’industria tessile di Lodz, Polonia, raccontata con immensa maestria e anche “malinconia” da Israel Joschua Singer in I fratelli Ashkenazi).
Il ’’tempo" lo esemplificheremo nel romanzo La marcia di Radetzky, il “’luogo” nel romanzo Giobbe e lo “stato pre-borghese” (per assurdo, intendendo la nostalgia del medesimo) nel romanzo Il profeta muto, che è del 1929, ma che Roth non volle pubblicato in vita ed è uscito in Germania nel già lontano 1966 e solo ora in Italia per le solite edizioni Adelphi, che di Roth hanno fatto un vessillo di presenza in libreria.
Il profeta muto, titolo impressionante, che non so quanto risalga precisamente e originariamente a Roth e al 1929, e rimanda immediatamente al deutscheriano profeta "armato, disarmato e in esilio” della rivoluzione sovietica, Leone Trotsky. Vi rimanda sul serio? In Friedrich Kargan, protagonista de Il profeta muto, è veramente possibile riconoscere Leone Trotsky? Non lo so, non mi pare, ne dubito. Rimanda, semmai, e in lui è possibile riconoscere l’ormai quasi eterno identikit del ribelle che è anti-borghese in quanto piccolo borghese o alto borghese, quindi incapace di riconoscersi nella figura del medio-burocrate-borghese, che nel bene e nel male gestisce la storia, persino nelle sue rivoluzioni, almeno dalla metà del ’700. Friedrich Kargan in realtà non è affatto Trotsky: non fa nessuna rivoluzione, la guarda accadere e poi la subisce. Con inconsapevole e folgorante anticipazione, Friedrich Kargan è l’identikit di una qualsiasi delle comete svanite nel corso delle rivoluzioni europee mancate nei dopoguerra fino al 1968.
Romanzo approssimativo, misto di grandi frettolosità e sublimi folgorazioni poetiche, Il profeta muto, più che la biografia idealizzata di un grande protagonista di una rivoluzione riuscita (Trotsky), è il lamento del piccolo borghese (Roth) che comunque l’avrebbe voluta diversa, proiettata non, bene o male, nel presente se non nel futuro, ma nel passato, nel passato pre-borghese imperiale, immutabile e certo. Al lettore, comunque, di godere o meno del rapido tratteggio delle vicende di Kargan-Trotsky. Al recensore rimane solo di chiedersi se a imporre a Roth di impedire la pubblicazione in vita del suo Profeta muto, sia veramente stato il timore di possibili rappresaglie del vago Savelli-Stalin, antagonista, nel romanzo, del presunto Kargan-Trotsky.
Joseph Roth, Il profeta muto, Adelphi
Corriere d’informazione, 6 gennaio 1979
Al versante della nostalgia asburgica appartiene La marcia di Radetzky (che mi ostino a considerare il suo capolavoro); al versante della nostalgia ebraica appartiene Giobbe. che è il capolavoro di questo lato della produzione rothiana e che viene ora presentato in libreria nella splendida nuova traduzione di Laura Terreni.
Il Giobbe di Roth è Mendel Singer, umilissimo e timoroso fedele della legge ebraica, che vive in un villaggio russo e campa con la famiglia delle poche monete che gli dà la sua professione di maestro. La miseria e la sventura aleggiano sulla sua povera testa di discendente di Giobbe, ma egli crede: sia fatta la volontà di Dio.
La sua famiglia si trasferisce in America seguendo il figlio che ha fatto fortuna: Mendel considera anche questo volontà di Dio e parte, accettando di abbandonare al suo destino il figlio malato. Se Dio vuole, guarirà. Anche in America la sventura si accanisce sulla sua testa sempre più povera, gli annienta la famiglia, lo getta nella disperazione: allora Giobbe si ribella grida che vuole bruciare. A chi gli chiede cosa vuole bruciare risponde: voglio bruciare Dio. Ma Dio, per voce del rabbino, aveva detto che il piccolo malato sarebbe guarito, e il figlio ricompare, non più malato, ma bello, ricco, importante.
Unico romanzo “positivo” di Roth, ha scritto di Giobbe Claudio Magris: sì, positivo, ma ancora una volta nel senso di chi si è rifugiato a credere nella superiorità della tradizione rispetto al nuovo.
Joseph Roth, Giobbe, Adelphi
Corriere d’informazione, 26 novembre 1977
Il romanzo è, credo, esattamente la struttura letteraria del recupero del passato dell’autore, o del suo ipotizzare un presente possibile, fantastico o no. Ora questo recupero (o conservazione) del passato o questo ipotizzare un possibile presente, letteralmente, attraverso lo strumento del romanzo, può avvenire in maniere diverse. Secondo la logica compiaciuta di chi in questo passato o in questo possibile presente si riconosce totalmente, limitandosi a rimpiangerlo nostalgicamente, ad amarlo idillicamente, a decantarlo acriticamente. Oppure secondo la logica (che amo particolarmente ed è propria di tanto romanzo moderno e contemporaneo) della ’’malinconia”, per la quale è d’obbligo il rinvio al citatissimo saggio di Benjamin sul “narratore”. “Malinconia” come coscienza di aver vissuto o di rivivere un periodo della storia e di esserselo visto o vederselo scivolare di dosso senza avervi saputo influire, incidere abbastanza a fondo. Senza essere stato capace, l’autore, di lasciarvi l’impronta che avrebbe voluto (non tanto in quanto autore, ma in quanto “uomo civile”), per cui nel romanzo può arrivare a ipotizzare di avervela comunque in qualche modo lasciata.
Oppure, ancora, secondo una logica che in questo caso indico come terza, funzionalmente all’autore di cui intendo parlare: la logica del “lontano da dove”, espressione coniata da Claudio Magris per definire la poetica di Joseph Roth, poetica del rimpianto del tempo passato, del tempo che precede la storia contemporanea all’autore, come tempo-stato-luogo di certezze, da contrapporre alle incertezze, alla confusione, al repentino mutare di valori del tempo in cui l’autore vive senza più raccapezzarsi. Per Joseph Roth, grande anarchico della conservazione e individualista della disperazione, il “tempo” delle certezze è quello dell’impero absburgico, il suo ’’stato” quello pre-borghese, il suo “luogo” (il “dove”) l’Europa orientale ipoteticamente pre-borghese della comunità ebraica yiddish (ma per contraltare si legga la saga ebraico-borghese dell’industria tessile di Lodz, Polonia, raccontata con immensa maestria e anche “malinconia” da Israel Joschua Singer in I fratelli Ashkenazi).
Il ’’tempo" lo esemplificheremo nel romanzo La marcia di Radetzky, il “’luogo” nel romanzo Giobbe e lo “stato pre-borghese” (per assurdo, intendendo la nostalgia del medesimo) nel romanzo Il profeta muto, che è del 1929, ma che Roth non volle pubblicato in vita ed è uscito in Germania nel già lontano 1966 e solo ora in Italia per le solite edizioni Adelphi, che di Roth hanno fatto un vessillo di presenza in libreria.
Il profeta muto, titolo impressionante, che non so quanto risalga precisamente e originariamente a Roth e al 1929, e rimanda immediatamente al deutscheriano profeta "armato, disarmato e in esilio” della rivoluzione sovietica, Leone Trotsky. Vi rimanda sul serio? In Friedrich Kargan, protagonista de Il profeta muto, è veramente possibile riconoscere Leone Trotsky? Non lo so, non mi pare, ne dubito. Rimanda, semmai, e in lui è possibile riconoscere l’ormai quasi eterno identikit del ribelle che è anti-borghese in quanto piccolo borghese o alto borghese, quindi incapace di riconoscersi nella figura del medio-burocrate-borghese, che nel bene e nel male gestisce la storia, persino nelle sue rivoluzioni, almeno dalla metà del ’700. Friedrich Kargan in realtà non è affatto Trotsky: non fa nessuna rivoluzione, la guarda accadere e poi la subisce. Con inconsapevole e folgorante anticipazione, Friedrich Kargan è l’identikit di una qualsiasi delle comete svanite nel corso delle rivoluzioni europee mancate nei dopoguerra fino al 1968.
Romanzo approssimativo, misto di grandi frettolosità e sublimi folgorazioni poetiche, Il profeta muto, più che la biografia idealizzata di un grande protagonista di una rivoluzione riuscita (Trotsky), è il lamento del piccolo borghese (Roth) che comunque l’avrebbe voluta diversa, proiettata non, bene o male, nel presente se non nel futuro, ma nel passato, nel passato pre-borghese imperiale, immutabile e certo. Al lettore, comunque, di godere o meno del rapido tratteggio delle vicende di Kargan-Trotsky. Al recensore rimane solo di chiedersi se a imporre a Roth di impedire la pubblicazione in vita del suo Profeta muto, sia veramente stato il timore di possibili rappresaglie del vago Savelli-Stalin, antagonista, nel romanzo, del presunto Kargan-Trotsky.
Joseph Roth, Il profeta muto, Adelphi
Corriere d’informazione, 6 gennaio 1979