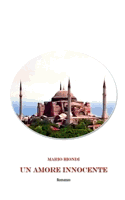Scrive di: Alberto Arbasino
Fratelli d'Italia
(edizione Einaudi 1976)
Fratelli d'Italia
(edizione Einaudi 1976)
© Mario Biondi
Divieto di riproduzione integrale
e obbligo di citazione (per cortesia...)
Che fosse uno dei più bravi (se non altro e senza dubbio «il più bravo degli Alberti», tanto per rifargli il verso), lo avevo già deciso un bel diciassette anni fa, quando mi capitò per le mani l’osatissima prima edizione feltrinelliana de L’anonimo lombardo, e non posso fare altro che confermarlo ora, a lettura appena conclusa (un tredici anni dopo la prima edizione) del nuovo Fratelli d’Italia tutto rivisto e corretto da Alberto Arbasino. Libro che rimane almeno straordinario anche a così grande distanza di tempo e si lascia abbondantemente alle spalle quasi tutto il ronzante miao-miao del romanzo italiano, diciamo, di mezza età.
Adesso naturalmente bisognerebbe che io potessi disporre di un paio di giorni «in conto permesso retribuito» per mettermi lì con la santa pazienza a fare una collazione accurata delle 659 pagine della nuova edizione Einaudi con le 532 (in corpo più grosso) della vecchia Feltrinelli, per vedere se non altro come si mescolano il «nuovo» e il «senno di poi», ma altrettanto naturalmente non si può (con i nostri due o tre ponti all’anno — perbacco! — abbiamo devastato l’Italia molto di più delle sciocchezze Lochkeed e cugine, si sa!); così procediamo per sommissimi capi.
La storia è semplicissima: quattro amici, che ci si può azzardare a definire «bizzarri», partono a bordo di due eleganti automobiline, con la scusa primaria di mettere assieme la sceneggiatura di un fantomatico «L’Italia si chiama amore» di celluloide, che naturalmente nessuno realizzerà mai. Sono uno studente ventenne from Bellinzona (quindi costretto già dalle condizioni ambientali a fare la famosa «gita a Chiasso») detto «elefantino» e già visto nell’Anonimo; un brillante scrittor-giovane di costume - moda - musica - teatro - ecc. - ecc. (tale Andrea, ma in realtà Alberto); un inutile amico francese noioso e malvestito e un compositore tedesco di gran classe, Klaus. Come dice la quarta di coperta, girano qua e là tra Roma e Milano, Firenze e Venezia, Spoleto e Capri (più Mantova e Terni, Salisburgo con la Baviera dei Ludwig e Londra dei teatri e del golf, con anche un po’ di Brembate e Lecco, Monza e Pavia); tra marchese e registi; tra teatri e giardini pubblici. Personaggi: decine di migliaia (come minimo), più o meno deliziosamente credibili. Primi su tutti una schiera spiritosissima di monsignori dai nomi altamente letterari, poi la strepitosa vecchia signora cresciuta nientemeno che in casa Tolstoi, che rammenta le visite al gran vecchio di signori che si chiamavano per esempio Cecov e Ciaikovski (e qui ilarità senza limiti per la prudentissima ammissione a porte chiuse che la vecchia signora fa di certe particolari usanze del gran musico, peraltro già scritte in tutti i garzantini: «il était ehm ehm... comment dire… ho… homo…»). Poi la Bellotta, con il suo amante poeta Arcangelo Elvezio e i due bassotti Arcangelo e Elvezio, con i qua parlare per esempio di «alienazione». E così via.
Ultima e molto noiosa quella che dovrebbe essere il faro femminile della storia, tal nobilissima Desideria. Puro e semplice Fellini & Dolce Vita, così come puro e semplice Antonioni & La notte è il di lei compagno, che muore di cancro.
E in questi due personaggi il libro denuncia i suoi anni veri: non «gran commedia dei nostri (italiani) anni Sessanta», come dice lo strillo editoriale, e neanche dei «primi anni Sessanta» come prudentemente corregge la quarta di coperta. No: ci sono dentro anche i «primi Sessanta», ma soprattutto i «last Fifties» (un po’ parenti del «last tycoon») e non solo gli «ultimi», visto che ci sono tanti bei riferimenti, dalla mostra del Mantegna a Mantova (’58 o ’57?) a «Pal Joey», che è di un bel po’ prima.
Infatti, con gli anni Sessanta il libro non c’entra un gran che e di conseguenza l'Arbasino, con grande astuzia, si è industriato a correggere e infilare dentro situazioni, prediche e nomi che hanno il compito preciso di spostare i limiti temporali del libro: p. e. quell’elencone di nomi, da Auerbach ai due Richards, attraverso Sklovskj, Saussure, Jakobson, Lévi-Strauss, Genette, ecc. ecc., che sono cultura dei Sessanta e nella nuova edizione si sommano ai vecchi Conrad, Musil, Fitzgerald ecc. ecc. che sono cultura proprio dei «Cinquanta».
Negli anni Sessanta in Italia temo che avvenissero cose vagamente diverse e più vivaci che non le feste delle contesse e dei tycoon a Capocotta: che so, diciamo «luglio ’60»? diciamo «Quaderni rossi?» diciamo persino «Gruppo ’63» e addirittura «lunga marcia verso il ’68»? Con tutte le contesse meno indecenti in marcia, naturalmente.
Chissà perché un ottimo libro molto calibratamente collocato a cavallo dei Fifties-Sixties lo si è voluto schiacciare a viva forza nei Sessanta e basta. Mah.
Detto questo parliamo dei luoghi e delle descrizioni. Si legga e si beva dalla prima all’ultima parola quella di New York, Cape Cod e Americhe varie: a chi ci è già stato sembrerà di esserci di nuovo e chi non ci è mai stato le impara precise precise. Straordinarie e messe in bocca al musicista Klaus (quattordici pagine nella vecchia, ma quarantatré nella nuova edizione, immagino con l’aggiunta di succulenti pezzi scritti all’epoca per i giornali).
E anche tutti i castelli dei Ludwig, messi invece in bocca all’«elefantino». E Londra. E la noia pestifera di Firenze.
Insomma, pari pari una «satyra lanx» con tributo a tutti i grandi: Forster, Firbank, i due Wilson, i due Lawrence (anzi quattro), Fitzgerald e Petronio (soprattutto), ma con anche un po’ di Franca Valeri e Camilla Cederna, più Sade, D’Annunzio ecc. ecc. in un fuoco artificiale di linguaggio delirante che a tratti raggiunge il limite del tollerabile (nel senso che uno deve per forza domandarsi: ma come fa?): un linguaggio che più che italiano è europeo, che si annette l’inglese e il francese e si piega alle loro costruzioni. Che dire, per esempio, di un fragoroso «E’ caduto in amore»?
Il libro finisce con un repertorio di materiali di riporto, anch’esso corretto e ampliato rispetto alla vecchia edizione: pezzi non usati, ipotesi di sviluppo della trama o della riflessione, elenchi di padri spirituali, i due risvolti editoriali («Blurb I» e «Blurb II») a suo tempo scritti (e il I allora pubblicato in quarta di coperta) per Feltrinelli, l’inutile (purtroppo sì, tra il ’76 e il ’77) suicidio di Desideria.
Alberto Arbasino, Fratelli d’Italia, Einaudi
Corriere del Ticino, 28 febbraio 1977
Pubblicato sul Corriere del Ticino, 1977