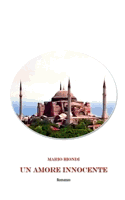Scrive di: Vidiadhar S. Naipaul - Premio Nobel 2001
I. Ritratto (1984)
II. Ritratto (1988)
III. Recensione: “Un’area di tenebra” (1999)
I. Ritratto (1984)
II. Ritratto (1988)
III. Recensione: “Un’area di tenebra” (1999)
© Mario Biondi
Divieto di riproduzione integrale
e obbligo di citazione (per cortesia...)
Statura media, capelli nerissimi, corporatura snella, molto elegante, discretamente blasé, vegetariano. Occhiali di tartaruga, cravatte di colore sempre molto spento, abiti preferibilmente di flanella, atteggiamento controllatamente cordiale ma pronto a trasformarsi nel più anglosassone dei fastidi. Fiuta tabacco, di cui trae presine da bellissime tabacchiere, e colleziona miniature indiane. Autore di diciassette tra romanzi e reportage di viaggio (di cui quattro tradotti in italiano), è stato più volte candidato al premio Nobel. Una parte della critica lo definisce «il più grande scrittore vivente di lingua inglese» o anche «il nuovo Conrad». Altri, invece, gli danno dell'«avvoltoio del Terzo Mondo».A questo complicato e intrigante identikit corrisponde V. S. Naipaul, scrittore, appunto, di lingua inglese e residente in Inghilterra — tra South Kensington e il Wiltshire — ma di origine indiano orientale, nato a Trinidad, nelle Indie Occidentali.
«V» e «S» sono le iniziali di un doppio nome non esattamente facile né da leggere né da pronunciare, ovvero Vidiadhur Surajprasad, di cui la seconda parte significa «saluto al sole» (la prima — per fortuna o per forza — viene dagli amici abbreviata in Vidia). Tutto insieme, un nome che denuncia una nobile discendenza bramina, che però negli anni si deve essere stemperata, se è vero che il nonno di V.S. a un certo punto della sua vita è dovuto emigrare dall'India per andare a lavorare in una piantagione di zucchero a Trinidad.
E a Trinidad, nel 1932, nasce V. S. Naipaul, da un padre giornalista che gli trasmette, insieme al gusto per Dickens, la passione per la carta scritta, per l’osservazione acuta e non conformista della realtà, e per il racconto. A diciassette anni il giovane è già ben determinato a diventare uno scrittore, anzi, uno dei migliori, se non addirittura «il migliore». («Arrivare secondo», afferma in una intervista,«non serve a niente», in accordo con il vecchio motto anglosassone per il quale il secondo sarebbe il primo degli sconfitti). Ottiene una borsa di studio a Oxford e, con un presumibile sospiro di sollievo, abbandona le Piccole Antille, dove è certamente meglio andare in vacanza che passare tutta la vita, trasferendosi definitivamente in Inghilterra, dove compie gli studi universitari, sicuramente con magnifici voti. Si sposa con una bionda inglese, da cui però non vuole figli «per non legarsi troppo alla vita». (In una recente intervista, però, denuncia qualche guaio di natura sentimentale, assenza di famiglia, solitudine e nervosismo, mancanza di veri amici).
Nel 1954, a ventidue anni, comincia a scrivere (perché trova insopportabile l’idea di avere un lavoro, di andare tutti i giorni in un ufficio o in una fabbrica, di dover dipendere da un altro uomo) e nel 1957, a venticinque anni, pubblica il primo libro Il massaggio mistico (in Italia, Mondadori, 1966), presto seguito dal romanzo Una casa per il signor Bisvas (ancora Mondadori, 1964). Già in quest'ultimo — che è ambientato a Trinidad e racconta con amara ironia le vicende di una famiglia immigrata dall’India e che ha messo le mani sopra una vecchia, magnifica dimora, trasformandola in brevissimo tempo in una catapecchia farraginosa e indecorosa —, risultano chiaramente decifrabili gli elementi fondamentali della poetica di Naipaul, ovvero della sua visione della storia: il Terzo Mondo, il suo assoluto bisogno di civiltà (quella occidentale, naturalmente) e al tempo stesso la sua totale incapacità di padroneggiare la stessa, assunta come modello inevitabile ma esterno, impossibile da fare culturalmente propria e quindi solamente da consumare fino in fondo, in un rapidissimo processo di deterioramento e distruzione.
Una poetica destinata implacabilmente a costellare i successivi libri di Naipaul di paesi ex coloniali visti esclusivamente come agglomerati di squallore, di costruzioni fatiscenti — cattedrali nel deserto o bidonville —, di ambizioni feroci quanto approssimative, di continue tentazioni autoritarie, di fallimenti individuali e collettivi. Al punto che diverrebbe d’obbligo: «Odiare l’oppressore, ma diffidare degli oppressi». Naipaul rifiuta sdegnosamente qualsiasi etichetta si tenti di affibbiargli, ma in particolare quella di «cantore del Terzo Mondo», né si sente particolarmente colpito dall’accusa di esserne «l'avvoltoio», come da quella di essere un reazionario. Bisogna essere realisti, dice, e non farsi accecare dai pregiudizi, non credere di più ai propri principi astratti che alla realtà dei fatti. Non farsi travolgere dal mito (peggio: dalla moda) della fuga dalla civiltà, che troppo spesso nasconde penosamente una pura e semplice mancanza di personalità, di identità, che costringe a quella capitolazione irrazionale di fronte all’esotico di maniera che, troppo spesso, significa soltanto droga.
Atteggiamento al quale buona parte della critica reagisce con altrettanta durezza. Di lui è stato scritto: «È un arrogante imperialista, un superficiale, uno scrittore che guarda ai problemi dei paesi sottosviluppati con il sussiego di un occidentale e che dell’India, a esempio, non vede che la miseria e la sporcizia, in cui teme di imbrattare i suoi eleganti scarpini di vacchetta». Oppure: «Sputa sentenze velenose nei confronti dei confratelli, come un uomo dalla pelle nera da poco convertito ai gusti occidentali». Giudizi certamente non teneri ed evidentemente arrivati fino all'orecchio dei soloni del premio Nobel, che ripetutamente lo segnalano ma mai lo premiano.
Un esempio lampante di questo sguardo spietato sul Terzo Mondo è senza dubbio rappresentato dal suo ultimo libro, Tra i credenti, recentissimamente pubblicato dalla Rizzoli, costituito da un lungo reportage di viaggio in quattro paesi islamici — Iran, Pakistan, Malesia e Indonesia — assai diversi tra di loro eppure legati dal duplice denominatore comune di essere paesi emergenti (o in via di sviluppo, o come li si voglia chiamare) e di essere di religione musulmana. Ma dal canto suo Naipaul nega recisamente di voler dare un quadro limitato al Terzo Mondo, etichetta assai generica, applicata a una congerie di paesi profondamente diversi tra di loro, africani, asiatici, sudamericani, comprendenti nel loro numero dei veri e propri subcontinenti, come l`India, lo Zaire, il Brasile, l'Argentina.
«Quello che descrivo», dice, «è il mondo di oggi». Infatti, il suo ultimo romanzo — Alla curva del fiume (Rizzoli, 1982), ambientato in un paese africano in cui si può riconoscere lo Zaire (ex Congo Belga) del presidente Mobutu — inizia con le parole: «Il mondo è quello che è...» e presenta una serie di personaggi tipici dello sradicamento terzomondista, del genere specifico, tuttavia, che non fa più riferimento agli sbandati e ai relitti umani dell’epoca coloniale (come sono tanti dei personaggi di Joseph Conrad), ma a quelli immediatamente prodotti dal trambusto della decolonizzazione. Figli, quelli, del romanticismo; figli, questi ultimi, del crollo delle ideologie.
«Il mondo è quello che è», scrive Naipaul iniziando il suo romanzo e subito dopo aggiunge: «Non c'è posto per chi si lascia vincere dall'inerzia, per chi non ha ambizioni». Ma il Lord Jim di Joseph Conrad non ha nulla a che fare con la categoria delle persone così motivate. Diverso il loro entusiasmo, diverso il loro mistero, diversa la loro disperazione, diversa la loro tragedia. E del resto Naipaul rifiuta l’accostamento a Conrad, così come, del resto — da scrittore di autentico rango — rifiuta l'accostamento a qualsiasi altro autore. Non si riconosce allievo di nessuno e nei confronti di nessuno si sente in debito.
I migliori di tutti i tempi, secondo lui, sono stati Shakespeare, Gogol, Ibsen, Proust, Balzac, Molière e Turgenev. Il problema, semmai, è diventare uno dei «migliori». Bravi anche Dickens e Thomas Mann. Di nessun interesse James Joyce. Fintamente semplice e spaventosamente verboso Hemingway. Somerset Maugham, dal canto suo, pur dovendoglisi riconoscere il merito di avere educato una generazione di lettori a nuovi canoni di lettura e di comportamento, scriveva con i piedi. In sostanza e in conclusione, secondo Naipaul, ci sarebbero pochissime opere di prim'ordine, e leggere un libro fino in fondo risulta francamente difficilissimo.Non è certamente un caso che nella sua bibliografia compaia un pamphlet intitolato: Che male c’è a essere snob?
(Amica, 29 maggio 1984)
II.
«Nuovo Conrad» o «avvoltoio del Terzo Mondo»? Dilemma dai corni piuttosto divaricati quello in cui si dibatte la critica di lingua inglese nei confronti del cinquantaseienne Vidiadhar Surajprasad Naipaul, scrittore nato in India, cresciuto a Trinidad e formatosi in Inghilterra. Con una certa tendenza a preferire il secondo (tra i due corni) e a esagerare: «È un arrogante imperialista, un superficiale», uno che, nel presunto fango del Terzo mondo, «...teme di imbrattare i suoi eleganti scarpini di vacchetta». «Sputa sentenze velenose nei confronti dei confratelli». E simili. Ma lui non se ne dà per inteso. Che male c’è a essere snob? si è infatti chiesto in un suo titolo. Dunque — riferiscono le cronache giornalistiche — via con gli atteggiamenti blasé, le delicate tabacchiere (da naso), le miniature indiane, il regime vegetariano.
E via con un’imponente bibliografia — narrativa, saggistica e di viaggio — che lo ha fatto ripetute volte candidare al Premio Nobel, ma che, soprattutto, smentisce senza possibilità di dubbio l’appellativo di «nuovo Conrad», usato in particolare dai recensori del romanzo Alla curva del fiume (Rizzoli, 1982). Una cosa era la perdizione mistica nell’esotico degli sbandati conradiani, frutto dell’epoca coloniale (Lord Jim per tutti), e un’altra completamente diversa l’autoannullamento dei relitti umani prodotti dal trambusto della decolonizzazione. Figli, quelli, del romanticismo, e questi della crisi delle ideologie. Quanto ad «avvoltoio del Terzo Mondo», be’, il testo del reportage intitolato Tra i credenti, ovvero tra i musulmani di Iran, Pakistan, Malesia e Indonesia (Rizzoli, 1983) era abbastanza impressionante. «Osservatore spietato» sarà meglio, ma il senso è quello.
Splendido narratore, invece, in almeno due dei racconti che compongono la raccolta Una bandiera sull’isola (Rizzoli, 1984), quelli che — con intensi effetti di comicità — hanno come quadro la casa degli ultrainglesi affittacamere Cooksey, su cui si abbatte tutto l’implacabile disdegno che Naipaul esibisce sempre nei confronti della banalità piccolo borghese, sia essa terzomondista o anglosassone. Infaticabile cantore dello spleen, della noia esistenziale, della banalità (e bruttezza) del presente nei confronti del mitizzato passato, Naipaul ripete con toni più accigliati che mai il leit motiv della propria poetica nel suo ultimo libro, L’enigma dell’arrivo. Romanzo, lo definisce la copertina, ma sarà forse più proprio parlare di «memoria». Memoria di un certo periodo vissuto nella campagna inglese, in una grande tenuta nobiliare in via di lottizzazione, e dei sottili legami che questo periodo connettono con altri momenti della vita dell’autore, con suoi viaggi, con l’elaborazione di sue opere, ma in particolare con la sua scoperta dell’Inghilterra (e con l’abbandono della nativa Trinidad) avvenuta all’età di diciotto anni per effetto della concessione di una borsa di studio.
Movente originario dell’ispirazione sarebbe stato in maniera piuttosto criptica la visione di un omonimo quadro di Giorgio De Chirico (in copertina), con il suo spirito di classicità mediterranea. Spirito che anima anche South Wind, romanzo di cui l’autore non leggerà mai più del primo capitolo, ma che, consigliatogli da un insegnante, ha finalmente trovato in una libreria di New York nel corso del favoloso primo viaggio adolescenziale dall’estrema periferia del Commonwealth al cuore dell’Inghilterra. (South Wind, sarà opportuno ricordare, si svolge in una mitica isola di nome Nepenthe, che in realtà è Capri, ed è dunque un peccato che i traduttori e redattori italiani non abbiano ritenuto opportuno avvertire in qualche modo il lettore che si tratta di un romanzo ambientato nel nostro paese, dovuto alla penna di Norman Douglas e intitolato — qui da noi — Vento del Sud.)
Come poi da un quadro visto riprodotto, da un libro quasi non letto e da una prima versione di racconto mai completata ma comunque totalmente diversa, l’autore sia passato alla ponderosa struttura di L’enigma dell’arrivo, il lettore farà una fatica veramente strenua per capirlo. Sempre tanto spleen. Invincibile, inguaribile. Neanche nella campagna inglese quasi nulla sembra andare più bene. Non chi vi abita, non chi vi lavora, non i vicini, non il mungitore, non la moglie fedifraga mancata, non il ragazzino, non i commercianti, non le piante, non i fiori, non le opere di miglioria, non — neanche quello — il cupo delitto che vi si consuma. Niente. Come a Trinidad, come ovunque nel mondo. Se mai un giorno V. S. Naipaul vincerà il Premio Nobel*, c’è da temere che ne rimarrà deluso: potrebbe scoprire che non è più quello di una volta.
Insieme a questo libro la Mondadori ripresenta anche la prima opera di Naipaul da essa stessa pubblicata in Italia nel ’64, Una casa per il signor Biswas, imponente romanzo amaramente ironico e a sfondo autobiografico, centrato sul degrado (naturalmente) che una famiglia neoarrivata dall’India a Trinidad riesce a provocare in una vecchia ed elegante dimora.
(Il giornale, 12 giugno 1988)
* [Ottobre 2001] Il Premio Nobel gli è finalmente stato assegnato (vive felicitazioni). I giornali riferiscono che non avrebbe risposto di persona alla telefonata che glielo annunciava, ma avrebbe mandato all'apparecchio la moglie...
III.
Vidiadhar S. Naipaul può essere uno degli scrittori più irritanti del mondo: lo sa e sembra tenerci moltissimo. Il suo inglese è smagliante, il fraseggio terso e nervoso, ma quanta albagia! Lo scrittore, anglicizzato fino al midollo, non può soffrire le sue origini indiane e la terra da cui partì tanti anni fa suo nonno per andare a far fortuna a Trinidad. Non c'è praticamente suo libro che non grondi di questo disprezzo: gli indiani sono arretrati, confusionari, sporchi, neghittosi, e chi più ne ha più ne metta. Nessuna indagine seria sulla lunga e tormentata storia del paese, soggetto a tante e pesanti dominazioni, nessuna vera riflessione sulla frammentata diversità culturale. Per il fortunato Naipaul (la cui fortuna è stata costruita dall'intraprendente nonno emigrato!) gli indiani sono così, sono sempre stati così, saranno sempre così. Gli inglesi, invece… Ah, se non avessero lasciato decadere lo spirito imperiale che li ha portati a conquistare mezzo mondo e, dentro di esso, l'India!
Tra i libri più irritanti di questo autore sembra dover essere annoverato Un'area di tenebra, risalente ai primi anni Sessanta, in cui Naipaul raccontò il suo primo impatto con la terra d'origine: un vero orrore al di là di ogni aspettativa, da vergognarsi, e via deprecando. Per un buon terzo di libro l'irritazione del lettore rasenta l'indignazione. Poi Naipaul visita il Kashmir: dopo averlo guardato ben bene con il solito naso arricciato, si ricorda finalmente di essere un uomo e non un semidio, e comincia a vivere da uomo tra gli uomini. Il risultato è una serie di pagine indimenticabili. Nell'ultima parte, però, ricominciano sentenziosità anti indiana e schizzinosità, fino all'agghiacciante visita al povero villaggio da cui era partito il nonno in cerca di fortuna. Agghiacciante, si badi bene, non già per la miseria del luogo e della buonissima gente, ma per il tono di algido disprezzo con cui Naipaul la affronta e pianta in asso. Basta il centinaio di splendide pagine sul Kashmir a porre riparo al sentore di colonialismo e razzismo che trasuda da tutte le altre?
V. S. Naipaul, Un'area di tenebra, Adelphi, pp. 323
(Letture)
«V» e «S» sono le iniziali di un doppio nome non esattamente facile né da leggere né da pronunciare, ovvero Vidiadhur Surajprasad, di cui la seconda parte significa «saluto al sole» (la prima — per fortuna o per forza — viene dagli amici abbreviata in Vidia). Tutto insieme, un nome che denuncia una nobile discendenza bramina, che però negli anni si deve essere stemperata, se è vero che il nonno di V.S. a un certo punto della sua vita è dovuto emigrare dall'India per andare a lavorare in una piantagione di zucchero a Trinidad.
E a Trinidad, nel 1932, nasce V. S. Naipaul, da un padre giornalista che gli trasmette, insieme al gusto per Dickens, la passione per la carta scritta, per l’osservazione acuta e non conformista della realtà, e per il racconto. A diciassette anni il giovane è già ben determinato a diventare uno scrittore, anzi, uno dei migliori, se non addirittura «il migliore». («Arrivare secondo», afferma in una intervista,«non serve a niente», in accordo con il vecchio motto anglosassone per il quale il secondo sarebbe il primo degli sconfitti). Ottiene una borsa di studio a Oxford e, con un presumibile sospiro di sollievo, abbandona le Piccole Antille, dove è certamente meglio andare in vacanza che passare tutta la vita, trasferendosi definitivamente in Inghilterra, dove compie gli studi universitari, sicuramente con magnifici voti. Si sposa con una bionda inglese, da cui però non vuole figli «per non legarsi troppo alla vita». (In una recente intervista, però, denuncia qualche guaio di natura sentimentale, assenza di famiglia, solitudine e nervosismo, mancanza di veri amici).
Nel 1954, a ventidue anni, comincia a scrivere (perché trova insopportabile l’idea di avere un lavoro, di andare tutti i giorni in un ufficio o in una fabbrica, di dover dipendere da un altro uomo) e nel 1957, a venticinque anni, pubblica il primo libro Il massaggio mistico (in Italia, Mondadori, 1966), presto seguito dal romanzo Una casa per il signor Bisvas (ancora Mondadori, 1964). Già in quest'ultimo — che è ambientato a Trinidad e racconta con amara ironia le vicende di una famiglia immigrata dall’India e che ha messo le mani sopra una vecchia, magnifica dimora, trasformandola in brevissimo tempo in una catapecchia farraginosa e indecorosa —, risultano chiaramente decifrabili gli elementi fondamentali della poetica di Naipaul, ovvero della sua visione della storia: il Terzo Mondo, il suo assoluto bisogno di civiltà (quella occidentale, naturalmente) e al tempo stesso la sua totale incapacità di padroneggiare la stessa, assunta come modello inevitabile ma esterno, impossibile da fare culturalmente propria e quindi solamente da consumare fino in fondo, in un rapidissimo processo di deterioramento e distruzione.
Una poetica destinata implacabilmente a costellare i successivi libri di Naipaul di paesi ex coloniali visti esclusivamente come agglomerati di squallore, di costruzioni fatiscenti — cattedrali nel deserto o bidonville —, di ambizioni feroci quanto approssimative, di continue tentazioni autoritarie, di fallimenti individuali e collettivi. Al punto che diverrebbe d’obbligo: «Odiare l’oppressore, ma diffidare degli oppressi». Naipaul rifiuta sdegnosamente qualsiasi etichetta si tenti di affibbiargli, ma in particolare quella di «cantore del Terzo Mondo», né si sente particolarmente colpito dall’accusa di esserne «l'avvoltoio», come da quella di essere un reazionario. Bisogna essere realisti, dice, e non farsi accecare dai pregiudizi, non credere di più ai propri principi astratti che alla realtà dei fatti. Non farsi travolgere dal mito (peggio: dalla moda) della fuga dalla civiltà, che troppo spesso nasconde penosamente una pura e semplice mancanza di personalità, di identità, che costringe a quella capitolazione irrazionale di fronte all’esotico di maniera che, troppo spesso, significa soltanto droga.
Atteggiamento al quale buona parte della critica reagisce con altrettanta durezza. Di lui è stato scritto: «È un arrogante imperialista, un superficiale, uno scrittore che guarda ai problemi dei paesi sottosviluppati con il sussiego di un occidentale e che dell’India, a esempio, non vede che la miseria e la sporcizia, in cui teme di imbrattare i suoi eleganti scarpini di vacchetta». Oppure: «Sputa sentenze velenose nei confronti dei confratelli, come un uomo dalla pelle nera da poco convertito ai gusti occidentali». Giudizi certamente non teneri ed evidentemente arrivati fino all'orecchio dei soloni del premio Nobel, che ripetutamente lo segnalano ma mai lo premiano.
Un esempio lampante di questo sguardo spietato sul Terzo Mondo è senza dubbio rappresentato dal suo ultimo libro, Tra i credenti, recentissimamente pubblicato dalla Rizzoli, costituito da un lungo reportage di viaggio in quattro paesi islamici — Iran, Pakistan, Malesia e Indonesia — assai diversi tra di loro eppure legati dal duplice denominatore comune di essere paesi emergenti (o in via di sviluppo, o come li si voglia chiamare) e di essere di religione musulmana. Ma dal canto suo Naipaul nega recisamente di voler dare un quadro limitato al Terzo Mondo, etichetta assai generica, applicata a una congerie di paesi profondamente diversi tra di loro, africani, asiatici, sudamericani, comprendenti nel loro numero dei veri e propri subcontinenti, come l`India, lo Zaire, il Brasile, l'Argentina.
«Quello che descrivo», dice, «è il mondo di oggi». Infatti, il suo ultimo romanzo — Alla curva del fiume (Rizzoli, 1982), ambientato in un paese africano in cui si può riconoscere lo Zaire (ex Congo Belga) del presidente Mobutu — inizia con le parole: «Il mondo è quello che è...» e presenta una serie di personaggi tipici dello sradicamento terzomondista, del genere specifico, tuttavia, che non fa più riferimento agli sbandati e ai relitti umani dell’epoca coloniale (come sono tanti dei personaggi di Joseph Conrad), ma a quelli immediatamente prodotti dal trambusto della decolonizzazione. Figli, quelli, del romanticismo; figli, questi ultimi, del crollo delle ideologie.
«Il mondo è quello che è», scrive Naipaul iniziando il suo romanzo e subito dopo aggiunge: «Non c'è posto per chi si lascia vincere dall'inerzia, per chi non ha ambizioni». Ma il Lord Jim di Joseph Conrad non ha nulla a che fare con la categoria delle persone così motivate. Diverso il loro entusiasmo, diverso il loro mistero, diversa la loro disperazione, diversa la loro tragedia. E del resto Naipaul rifiuta l’accostamento a Conrad, così come, del resto — da scrittore di autentico rango — rifiuta l'accostamento a qualsiasi altro autore. Non si riconosce allievo di nessuno e nei confronti di nessuno si sente in debito.
I migliori di tutti i tempi, secondo lui, sono stati Shakespeare, Gogol, Ibsen, Proust, Balzac, Molière e Turgenev. Il problema, semmai, è diventare uno dei «migliori». Bravi anche Dickens e Thomas Mann. Di nessun interesse James Joyce. Fintamente semplice e spaventosamente verboso Hemingway. Somerset Maugham, dal canto suo, pur dovendoglisi riconoscere il merito di avere educato una generazione di lettori a nuovi canoni di lettura e di comportamento, scriveva con i piedi. In sostanza e in conclusione, secondo Naipaul, ci sarebbero pochissime opere di prim'ordine, e leggere un libro fino in fondo risulta francamente difficilissimo.Non è certamente un caso che nella sua bibliografia compaia un pamphlet intitolato: Che male c’è a essere snob?
(Amica, 29 maggio 1984)
II.
«Nuovo Conrad» o «avvoltoio del Terzo Mondo»? Dilemma dai corni piuttosto divaricati quello in cui si dibatte la critica di lingua inglese nei confronti del cinquantaseienne Vidiadhar Surajprasad Naipaul, scrittore nato in India, cresciuto a Trinidad e formatosi in Inghilterra. Con una certa tendenza a preferire il secondo (tra i due corni) e a esagerare: «È un arrogante imperialista, un superficiale», uno che, nel presunto fango del Terzo mondo, «...teme di imbrattare i suoi eleganti scarpini di vacchetta». «Sputa sentenze velenose nei confronti dei confratelli». E simili. Ma lui non se ne dà per inteso. Che male c’è a essere snob? si è infatti chiesto in un suo titolo. Dunque — riferiscono le cronache giornalistiche — via con gli atteggiamenti blasé, le delicate tabacchiere (da naso), le miniature indiane, il regime vegetariano.
E via con un’imponente bibliografia — narrativa, saggistica e di viaggio — che lo ha fatto ripetute volte candidare al Premio Nobel, ma che, soprattutto, smentisce senza possibilità di dubbio l’appellativo di «nuovo Conrad», usato in particolare dai recensori del romanzo Alla curva del fiume (Rizzoli, 1982). Una cosa era la perdizione mistica nell’esotico degli sbandati conradiani, frutto dell’epoca coloniale (Lord Jim per tutti), e un’altra completamente diversa l’autoannullamento dei relitti umani prodotti dal trambusto della decolonizzazione. Figli, quelli, del romanticismo, e questi della crisi delle ideologie. Quanto ad «avvoltoio del Terzo Mondo», be’, il testo del reportage intitolato Tra i credenti, ovvero tra i musulmani di Iran, Pakistan, Malesia e Indonesia (Rizzoli, 1983) era abbastanza impressionante. «Osservatore spietato» sarà meglio, ma il senso è quello.
Splendido narratore, invece, in almeno due dei racconti che compongono la raccolta Una bandiera sull’isola (Rizzoli, 1984), quelli che — con intensi effetti di comicità — hanno come quadro la casa degli ultrainglesi affittacamere Cooksey, su cui si abbatte tutto l’implacabile disdegno che Naipaul esibisce sempre nei confronti della banalità piccolo borghese, sia essa terzomondista o anglosassone. Infaticabile cantore dello spleen, della noia esistenziale, della banalità (e bruttezza) del presente nei confronti del mitizzato passato, Naipaul ripete con toni più accigliati che mai il leit motiv della propria poetica nel suo ultimo libro, L’enigma dell’arrivo. Romanzo, lo definisce la copertina, ma sarà forse più proprio parlare di «memoria». Memoria di un certo periodo vissuto nella campagna inglese, in una grande tenuta nobiliare in via di lottizzazione, e dei sottili legami che questo periodo connettono con altri momenti della vita dell’autore, con suoi viaggi, con l’elaborazione di sue opere, ma in particolare con la sua scoperta dell’Inghilterra (e con l’abbandono della nativa Trinidad) avvenuta all’età di diciotto anni per effetto della concessione di una borsa di studio.
Movente originario dell’ispirazione sarebbe stato in maniera piuttosto criptica la visione di un omonimo quadro di Giorgio De Chirico (in copertina), con il suo spirito di classicità mediterranea. Spirito che anima anche South Wind, romanzo di cui l’autore non leggerà mai più del primo capitolo, ma che, consigliatogli da un insegnante, ha finalmente trovato in una libreria di New York nel corso del favoloso primo viaggio adolescenziale dall’estrema periferia del Commonwealth al cuore dell’Inghilterra. (South Wind, sarà opportuno ricordare, si svolge in una mitica isola di nome Nepenthe, che in realtà è Capri, ed è dunque un peccato che i traduttori e redattori italiani non abbiano ritenuto opportuno avvertire in qualche modo il lettore che si tratta di un romanzo ambientato nel nostro paese, dovuto alla penna di Norman Douglas e intitolato — qui da noi — Vento del Sud.)
Come poi da un quadro visto riprodotto, da un libro quasi non letto e da una prima versione di racconto mai completata ma comunque totalmente diversa, l’autore sia passato alla ponderosa struttura di L’enigma dell’arrivo, il lettore farà una fatica veramente strenua per capirlo. Sempre tanto spleen. Invincibile, inguaribile. Neanche nella campagna inglese quasi nulla sembra andare più bene. Non chi vi abita, non chi vi lavora, non i vicini, non il mungitore, non la moglie fedifraga mancata, non il ragazzino, non i commercianti, non le piante, non i fiori, non le opere di miglioria, non — neanche quello — il cupo delitto che vi si consuma. Niente. Come a Trinidad, come ovunque nel mondo. Se mai un giorno V. S. Naipaul vincerà il Premio Nobel*, c’è da temere che ne rimarrà deluso: potrebbe scoprire che non è più quello di una volta.
Insieme a questo libro la Mondadori ripresenta anche la prima opera di Naipaul da essa stessa pubblicata in Italia nel ’64, Una casa per il signor Biswas, imponente romanzo amaramente ironico e a sfondo autobiografico, centrato sul degrado (naturalmente) che una famiglia neoarrivata dall’India a Trinidad riesce a provocare in una vecchia ed elegante dimora.
(Il giornale, 12 giugno 1988)
* [Ottobre 2001] Il Premio Nobel gli è finalmente stato assegnato (vive felicitazioni). I giornali riferiscono che non avrebbe risposto di persona alla telefonata che glielo annunciava, ma avrebbe mandato all'apparecchio la moglie...
III.
Vidiadhar S. Naipaul può essere uno degli scrittori più irritanti del mondo: lo sa e sembra tenerci moltissimo. Il suo inglese è smagliante, il fraseggio terso e nervoso, ma quanta albagia! Lo scrittore, anglicizzato fino al midollo, non può soffrire le sue origini indiane e la terra da cui partì tanti anni fa suo nonno per andare a far fortuna a Trinidad. Non c'è praticamente suo libro che non grondi di questo disprezzo: gli indiani sono arretrati, confusionari, sporchi, neghittosi, e chi più ne ha più ne metta. Nessuna indagine seria sulla lunga e tormentata storia del paese, soggetto a tante e pesanti dominazioni, nessuna vera riflessione sulla frammentata diversità culturale. Per il fortunato Naipaul (la cui fortuna è stata costruita dall'intraprendente nonno emigrato!) gli indiani sono così, sono sempre stati così, saranno sempre così. Gli inglesi, invece… Ah, se non avessero lasciato decadere lo spirito imperiale che li ha portati a conquistare mezzo mondo e, dentro di esso, l'India!
Tra i libri più irritanti di questo autore sembra dover essere annoverato Un'area di tenebra, risalente ai primi anni Sessanta, in cui Naipaul raccontò il suo primo impatto con la terra d'origine: un vero orrore al di là di ogni aspettativa, da vergognarsi, e via deprecando. Per un buon terzo di libro l'irritazione del lettore rasenta l'indignazione. Poi Naipaul visita il Kashmir: dopo averlo guardato ben bene con il solito naso arricciato, si ricorda finalmente di essere un uomo e non un semidio, e comincia a vivere da uomo tra gli uomini. Il risultato è una serie di pagine indimenticabili. Nell'ultima parte, però, ricominciano sentenziosità anti indiana e schizzinosità, fino all'agghiacciante visita al povero villaggio da cui era partito il nonno in cerca di fortuna. Agghiacciante, si badi bene, non già per la miseria del luogo e della buonissima gente, ma per il tono di algido disprezzo con cui Naipaul la affronta e pianta in asso. Basta il centinaio di splendide pagine sul Kashmir a porre riparo al sentore di colonialismo e razzismo che trasuda da tutte le altre?
V. S. Naipaul, Un'area di tenebra, Adelphi, pp. 323
(Letture)