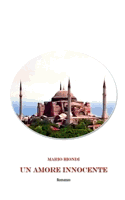Recensione: By the Sea (Sulla riva del mare)
Un scatoletta lignea contenente qualche residuo di “ud” è praticamente tutto quanto di valore riesce a portare con sé un anziano richiedente asilo che sbarca in Gran Bretagna provenendo dalla Tanzania, e più precisamente da Zanzibar, terra di antica cultura persiano-araba. Il protagonista del romanzo Sulla riva del mare del Premio Nobel Abdulrazak Gurnah, nato a Zanzibar e residente nel Regno Unito. Naturalmente alla dogana, da dove per pochissimo non viene rispedito a casa, gli viene sequestrata da un doganiere occhiuto e dotato di naso finissimo.
“Ud-al-qamari”, dice il protagonista. Anzi, precisa, “al-qimari”, come gli ha spiegato l’uomo da cui ha ricevuto quel prezioso materiale, ormai ridotto alle ultime briciole di una trascorsa condizione di vita benestante se non proprio ricca. Non “legno della luna”, quindi, ma legno dello “Khmer”, la ricchissima, potente e raffinata Cambogia dei tempi antichi, da cui a noi sono arrivate le stupefacenti rovine sepolte nella giungla. Giungla di legni davvero belli e preziosi e di gente che li sa lavorare.
L’uomo che ha portato lo “ud” era un mercante di etnia persiana, che ogni anno arrivava regolarmente a Zanzibar per i suoi commerci, portato dai “venti di musim” ovvero “commerciali” (trade winds), gli Alisei, insomma, e poi portato via dai venti altrettanto regolarmente contrari dopo il consueto intervallo di tempo. Un personaggio appena presente nel romanzo, ma destinato ad avervi un’importanza fondamentale quanto sinistra.
Il richiedente asilo si presenta all’autorità britannica con un passaporto intestato a Rajab Shaaban, e l’autorità si accorge in extremis che quell’asilo glielo deve proprio offrire, perché nella sua terra d’origine ha combinato non pochi pasticci ai tempi del cosiddetto Impero e del conseguente sfruttamento coloniale. Era potentissimo, l’Impero britannico, padrone di quasi tutto il meglio e il più grande, come il profugo ha dovuto imparare sui libri scolastici da esso impostigli, anche se con qualche esagerazione, o imprecisione, se è vero che la montagna più alta del mondo, l’Everest, chiusa com’è tra Cina e Nepal, a detto Impero non è mai appartenuta.
Ma Rajab Shaaban non è il suo vero nome, e lo spiega subito al lettore, anche se aspetterà le ultimissime pagine per chiarire come mai abbia usato proprio quello, che in realtà è il nome di un suo acre nemico, divenuto tale proprio per circostanze connesse con gli oscuri traffici del persiano, portatore della raffinata resina e di altre raffinatezze forse non altrettanto profumate ma molto cantate nelle Mille e una notte, il grande romanzo dei popoli persiano-arabi. Un libro che il presunto Mr. Shaaban ha letto con passione, come tanti altri, giù giù fino a Bartleby lo scrivano. È un uomo colto, anche se non vuole assolutamente farlo sapere.
Finge anzi di essere del tutto illetterato e di parlare soltanto pochissime parole di inglese, perché così gli è stato suggerito dal trafficante che gli ha procurato il biglietto di viaggio. Per questo l’autorità britannica, distratta ma in fondo benefica, cerca di metterlo in contatto con un un altro rifugiato dalla sua terra, perché gli faccia da interprete. Ma non ce ne sarà bisogno: Mr. Shaaban decide finalmente che ormai è al sicuro e quindi può smettere di fingere di non conoscere l’inglese.
Latif Mahmud è il nome di quest’uomo che avrebbe dovuto fargli da interprete. “Latif Mahmud, che meraviglia!” esclama Mr. Shaaban. “Lo conosce?” gli chiede l’assistente sociale, esterrefatta quanto deliziata. Oh, altro che se lo conosce. E a quel punto è lui a chiedere di incontrarlo. Così a poco a poco, dai loro ricordi, si intreccia e sviluppa la tortuosa vicenda dei due conterranei costretti all’esilio. Un po’ parenti, addirittura. Ma separati da un odio che… No, non si può raccontare altro.
Romanzo potente, Sulla riva del mare — già pubblicato in Italia e poi frettolosamente abbandonato (capita un po’ troppo spesso, signori editori!), ma per fortuna ricuperato con ottima tempistica da La Nave di Teseo — composto in un inglese terso e precisissimo: si sa, con la loro lingua i colonialisti possono giocare e sperimentare fin che vogliono, ma i colonizzati no, loro la devono conoscere e usare bene, altrimenti sono guai. Se però i primi si possono permettere escursioni nel loro gaelico o genericamente celtico d’origine, be’ allora il colonizzato Gurnah rivendica il diritto di usare il suo arabo-persiano nativo senza metterlo tra virgolette o in corsivo.
Non so quanto sia davvero emblematico delle vicende dell’attuale emigrazione — abbastanza poco, mi pare —, e d’altra parte non sembra crederlo nemmeno l’autore, al quale è perfettamente chiaro quanto al suo insediamento in un altro mondo sia stata propedeutica l’elevata condizione sociale della sua famiglia. Ma è senz’altro emblematico, e in maniera sontuosa, della straziante nostalgia delle proprie origini da cui l’emigrato sarà costretto ad essere afflitto per tutta la vita. Come lo sono i due coprotagonisti del romanzo. Hanno abbandonato Zanzibar, ma, a dispetto di fatiche vissute e pene sofferte, l’hanno nel cuore, con la sua storia, con i suoi colori, sapori e profumi.
Come quello dello “ud”, un profumo davvero affascinante, ma che, spentosi il bastoncino o il piccolo cono di incenso, si lascia dietro un certo senso di stantio, di vecchio, che fatica a dissiparsi. L’odore, forse, dell’infezione da cui esso è stato prodotto, come i due protagonisti lo sono della dissoluzione del loro vecchio mondo. Non so se fosse questa l’intenzione programmatica del bravissimo narratore, ma è quanto egli fa avvertire dal protagonista nelle ultime righe del romanzo.