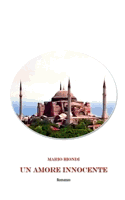Scrive di: Janet Frame
I. Ritratto e Recensione di “Dentro il muro” (1990)
II. Recensione di “Gridano i gufi” (1994)
I. Ritratto e Recensione di “Dentro il muro” (1990)
II. Recensione di “Gridano i gufi” (1994)
© Mario Biondi
Divieto di riproduzione integrale
e obbligo di citazione (per cortesia...)
L’inferno di una clinica psichiatrica. Un’istituzione sanitaria dove «mille donne dipendono da un dottore e mezzo». Ovvero: «un problema di calcolo umano rimasto senza soluzione». Un universo dove si vegeta come animali, dove al mattino gli abiti vengono restituiti alla rinfusa, e se una disgraziata scopre di essere rimasta senza mutande, viene brutalmente invitata a non fare storie, tanto di maschi lì attorno non ce n’è. E se capita che abbia bisogno di un assorbente igienico, senza tante cerimonie la si invita a «metterci un tappo» e a smetterla di seccare. L’infelice così trattata decade inesorabilmente dalla condizione di «persona» a quella di «paziente». Senza possibilità di riscatto a meno che non si verifichi un miracolo.
In un simile universo a poco a poco l’«assistita» viene spogliata di ogni personalità, rischiando ogni mattino di sentire chiamare il proprio nome per prepararsi al terrore del «trattamento».
L’elettroshock. Un surrogato della sedia elettrica. Per «il suo bene», naturalmente. Una bolgia di dannate dove di quando in quando capita di veder aggirarsi una povera anima particolarmente in pena, lo sguardo spento, un sorriso atono sulle labbra, i capelli rasati, un foulard a fiori che più che nascondere denuncia al mondo la presenza di una ferita irreparabile. Una donna sottoposta a lobotomia. Per «il suo bene». Per farla diventare non più una «paziente» ma di nuovo una «persona».
In tale universo di orrore si trova a precipitare, ventunenne, nel ’46, una studentessa universitaria neozelandese, insegnante in prova. Diagnosi: «schizofrenia». In pochissimo tempo la giovane, Janet Frame, si vede spalancare davanti un baratro dal quale non soltanto le risulta impossibile fuggire, ma da cui si sente addirittura inesorabilmente richiamare e risucchiare ogni volta che le viene concesso un periodo di licenza, di prova a vivere in mezzo agli altri. Lei ormai sembra saper vivere soltanto con Shakespeare, con Rilke, con Coleridge. Con la gente comune ha disimparato a stare. L’unica realtà che sa affrontare è il secluso universo della casa di cura. Vi vive otto anni, dai ventuno fino alla soglia dei trenta, subisce duecento elettroshock, arriva sulla soglia della lobotomia. Finché per lei il miracolo si verifica.
È la vicenda che la stessa Janet Frame, divenuta la più importante scrittrice neozelandese vivente, racconta senza un briciolo di reticenza ma con grande sapienza letteraria ed elevato spirito poetico - oltre che nel magnifico inglese che sanno impiegare gli scrittori delle ex colonie britanniche, da Doris Lessing a Robertson Davies a Peter Carey - nel romanzo Dentro il muro. Una storia che fa letteralmente mancare il fiato. Un autentico horror, mandato in libreria in questi giorni da Interno Giallo. L’autrice-protagonista, celata sotto il nome fittizio di Istina Mavet, passa da una casa di cura a un’altra, da un padiglione all’altro, da un girone dell’inferno al successivo, in una spietata altalena di esperimenti terapeutici che inevitabilmente riconduce alla pratica dell’elettroshock.
«I miei anni tra i venti e i trenta», ha dichiarato in un’intervista, «sono scappati via senza lasciare tracce, come se io non esistessi.» Anni che vive sordidamente sudicia, affamata, umiliata. Il suo fisico reagisce all’abnormità della situazione con altre abnormità. Le cresce la barba e lei cerca di tagliarsela con limette di carta vetrata. Passa settimane e settimane in isolamento, parlando solamente con un topolino cui dà il nome di signor Griffiths. Ma la vita, fuori dall’isolamento, è talmente terribile che preferisce stare così segregata, sola con se stessa, come un animale in una fetida gabbia. Sente la mente, insieme al fisico, avvicinarsi sempre più al limite estremo di rottura. Eppure è convinta che in qualche modo tutto ciò sia giusto. «malata», non sa vivere con gli altri, il mondo le fa paura. Soltanto in qualche raro momento di lucidità arriva a sospettare che la diagnosi sia stata sbagliata, con il suo tacito consenso. A pensare di non essere affatto schizofrenica.
Dentro il muro racconta con agghiacciante realismo la parte centrale di una vicenda umana su cui Janet Frame è poi tornata per esteso nei tre volumi dell’autobiografia che, divenuti un mito in Nuova Zelanda e acclamati nel mondo anglosassone come opera di straordinario livello artistico oltre che umano, vengono probabilmente soltanto ora scoperti nel loro giusto valore nelle altre lingue in conseguenza dell’interesse suscitato al recente festival di Cannes dal film televisivo in tre puntate che da essi ha tratto la giovane regista Jane Campion, anch’essa neozelandese.
Una storia che - nella prima parte, To the Is-land - comincia come mille altre. Una modestissima famiglia piccolo borghese. Un padre ferroviere, uomo irresoluto che cerca di nascondere la propria debolezza sotto un ruvido strato di rigidezza. Una madre, animata da singolari impulsi poetici, che vive nel mito della famiglia. La morte per annegamento della prima figlia, un sospetto di malattia mentale per il secondogenito. Normali interni di famiglia predestinata alla tragedia.
Da simile contesto emerge una piccola artista in fieri, una personcina abituata a vivere un proprio privatissimo rapporto con il linguaggio, che ama stravolgere a proprio piacimento e secondo propri insondabili fini. Un’aspirante poetessa che sembra destinata a fare la gioia dei frustrati slanci poetici materni. Nulla, quando ventenne lascia la famiglia per andare all’università e avviarsi a una normale carriera di insegnante con propensioni poetiche, lascia presagire l’abisso che di lì a poco tempo la chiamerà a sé.
Difficoltà di rapporto con gli altri, problemi di comunicazione ulteriormente aggravati dalle disagiate condizioni economiche. La ragazza studia con esiti brillanti, ma, malnutrita nel fisico come nei sentimenti, la sua mente comincia a vacillare. L’«Immaginazione» (nella teorizzazione che la Frame trova elaborata da Coleridge nella Biographia Literaria) inizia a prevalere sulla «Realtà». Janet lavora con fervore, pubblica le prime poesie, il primo racconto, ma in lei comincia a manifestarsi qualche segno di equilibrio malcerto. L’insegnamento viene abbandonato senza spiegazioni. E un giorno arriva un goffo tentativo di suicidio. La pace eterna cercata nientemeno che in un tubetto di Aspro. L’esito è semplicemente un’emorragia, accompagnata da forti malesseri di natura gastrica. Niente di peggio, a prima vista. Anzi, caso mai una straordinaria felicità nel ritrovarsi viva. L’apparente possibilità di uscire dal tunnel della depressione. Trovato nuovo entusiasmo, Janet si confida con un insegnante che ha fatto presa nei suoi sentimenti. Un bel giovane dotto e moderno, che esegue Schubert al piano e ama riempirsi la bocca con confuse citazioni da Freud e dalla sua scuola psicoanalitica. Ed è da lui, con le migliori intenzioni, con il più comprensivo dei sorrisi, che inizia il disastro. «Sei stanca», le dice più o meno. «Non sarà il caso di farsi ricoverare per un po’?»
Quando Janet si rende conto che il ricovero è avvenuto in un padiglione per malati di mente, è troppo tardi. Dopo qualche tempo arriva la diagnosi. Schizofrenia. La giovane la prende alla leggera. «Ho la schizzomania», spiega più o meno a casa, scherzando e cedendo ancora una volta all’irresistibile gusto di stravolgere le parole. Schizofrenia. Che cosa sarà mai? Si mette a scartabellare dubbie pubblicazioni di taglio parapsicoanalitico. Dalle confuse e agitate letture deduce che la paura del dentista sarebbe un sintomo accertato di schizofrenia, in quanto generata dal senso di colpa nei confronti della masturbazione. Masturbazione? Personalmente (scrive con disarmante candore nella seconda parte dell’autobiografia, An angel at my table) fino a quel momento non conosceva nemmeno il significato dell’espressione. È una pratica di cui si dichiara «innocente». Però ha i denti malamente cariati e ha effettivamente una paura dannata di andare dal dentista. Dunque il teorema si chiude, non c’è più dubbio. È schizofrenica. Quindi hanno ragione di rinchiuderla per curarla.
La vita di Janet procede così, da anima reietta, fuggendo dall’insegnamento, rinunciando all’università, rifugiandosi nei lavori più umili, infermiera, serva, sguattera, dentro e fuori da case di cura. A una cosa sola la giovane non rinuncia. Alla letteratura. Ai suoi poeti. A scrivere. Fino al colpo finale, provocato nella sua povera mente dalla morte per annegamento di una seconda sorella, la più piccola, la più amata. la crisi definitiva, l’abisso, i padiglioni per incurabili, i duecento elettroshock, la prospettiva di passare tutta la vita segregata.
Fino al penultimo atto. Nella sua coazione ad avere una famiglia perfetta, la madre decide finalmente di non poter accettare di avere una figlia così fuori dall’ordinario. Conclude che hanno ragione i medici, che effettivamente la soluzione potrebbe risiedere nella costruzione di «una nuova personalità» per Janet. Firma il documento con cui autorizza che le venga eseguita una lobotomia.
Janet è di fronte alla condanna finale. La sua mente è ossessionata dalla visione dell’amica più cara, che è appena stata sottoposta alla medesima mutilazione. Un essere irrimediabilmente straziato. Guarda verso il fondo del precipizio e scopre che è senza fine. Si sente disperata. Quando vede arrivare un nuovo medico di cui le sembra di poter avere fiducia, commette l’inaudita infrazione di interpellarlo. «Che cosa ne pensa?» gli chiede. «Di che cosa?» replica il medico. Della lobotomia, naturalmente.
Ed ecco il miracolo. «Lobotomia?» dice il medico. No, non crede che sia necessaria. Non lo crede affatto. Piuttosto, Janet ha sentito del premio? Quale premio? Il premio letterario che è stato appena assegnato al suo primo libro di racconti, The lagoon. Janet non ricordava quasi nemmeno di averlo scritto, di essere riuscita a pubblicarlo. L’unica recensione che ne ha visto, con luminosa e supponente miopia dichiarava: «Robetta che abbiamo già letto anche troppo spesso».
Attraverso quella «robetta» stava cercando di esprimere il proprio insondabile male una giovane donna destinata a diventare una delle più eminenti scrittrici in lingua inglese del nostro tempo. A quella «robetta» e al premio a essa riconosciuto il mondo letterario internazionale deve la salvezza di un proprio rispettabilissimo esponente. Janet Frame vi deve semplicemente la ragione e la vita.
An Angel at my Table si chiude sulla «liberazione» dalla condizione di pazza. Nella terza parte dell’autobiografia - The Envoy from Mirror City - la vita riprende faticosamente il suo corso. Una borsa di studio consente a Janet Frame di venire in Europa, dove, ormai non più nell’alba della vita, conosce finalmente per la prima volta l’amore fisico, raccontato con disincantata e sottile capacità di autoironia. Ed è nel londinese Maudesley Hospital che la diagnosi di un tempo viene definitivamente smentita. Janet Frame non è mai stata schizofrenica.
Ora, sessantaseienne, vive da sola in una fattoria in aperta campagna, in mezzo a un folcloristico disordine di cui probabilmente soltanto lei coglie la logica. I diritti d’autore e le borse di studio le consentono un’esistenza dignitosa. Non sollecita le visite, anche se le riceve con amabile cortesia. Non ama le interviste, anche se vi si sottopone di buon grado. Per farsi compagnia usa quel pianoforte che ha imparato a suonare da autodidatta e che compare spesso nelle sue storie. I libri li compone su una macchina per scrivere portatile, antiquata, anche se non disprezza il computer. Lo ha da anni. Lo sfida a strenue tenzoni di scacchi. Oppure ci si esercita in quel Corso di Simulazione di Volo che ha inserito nel romanzo The Carpathians. Per vincere la «paura di volare», dice.
Una volta «fuori», le hanno ossessivamente prescritto le infermiere delle diverse case di cura, per riprendere a vivere una vita normale dovrai assolutamente dimenticare tutto ciò che hai visto e vissuto qui dentro. Troppo difficile, sembra replicare Janet Frame attraverso i propri scritti (sette romanzi, oltre ai racconti, alle poesie e all’autobiografia). Dal male di avere vissuto una simile esperienza è con ogni probabilità impossibile guarire davvero.
Dentro il muro, Ed. Interno giallo
II.
Nuova Zelanda, anni Quaranta-Cinquanta. Una clinica psichiatrica femminile. Un inferno. Un universo in cui a poco a poco si viene spogliate di ogni personalità, rischiando continuamente di sentirsi chiamare per prepararsi al terrore dell'elettroshock.
Una bolgia dove di quando in quando capita di vedere un'anima particolarmente in pena, lo sguardo spento, un sorriso atono, un foulard che denuncia la presenza di una ferita irreparabile: una donna sottoposta a lobotomia. In tale orrore si trova a precipitare nel '46, ventunenne, una studentessa. Diagnosi: «schizofrenia» .
In pochissimo tempo la giovane, Janet Frame, si vede spalancare davanti un baratro dal quale non soltanto le risulta impossibile fuggire ma in cui si sente addirittura risucchiare. Con i suoi simili ha disimparato a stare, ormai sembra saper vivere soltanto con Shakespeare, Rilke, Coleridge. In casa di cura vive otto anni, subisce duecento elettroshock, arriva sulla soglia della lobotomia. Finché una sorta di miracolo la salva. Un medico intelligente combinato con un premio letterario.
Una volta «fuori» , le hanno più volte prescritto che, per riprendere una vita normale, dovrà assolutamente dimenticare tutto ci ò che ha visto. Troppo difficile, sembra replicare lei. Dal male di avere vissuto una simile esperienza è con ogni probabilità impossibile guarire fino in fondo. Infatti, divenuta la più importante scrittrice neozelandese vivente, vi torna sopra con un’insistenza quasi ossessiva, sia pure con grosse varianti narrative. L'ha raccontata in Dentro il muro e nei tre volumi dell'autobiografÏa (da cui Jane Campion, prima di Lezioni di piano, ha tratto il film Un angelo alla mia tavola) e lo fa ancora una volta nello splendido Gridano i gufi (da La tempesta), certamente uno dei suoi migliori conseguimenti, forse il più alto.
Una storia che (nelle diverse versioni narrative offerte da Janet Frame fa letteralmente mancare il fiato, raccontata senza un briciolo di reticenza ma con grande sapienza letteraria ed elevato spirito poetico. Una modesta famiglia piccolissimo borghese. Un padre ferroviere, uomo irresoluto, fintamente rigido. Una madre animata da singolari slanci poetici. La morte tragica della prima figlia, un sospetto di malattia mentale per il secondogenito. Da simile contesto emerge una piccola artista in potenza, una persona abituata a vivere un proprio privatissimo rapporto con il linguaggio, che ama stravolgere secondo propri fini insondabili. Un'aspirante poetessa malata di poesia. Invece, i suoi problemi di comunicazione, gli stravolgimenti del linguaggio, vengono scambiati per schizofrenia. E come tale curati fino al limite della lobotomia. Una storia stupefacente, da leggere, meditare e non dimenticare mai. Ma, a proposito di «poesia», viene da chiedersi: che fine ha fatto in Italia? Dove sono i poeti? Presi per schizofrenici anche loro?
Sottoposti a elettroshock, minacciati di lobotomia? Dove sono finiti i testi poetici contemporanei italiani? I soldi guadagnati dagli editori con le formiche che si incazzano e con quelli che sperano che se la cavano, non si diceva che sarebbero serviti per pubblicare libri di alta qualità, difficili e dunque costosi?
E non appartengono a tale schiera, in primissima istanza, i testi dei poeti? Dove sono? Dovremo concludere malinconicamente che le formiche incazzate se la sono cavata, portando a casa almeno il pancreas, e che invece i bravi poeti sono tutti rinchiusi in attesa di lobotomia?
Gridano i gufi, Guanda (Corriere della sera, 8 giugno 1994)
In un simile universo a poco a poco l’«assistita» viene spogliata di ogni personalità, rischiando ogni mattino di sentire chiamare il proprio nome per prepararsi al terrore del «trattamento».
L’elettroshock. Un surrogato della sedia elettrica. Per «il suo bene», naturalmente. Una bolgia di dannate dove di quando in quando capita di veder aggirarsi una povera anima particolarmente in pena, lo sguardo spento, un sorriso atono sulle labbra, i capelli rasati, un foulard a fiori che più che nascondere denuncia al mondo la presenza di una ferita irreparabile. Una donna sottoposta a lobotomia. Per «il suo bene». Per farla diventare non più una «paziente» ma di nuovo una «persona».
In tale universo di orrore si trova a precipitare, ventunenne, nel ’46, una studentessa universitaria neozelandese, insegnante in prova. Diagnosi: «schizofrenia». In pochissimo tempo la giovane, Janet Frame, si vede spalancare davanti un baratro dal quale non soltanto le risulta impossibile fuggire, ma da cui si sente addirittura inesorabilmente richiamare e risucchiare ogni volta che le viene concesso un periodo di licenza, di prova a vivere in mezzo agli altri. Lei ormai sembra saper vivere soltanto con Shakespeare, con Rilke, con Coleridge. Con la gente comune ha disimparato a stare. L’unica realtà che sa affrontare è il secluso universo della casa di cura. Vi vive otto anni, dai ventuno fino alla soglia dei trenta, subisce duecento elettroshock, arriva sulla soglia della lobotomia. Finché per lei il miracolo si verifica.
È la vicenda che la stessa Janet Frame, divenuta la più importante scrittrice neozelandese vivente, racconta senza un briciolo di reticenza ma con grande sapienza letteraria ed elevato spirito poetico - oltre che nel magnifico inglese che sanno impiegare gli scrittori delle ex colonie britanniche, da Doris Lessing a Robertson Davies a Peter Carey - nel romanzo Dentro il muro. Una storia che fa letteralmente mancare il fiato. Un autentico horror, mandato in libreria in questi giorni da Interno Giallo. L’autrice-protagonista, celata sotto il nome fittizio di Istina Mavet, passa da una casa di cura a un’altra, da un padiglione all’altro, da un girone dell’inferno al successivo, in una spietata altalena di esperimenti terapeutici che inevitabilmente riconduce alla pratica dell’elettroshock.
«I miei anni tra i venti e i trenta», ha dichiarato in un’intervista, «sono scappati via senza lasciare tracce, come se io non esistessi.» Anni che vive sordidamente sudicia, affamata, umiliata. Il suo fisico reagisce all’abnormità della situazione con altre abnormità. Le cresce la barba e lei cerca di tagliarsela con limette di carta vetrata. Passa settimane e settimane in isolamento, parlando solamente con un topolino cui dà il nome di signor Griffiths. Ma la vita, fuori dall’isolamento, è talmente terribile che preferisce stare così segregata, sola con se stessa, come un animale in una fetida gabbia. Sente la mente, insieme al fisico, avvicinarsi sempre più al limite estremo di rottura. Eppure è convinta che in qualche modo tutto ciò sia giusto. «malata», non sa vivere con gli altri, il mondo le fa paura. Soltanto in qualche raro momento di lucidità arriva a sospettare che la diagnosi sia stata sbagliata, con il suo tacito consenso. A pensare di non essere affatto schizofrenica.
Dentro il muro racconta con agghiacciante realismo la parte centrale di una vicenda umana su cui Janet Frame è poi tornata per esteso nei tre volumi dell’autobiografia che, divenuti un mito in Nuova Zelanda e acclamati nel mondo anglosassone come opera di straordinario livello artistico oltre che umano, vengono probabilmente soltanto ora scoperti nel loro giusto valore nelle altre lingue in conseguenza dell’interesse suscitato al recente festival di Cannes dal film televisivo in tre puntate che da essi ha tratto la giovane regista Jane Campion, anch’essa neozelandese.
Una storia che - nella prima parte, To the Is-land - comincia come mille altre. Una modestissima famiglia piccolo borghese. Un padre ferroviere, uomo irresoluto che cerca di nascondere la propria debolezza sotto un ruvido strato di rigidezza. Una madre, animata da singolari impulsi poetici, che vive nel mito della famiglia. La morte per annegamento della prima figlia, un sospetto di malattia mentale per il secondogenito. Normali interni di famiglia predestinata alla tragedia.
Da simile contesto emerge una piccola artista in fieri, una personcina abituata a vivere un proprio privatissimo rapporto con il linguaggio, che ama stravolgere a proprio piacimento e secondo propri insondabili fini. Un’aspirante poetessa che sembra destinata a fare la gioia dei frustrati slanci poetici materni. Nulla, quando ventenne lascia la famiglia per andare all’università e avviarsi a una normale carriera di insegnante con propensioni poetiche, lascia presagire l’abisso che di lì a poco tempo la chiamerà a sé.
Difficoltà di rapporto con gli altri, problemi di comunicazione ulteriormente aggravati dalle disagiate condizioni economiche. La ragazza studia con esiti brillanti, ma, malnutrita nel fisico come nei sentimenti, la sua mente comincia a vacillare. L’«Immaginazione» (nella teorizzazione che la Frame trova elaborata da Coleridge nella Biographia Literaria) inizia a prevalere sulla «Realtà». Janet lavora con fervore, pubblica le prime poesie, il primo racconto, ma in lei comincia a manifestarsi qualche segno di equilibrio malcerto. L’insegnamento viene abbandonato senza spiegazioni. E un giorno arriva un goffo tentativo di suicidio. La pace eterna cercata nientemeno che in un tubetto di Aspro. L’esito è semplicemente un’emorragia, accompagnata da forti malesseri di natura gastrica. Niente di peggio, a prima vista. Anzi, caso mai una straordinaria felicità nel ritrovarsi viva. L’apparente possibilità di uscire dal tunnel della depressione. Trovato nuovo entusiasmo, Janet si confida con un insegnante che ha fatto presa nei suoi sentimenti. Un bel giovane dotto e moderno, che esegue Schubert al piano e ama riempirsi la bocca con confuse citazioni da Freud e dalla sua scuola psicoanalitica. Ed è da lui, con le migliori intenzioni, con il più comprensivo dei sorrisi, che inizia il disastro. «Sei stanca», le dice più o meno. «Non sarà il caso di farsi ricoverare per un po’?»
Quando Janet si rende conto che il ricovero è avvenuto in un padiglione per malati di mente, è troppo tardi. Dopo qualche tempo arriva la diagnosi. Schizofrenia. La giovane la prende alla leggera. «Ho la schizzomania», spiega più o meno a casa, scherzando e cedendo ancora una volta all’irresistibile gusto di stravolgere le parole. Schizofrenia. Che cosa sarà mai? Si mette a scartabellare dubbie pubblicazioni di taglio parapsicoanalitico. Dalle confuse e agitate letture deduce che la paura del dentista sarebbe un sintomo accertato di schizofrenia, in quanto generata dal senso di colpa nei confronti della masturbazione. Masturbazione? Personalmente (scrive con disarmante candore nella seconda parte dell’autobiografia, An angel at my table) fino a quel momento non conosceva nemmeno il significato dell’espressione. È una pratica di cui si dichiara «innocente». Però ha i denti malamente cariati e ha effettivamente una paura dannata di andare dal dentista. Dunque il teorema si chiude, non c’è più dubbio. È schizofrenica. Quindi hanno ragione di rinchiuderla per curarla.
La vita di Janet procede così, da anima reietta, fuggendo dall’insegnamento, rinunciando all’università, rifugiandosi nei lavori più umili, infermiera, serva, sguattera, dentro e fuori da case di cura. A una cosa sola la giovane non rinuncia. Alla letteratura. Ai suoi poeti. A scrivere. Fino al colpo finale, provocato nella sua povera mente dalla morte per annegamento di una seconda sorella, la più piccola, la più amata. la crisi definitiva, l’abisso, i padiglioni per incurabili, i duecento elettroshock, la prospettiva di passare tutta la vita segregata.
Fino al penultimo atto. Nella sua coazione ad avere una famiglia perfetta, la madre decide finalmente di non poter accettare di avere una figlia così fuori dall’ordinario. Conclude che hanno ragione i medici, che effettivamente la soluzione potrebbe risiedere nella costruzione di «una nuova personalità» per Janet. Firma il documento con cui autorizza che le venga eseguita una lobotomia.
Janet è di fronte alla condanna finale. La sua mente è ossessionata dalla visione dell’amica più cara, che è appena stata sottoposta alla medesima mutilazione. Un essere irrimediabilmente straziato. Guarda verso il fondo del precipizio e scopre che è senza fine. Si sente disperata. Quando vede arrivare un nuovo medico di cui le sembra di poter avere fiducia, commette l’inaudita infrazione di interpellarlo. «Che cosa ne pensa?» gli chiede. «Di che cosa?» replica il medico. Della lobotomia, naturalmente.
Ed ecco il miracolo. «Lobotomia?» dice il medico. No, non crede che sia necessaria. Non lo crede affatto. Piuttosto, Janet ha sentito del premio? Quale premio? Il premio letterario che è stato appena assegnato al suo primo libro di racconti, The lagoon. Janet non ricordava quasi nemmeno di averlo scritto, di essere riuscita a pubblicarlo. L’unica recensione che ne ha visto, con luminosa e supponente miopia dichiarava: «Robetta che abbiamo già letto anche troppo spesso».
Attraverso quella «robetta» stava cercando di esprimere il proprio insondabile male una giovane donna destinata a diventare una delle più eminenti scrittrici in lingua inglese del nostro tempo. A quella «robetta» e al premio a essa riconosciuto il mondo letterario internazionale deve la salvezza di un proprio rispettabilissimo esponente. Janet Frame vi deve semplicemente la ragione e la vita.
An Angel at my Table si chiude sulla «liberazione» dalla condizione di pazza. Nella terza parte dell’autobiografia - The Envoy from Mirror City - la vita riprende faticosamente il suo corso. Una borsa di studio consente a Janet Frame di venire in Europa, dove, ormai non più nell’alba della vita, conosce finalmente per la prima volta l’amore fisico, raccontato con disincantata e sottile capacità di autoironia. Ed è nel londinese Maudesley Hospital che la diagnosi di un tempo viene definitivamente smentita. Janet Frame non è mai stata schizofrenica.
Ora, sessantaseienne, vive da sola in una fattoria in aperta campagna, in mezzo a un folcloristico disordine di cui probabilmente soltanto lei coglie la logica. I diritti d’autore e le borse di studio le consentono un’esistenza dignitosa. Non sollecita le visite, anche se le riceve con amabile cortesia. Non ama le interviste, anche se vi si sottopone di buon grado. Per farsi compagnia usa quel pianoforte che ha imparato a suonare da autodidatta e che compare spesso nelle sue storie. I libri li compone su una macchina per scrivere portatile, antiquata, anche se non disprezza il computer. Lo ha da anni. Lo sfida a strenue tenzoni di scacchi. Oppure ci si esercita in quel Corso di Simulazione di Volo che ha inserito nel romanzo The Carpathians. Per vincere la «paura di volare», dice.
Una volta «fuori», le hanno ossessivamente prescritto le infermiere delle diverse case di cura, per riprendere a vivere una vita normale dovrai assolutamente dimenticare tutto ciò che hai visto e vissuto qui dentro. Troppo difficile, sembra replicare Janet Frame attraverso i propri scritti (sette romanzi, oltre ai racconti, alle poesie e all’autobiografia). Dal male di avere vissuto una simile esperienza è con ogni probabilità impossibile guarire davvero.
Dentro il muro, Ed. Interno giallo
II.
Nuova Zelanda, anni Quaranta-Cinquanta. Una clinica psichiatrica femminile. Un inferno. Un universo in cui a poco a poco si viene spogliate di ogni personalità, rischiando continuamente di sentirsi chiamare per prepararsi al terrore dell'elettroshock.
Una bolgia dove di quando in quando capita di vedere un'anima particolarmente in pena, lo sguardo spento, un sorriso atono, un foulard che denuncia la presenza di una ferita irreparabile: una donna sottoposta a lobotomia. In tale orrore si trova a precipitare nel '46, ventunenne, una studentessa. Diagnosi: «schizofrenia» .
In pochissimo tempo la giovane, Janet Frame, si vede spalancare davanti un baratro dal quale non soltanto le risulta impossibile fuggire ma in cui si sente addirittura risucchiare. Con i suoi simili ha disimparato a stare, ormai sembra saper vivere soltanto con Shakespeare, Rilke, Coleridge. In casa di cura vive otto anni, subisce duecento elettroshock, arriva sulla soglia della lobotomia. Finché una sorta di miracolo la salva. Un medico intelligente combinato con un premio letterario.
Una volta «fuori» , le hanno più volte prescritto che, per riprendere una vita normale, dovrà assolutamente dimenticare tutto ci ò che ha visto. Troppo difficile, sembra replicare lei. Dal male di avere vissuto una simile esperienza è con ogni probabilità impossibile guarire fino in fondo. Infatti, divenuta la più importante scrittrice neozelandese vivente, vi torna sopra con un’insistenza quasi ossessiva, sia pure con grosse varianti narrative. L'ha raccontata in Dentro il muro e nei tre volumi dell'autobiografÏa (da cui Jane Campion, prima di Lezioni di piano, ha tratto il film Un angelo alla mia tavola) e lo fa ancora una volta nello splendido Gridano i gufi (da La tempesta), certamente uno dei suoi migliori conseguimenti, forse il più alto.
Una storia che (nelle diverse versioni narrative offerte da Janet Frame fa letteralmente mancare il fiato, raccontata senza un briciolo di reticenza ma con grande sapienza letteraria ed elevato spirito poetico. Una modesta famiglia piccolissimo borghese. Un padre ferroviere, uomo irresoluto, fintamente rigido. Una madre animata da singolari slanci poetici. La morte tragica della prima figlia, un sospetto di malattia mentale per il secondogenito. Da simile contesto emerge una piccola artista in potenza, una persona abituata a vivere un proprio privatissimo rapporto con il linguaggio, che ama stravolgere secondo propri fini insondabili. Un'aspirante poetessa malata di poesia. Invece, i suoi problemi di comunicazione, gli stravolgimenti del linguaggio, vengono scambiati per schizofrenia. E come tale curati fino al limite della lobotomia. Una storia stupefacente, da leggere, meditare e non dimenticare mai. Ma, a proposito di «poesia», viene da chiedersi: che fine ha fatto in Italia? Dove sono i poeti? Presi per schizofrenici anche loro?
Sottoposti a elettroshock, minacciati di lobotomia? Dove sono finiti i testi poetici contemporanei italiani? I soldi guadagnati dagli editori con le formiche che si incazzano e con quelli che sperano che se la cavano, non si diceva che sarebbero serviti per pubblicare libri di alta qualità, difficili e dunque costosi?
E non appartengono a tale schiera, in primissima istanza, i testi dei poeti? Dove sono? Dovremo concludere malinconicamente che le formiche incazzate se la sono cavata, portando a casa almeno il pancreas, e che invece i bravi poeti sono tutti rinchiusi in attesa di lobotomia?
Gridano i gufi, Guanda (Corriere della sera, 8 giugno 1994)