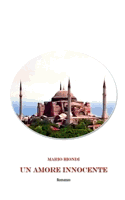Scrive di: William Golding. Premio Nobel 1983
1. Articolo su una conferenza a Milano in ottobre 1983
2. Intervista (novembre 1983)
1. Articolo su una conferenza a Milano in ottobre 1983
2. Intervista (novembre 1983)
© Mario Biondi
Divieto di riproduzione integrale
e obbligo di citazione (per cortesia...)
Fine marzo 1982. William Golding è a Milano per il suo ultimo romanzo, Riti di passaggio. Tra un’intervista e l’altra (non molte, per il vero, e organizzate tra molte italiche supponenze e diffidenze), tiene una conferenza al British Council. Davanti alla gremita, allibita ed esilarata platea, estrae da una tasca degli stazzonati e un po’ lardellati pantaloni scozzesi un foglietto, se lo spiega davanti al naso e si mette a leggere una sorta di stupefacente necrologio di se stesso, rivolto a una fantomatica associazione londinese. Poi fa una pausa drammaticamente perplessa e borbotta qualcosa come: «Be’, ho sbagliato foglio... Comunque, eccomi qui». La conferenza è finita. Ma cominciano subito le domande del pubblico. Nessuno ha ancora letto il nuovo romanzo e — si capisce benissimo — neanche i precedenti, tranne uno, Il signore delle mosche un "monster" dell’editoria di tutti i tempi (10 milioni e passa di copie solo in lingua inglese).
Tanto per cambiare gli viene subito chiesto qual è il messaggio fondamentale di questo Signore delle mosche (ovvero Belzebù, titolo che probabilmente fu proposto da T.S. Eliot in persona, allora direttore di quella casa editrice inglese). Lui, con la sua bellissima voce profonda e con una dizione da consumato ex attore («un pessimo attore», dice), addirittura resa ancor più incisiva da un lieve difetto di pronuncia, risponde ripetendo tre volte la parola "grief": «dolore, dolore, dolore». E nei suoi occhi di ghiaccio, sprofondati in un liquido azzurro marino, brillano delle lacrime autentiche. Se le asciuga fingendo di tergersi il sudore dalla fronte.
In pochi minuti, con due battute e due atteggiamenti diametralmente opposti, il gran vecchio pestifero e dolcissimo aveva saputo condensare il significato di tutta la sua opera narrativa. Una terribile e magica commistione di humour travolgente, dissacrante, crudele, e di senso quasi panico del Dolore, un dolore cosmico, che avvolge ogni cosa e non risparmia nessuno, nutrito e protetto dall’Ipocrisia, in particolare quella della società britannica. Il Bene sempre sconfitto dal Male, gli apparenti Buoni che non sono mai buoni, gli Innocenti che quasi sempre agli occhi del buon senso appaiono colpevoli, e quanto più sono veramente innocenti, tanto più sono Vittime. Come il bambino Piggy del Signore delle mosche, come la zitella Palla della Piramide, come il reverendo Colley di Riti di passaggio, come il povero, deforme, subumano Matty e il trepidante, vecchio pedofilo Mr. Pediggree di Darkness Visible (uscito in seguito con il titolo italiano di L’oscuro visibile).
Singolare personaggio William Golding, indimenticabile. Non vuole assolutamente parlare né sentir parlare di Darkness Visible, suo penultimo romanzo. Romanzo imponente, febbrile, oscuro, ambizioso, a tratti magnifico, a tratti abbondantemente sbagliato, che crea un autentico groviglio di Bene e Male, di Amore e Terrore, infarcito di situazioni stregonesche e di deliri gnostici, con un avvio di apocalittica grandezza e un finale di desolata tenerezza. In Inghilterra è stato accolto con pareri molto discordanti. Anthony Burgess è addirittura andato in bestia: in una lunga recensione lo ha definito «un brancolante tentativo di tornare alla pratica di un’arte che Golding non avrebbe dovuto trascurare per tanto tempo». (Era, infatti, il suo primo romanzo dopo diversi anni di silenzio creativo).
È per questo che Golding circonda il suo romanzo di un fittissimo velo di silenzio? Non dovrebbe essere, dal momento che lui stesso afferma infastidito di non leggere niente, nemmeno le recensioni dei suoi libri.
In compenso si esibisce in fuochi artificiali di battute feroci, perfidie, strepitosi aneddoti che spaziano dal bel mondo di Londra ai buoni selvaggi della Nuova Guinea. Racconta di quando è venuto a Milano la prima volta, con moglie e figli, ed è finito a dormire in un albergo a ore. E di quando, passeggiando studentello nei giardini di Oxford, incontrò su un piccolo ponte un signore minuscolo dalla grande criniera: Albert Einstein. Come rivolgergli la parola, non conoscendo il tedesco? Continuò a guardare nel fiumiciattolo, allungò un dito e disse: «Fish». «Ja», rispose con un benevolo sorriso il grand’uomo: «Ja, fish». «Così», conclude, «comunicai con il massimo rappresentante del nostro tempo, il Pitagora moderno».
E si diffonde sulla propria passione per il mondo greco, di cui tuttavia lo affascina non lo spirito razionale, ma la potenza devastante del Mito. Quel Mito che esprime il dolore del cosmo attraverso la voce dei poeti, una voce che proviene da remote regioni intime, non dalla ragione. Razionalizzare significa comunque rendere le cose comuni, un po’ ridicole. E non sono i poeti a dover credere in Dio, ma Dio in loro. E così via, così via, così via...
La notte è ormai fonda. Il vino è scorso a un ritmo terrificante («Chissà perché», chiede sconsolato, «gli scrittori inglesi non riescono a fare a meno di ubriacarsi?»). Seguire un filo logico, prendere appunti ragionati è impossibile. Non si riesce a infilarlo nell’ascensore dell’albergo. Ma finalmente ci entra, con le mani tra i capelli, lo sguardo folle, la barba rigata di lacrime, e parte. Dove andrà mai a finire?
Finisce regolarmente a casa sua, a Ebble Thatch, Bowerchalke, vicino a Salisbury, nel Wiltshire, da dove telefona subito (chi ha detto che non ha il telefono?) per assicurare che è arrivato sano e salvo. E chiede scusa. E chiede se non è stato troppo cattivo. E poi scrive: «Mio caro, ancora una volta grazie per essermi stato "guida filosofo e amico". Abbandonato a me stesso, Dio sa che cosa avrebbe potuto succedere. Bill».
Non sarebbe successo proprio niente, tutto si sarebbe svolto con assoluta regolarità e precisione. Perché il Cattivo che non è cattivo, il Colpevole che non è colpevole, l’Innocente-Vittima dei suoi romanzi il perseguitato dal Male dei Buoni — come ancora una volta sicuramente gli stanno dimostrando le inutili polemiche seguite all’assegnazione del Nobel — è lui, Bill Golding.
(Europeo, 29 ottobre 1983)
II.
Narra un antico e riservatissimo pettegolezzo londinese che un certo re d’Inghilterra, desiderando visitare molto assiduamente una certa signora, che non era la regina, non sapesse che pesci prendere. Londra era già una città grandicella, ma un re è pur sempre un re e non può non dare nell’occhio. Della delicata questione volle graziosamente occuparsi un nobile amico del sovrano, assicurandone la soluzione. Acquistò due case contigue, i cui portoni davano su due vie parallele. Assoldò dei muratori italiani, che non conoscevano l’inglese, fece loro bendare gli occhi e comandò che aprissero una porta segreta tra le due case. Così, mentre da uno dei due portoni il certo re faceva il suo ingresso in una delle due case, con il dichiarato intento di volersi piacevolmente intrattenere con alcuni carissimi amici di sesso rigorosamente maschile, dall’altro portone, sull’altra via, nell’altra casa faceva il suo lieto ingresso la certa signora, con l’altrettanto dichiarato intento di volersi frivolamente intrattenere con alcune dolcissime amiche, di sesso castissimamente femminile. E attraverso la porta segreta, aperta dai muratori italiani bendati...
Passati i secoli, le due case contigue sono diventate un vecchio albergo molto, molto esclusivo, di cui chi scrive è stato pregato di non fare il nome. E bisognerebbe forse anche tacere quello delle due vie su cui danno le porte dell’albergo, ma gli indiscreti prendano golosamente nota che si tratta di Abemarle Street e Dover Street, a due passi da Bond Street, a un tiro di archibugio da Piccadilly Circus. Tanto, in quell’albergo, non troveranno mai una camera. Mentre è proprio lì che chi scrive viene ricevuto da William Golding. Vi alloggia con assoluta regolarità da oltre venticinque anni, ogni volta che i casi della vita o dell’arte lo trascinano lontano dalla sua campagna e lo attirano nella capitale del Commonwealth.
William Golding — Bill per gli amici — è un vecchio signore dolcissimo e perfido, dallo sguardo mobilissimo e dalla barba patriarcalmente candida, elegantemente trasandato e impareggiabilmente spiritoso, capace di grandissimi slanci, di squisite cortesie e di cascate di battute estasianti, ma anche di profonde irritazioni e di raggelanti dispetti. Ha scritto nove romanzi di intensa qualità e di tortuosa complessità, in cui il suo humour travolgente si mescola esplosivamente con un senso lacerante del Male e del Dolore in questo mondo. Opere di grande valore e vigore, quasi impossibili da tradurre in altre lingue, che ne hanno fatto uno scrittore venerato dalle anime complicate e sdegnosamente contestato dalle mezzecalze.
Con lui, ad attendere l’amico italiano, dietro a un tavolino carico di finissime tartine e pronto per il più introvabile dei tè, c’è anche la moglie, Ann, amabilissima compagna di una lunga vita ricca di episodi notevoli e addirittura avventure, letterarie e umane. Una vita su cui, giovedì 6 ottobre, si è abbattuta come un fulmine a ciel sereno la notizia che William Golding, ex professore di letteratura inglese e greco, ex uomo di mare, gentleman di campagna e settantaduenne cavallerizzo neofita, appartato artefice di splendide e complesse cattedrali di parole, era diventato Premio Nobel 1983 per la letteratura.
MARIO BIONDI: Come ha avuto la notizia ?
WILLIAM GOLDING: Ero in casa quando, verso le dieci del mattino, è suonato il telefono. Era un giornalista svedese: mi informava che avevo il 50 per cento di possibilità di vincere il Premio Nobel. Sono rimasto allibito. Gli ho chiesto quando sarebbe arrivata la notizia definitiva. Nel giro di due o tre ore, mi ha risposto. L’ho ringraziato, ma in cuor mio l’ho mandato decisamente all’inferno. Ero furibondo. Spregevole individuo! Mi costringeva a passare due o tre ore di ansia tremenda, con le dita incrociate, a fare scongiuri. Non avevo mai nemmeno lontanamente pensato che il Nobel potesse toccare a me. Avevo sentito che Lech Walesa aveva avuto il premio per la pace e per me tutto finiva lì. Mi ero assolutamente dimenticato che di Premi Nobel ne vengono assegnati diversi, tra cui uno per la letteratura.
BIONDI: E poi?
GOLDING: Mi sono messo a lavorare al mio diario e, verso mezzogiorno, sono andato nella stanza dove teniamo la televisione. Mia moglie si è ritirata in un salotto, con la radio accesa. Anche la televisione era accesa, ma aveva il volume staccato. Ho visto che stavano per dare la notizia e, con il cuore in gola, ho fatto un autentico balzo per alzare il volume, ma proprio in quel momento, dall’altro locale, ho sentito un urlo terrificante. Mia moglie aveva sentito la notizia alla radio. Era assolutamente vero. Sono corso fuori, nel corridoio, e ci siamo letteralmente scontrati. Bang! Io purtroppo avevo ancora la mano sulla maniglia all’interno della porta che, in conseguenza dello scontro, si è chiusa di scatto. Sulla mano mi è venuto un livido enorme, che mi ha poi provocato pene spaventose, perché in quei giorni ho dovuto stringere decine di mani di vicini venuti per congratularsi. Ogni stretta di mano era un gemito. Ma credo che in tutto ciò vi sia qualcosa di profondamente simbolico. Lo sa che i francesi definiscono il Premio Nobel «une pierre tombale»? Ogni stretta di mano mi ricordava la tomba.
BIONDI: Insomma, il Dolore, massima espressione delle sue opere, la perseguita sempre.
GOLDING: Lasci perdere il Dolore, per adesso. Direi piuttosto che si tratta di puro spirito farsesco, di cui tutta la mia vita è intessuta e che credo di avere abbondantemente fatto filtrare anche nelle mie opere.
BIONDI: Già, il clown triste, a cui tutti chiedono di fare la parte di Amleto, come ha dichiarato in un’intervista.
GOLDING: Macché Amleto. Preferisco Pulcinella. E niente affatto triste. Allegrissimo e divertitissimo, invece. Perseguitato dalla farsa. Lo sa, per esempio, che Cobber, il mio cavallo, è diventato molto più famoso di me? Subito dopo l’arrivo della notizia, il telefono non voleva più stare zitto, per cui sono uscito a fare una cavalcata in campagna. E mi sono messo a ripetere, ad alta voce: «Ho vinto il Premio Nobel! Ho vinto il Premio Nobel!» Ma mi sono reso conto che né io né il cavallo riuscivamo a valutare a quale livello di importanza fossimo arrivati. Quando sono rientrato a casa ho trovato una troupe televisiva della Bbc. Non hanno voluto perdere l’occasione di riprendere anche Cobber, che immediatamente è diventato una star televisiva. Adesso il suo muso è molto più conosciuto della mia faccia. E subito dopo mi sono trovato catapultato a Parigi, in un convegno di Premi Nobel. Mi aggiravo come un ragazzino tra questi distintissimi signori e a un certo punto mi sono accorto che tutti quanti, tranne me, avevano all’occhiello un distintivo dorato. Solo dopo due giorni mi sono reso conto che sul distintivo c’era scritto: «Premio Nobel signor Tal dei Tali».
BIONDI: Ma che cosa ha pensato, che cosa ha fatto, che cosa ha detto nel momento in cui ha saputo la notizia? Era felice?
GOLDING: Molto felice... Quello che ho fatto, gliel’ho detto. Mi sono scontrato con mia moglie. Che cosa vuole che abbia detto? Ho detto: «Ahi!» Poi ho pensato che non potevo crederci. E ancora adesso stento a crederci. Mi sembra una cosa ridicola.
BIONDI: Posso scrivere questo aggettivo?
GOLDING: Certo che può. Ma cerchi di capire bene. Non intendo affatto dire che il Premio Nobel è una cosa ridicola. Trovo ridicolo che, nel mondo, abbiano scelto proprio me. Chissà perché.
BIONDI: Perché?
GOLDING: Probabilmente per i saggi contenuti nel mio libro A moving target (Bersaglio mobile). Non posso vedere altra ragione.
BIONDI: L’assegnazione del Premio ha in qualche modo cambiato la sua vita?
GOLDING: Dal punto di vista letterario un cambiamento c’è certamente stato. Ho conquistato la sicurezza. Le mie opere possono piacere o non piacere, ma hanno avuto il massimo riconoscimento che si possa avere. Ora ho la sicurezza della loro qualità. Dal punto di vista del denaro, invece, non credo ci sia stato alcun cambiamento. Mia moglie e io abbiamo bisogno di poco.
BIONDI: Molto bene. Messo in evidenza lo spirito farsesco e reso il dovuto omaggio alla previdenza, vogliamo ora parlare del Dolore? Perché ce n’è tanto nelle sue opere?
GOLDING: Perché il mondo ne è intriso. La mia è una grande tristezza per ciò che è in realtà la natura umana. E’ un’idea, una scoperta che mi ha colpito come una mazzata alla fine della guerra. Quando ho scoperto che tutte le atrocità attribuite ai tedeschi erano vere. Ho capito quanto male può esserci nell’uomo. E’ il vero nostro problema, ciò che dobbiamo combattere se vogliamo continuare a considerarci esseri civili. Questo è il dolore mio e dei miei libri. Tristezza all’ennesima potenza.
BIONDI: Quindi, nel nostro mondo il problema del Male è fondamentale.
GOLDING: Ce n’è tanto. In realtà, penso di aver addirittura aspirato a risolvere il problema del Male, come tanta gente ha fatto e continua a fare. Ma ora so che non ci sono riuscito. Ho solo messo in rilievo che il nostro problema è quello: il Male. Temo che sia insolubile, come del resto quello del Bene. Siamo qui, in bilico tra queste due forze opposte, entrambe in realtà incomprensibili, insolubili in quanto problemi, a cui ci si può solo accostare in termini di sentimento o di esperienza.
BIONDI: E l’Amore?
GOLDING: Oh Dio!... E’ un’espressione su cui la semantica entra in crisi. Quanti significati ha la parola Amore? C’è quello di una persona per un’altra, quello dei genitori, quello dei figli, quello di Dio o per Dio... Che cosa si può dire ancora, sull’Amore, se non che è un concetto universale?
BIONDI: Ma è stato importante nella sua vita?
GOLDING: Lo è stato, certamente. E’ ciò che tutti vanno cercando e, in un certo senso, credo che si possa definire criminale chi non è mai stato capace di trovarlo.
BIONDI: Lei crede in Dio? E se ci crede, come giustifica il fatto che Dio consenta a tanto Male di trionfare nel mondo?
GOLDING: Io credo in Dio, certamente. Ma alla sua domanda non so proprio rispondere. E’ un problema che è stato discusso per migliaia di anni dai sapienti. Io sono solo un narratore. Come posso conoscere le risposte? Posso solo, talvolta, porre i problemi.
BIONDI: Nient’altro?
GOLDING: Non le sembra abbastanza?
BIONDI: E per il futuro? Che progetti ha?
GOLDING: Ahimè! Prima di tutto devo scrivere il discorso per la cerimonia del Nobel. E una cosa che mi sta facendo impazzire. A settantadue anni si è detto tutto quello che si aveva da dire. Almeno trenta volte. E almeno sei lo si è scritto. E invece si pretende che un uomo, già con il piede nella fossa, abbia ancora qualcosa di nuovo da dire. Come preferirei dover scrivere il discorso di Walesa!
BIONDI: Crede che sia più facile?
GOLDING: E certamente più facile. Ci sono tante cose facili da dire. Badi bene: non intendo «poco importanti». Al contrario, sulla pace ci sono infinite cose della massima importanza che si possono dire in maniera facile. E, ovviamente, la cosa più importante è che l’America e la Russia arretrino entrambe. Di fronte a un simile problema, quelli della letteratura non sono niente... Ma mia moglie mi ha dato un ottimo consiglio. Affrontare questo problema dal punto di vista della letteratura. Perché i letterati sono esseri umani e come tali il problema della pace li investe direttamente, a prescindere dalle questioni politiche. Credo proprio che scriverò questo.
BIONDI: Sua moglie è stata importante anche per la sua attività letteraria?
GOLDING: Molto importante. Vivere con Ann è come avere in casa un consulente editoriale. Legge tutto quello che scrivo nella prima stesura, e poi mi dà i suoi consigli.
BIONDI: Nel suo romanzo di prossima uscita The paper men (Gli uomini di carta), c’è molta Italia. Come mai?
GOLDING: Mia moglie e io amiamo molto l’Italia. Ci siamo stati un’infinità di volte. L’abbiamo percorsa dalle Alpi alla Sicilia. I paesaggi. Un incredibile accumulo di storia. La bellezza della lingua. Dovreste continuamente cantarla, non parlarla. E la regolarità di fattezze della gente. Una cosa che fa pensare all’evoluzione definitiva e perfetta di una forma, di qualcosa che non è più migliorabile. Siamo spinti verso l’Italia dallo stesso spirito che animava Shelley, Byron, Keats, i Browning... Una volta ci siamo arrivati dalla Grecia. Siamo sbarcati a Brindisi, Ann, io e i due ragazzi. Doveva essere venticinque anni fa. Tempi magnifici. Di grande povertà e allegria. Non avevamo quasi più un soldo, ma io ho tranquillizzato tutti. A Milano — ho detto — c’è il mio editore italiano. Avrò ben maturato qualche diritto d’autore. Invece non c’era neanche una lira. Dei miei libri non si era praticamente venduta una copia. Povero me! Devo però dire che la mia famiglia si è comportata in un modo assai nobile. Per giorni e giorni si è nutrita di sola pasta, per consentire a me di nutrirmi di buon vino italiano. Ah, Italia...
BIONDI: Ci tornerà?
GOLDING: Senza dubbio. Spero nella prossima primavera. Prima andrò per un mese o due, o forse anche tre, in Egitto. Una casa editrice di grossi volumi illustrati mi ha chiesto un testo di impressioni su questo paese, che conosco già bene. Ci andrò con mia moglie e un fotografo, e avremo a nostra disposizione un battello, appositamente noleggiato, per andare su è giù a nostro piacimento lungo il Nilo. Sarà un’esperienza magnifica. E al ritorno conto proprio di fermarmi qualche giorno a Roma o a Milano.
BIONDI: E l’aneddoto che mi ha raccontato a proposito dell’albergo è vero?
GOLDING: Assolutamente no. Ma non lo trova bello?
(Amica, novembre 1983)
Tanto per cambiare gli viene subito chiesto qual è il messaggio fondamentale di questo Signore delle mosche (ovvero Belzebù, titolo che probabilmente fu proposto da T.S. Eliot in persona, allora direttore di quella casa editrice inglese). Lui, con la sua bellissima voce profonda e con una dizione da consumato ex attore («un pessimo attore», dice), addirittura resa ancor più incisiva da un lieve difetto di pronuncia, risponde ripetendo tre volte la parola "grief": «dolore, dolore, dolore». E nei suoi occhi di ghiaccio, sprofondati in un liquido azzurro marino, brillano delle lacrime autentiche. Se le asciuga fingendo di tergersi il sudore dalla fronte.
In pochi minuti, con due battute e due atteggiamenti diametralmente opposti, il gran vecchio pestifero e dolcissimo aveva saputo condensare il significato di tutta la sua opera narrativa. Una terribile e magica commistione di humour travolgente, dissacrante, crudele, e di senso quasi panico del Dolore, un dolore cosmico, che avvolge ogni cosa e non risparmia nessuno, nutrito e protetto dall’Ipocrisia, in particolare quella della società britannica. Il Bene sempre sconfitto dal Male, gli apparenti Buoni che non sono mai buoni, gli Innocenti che quasi sempre agli occhi del buon senso appaiono colpevoli, e quanto più sono veramente innocenti, tanto più sono Vittime. Come il bambino Piggy del Signore delle mosche, come la zitella Palla della Piramide, come il reverendo Colley di Riti di passaggio, come il povero, deforme, subumano Matty e il trepidante, vecchio pedofilo Mr. Pediggree di Darkness Visible (uscito in seguito con il titolo italiano di L’oscuro visibile).
Singolare personaggio William Golding, indimenticabile. Non vuole assolutamente parlare né sentir parlare di Darkness Visible, suo penultimo romanzo. Romanzo imponente, febbrile, oscuro, ambizioso, a tratti magnifico, a tratti abbondantemente sbagliato, che crea un autentico groviglio di Bene e Male, di Amore e Terrore, infarcito di situazioni stregonesche e di deliri gnostici, con un avvio di apocalittica grandezza e un finale di desolata tenerezza. In Inghilterra è stato accolto con pareri molto discordanti. Anthony Burgess è addirittura andato in bestia: in una lunga recensione lo ha definito «un brancolante tentativo di tornare alla pratica di un’arte che Golding non avrebbe dovuto trascurare per tanto tempo». (Era, infatti, il suo primo romanzo dopo diversi anni di silenzio creativo).
È per questo che Golding circonda il suo romanzo di un fittissimo velo di silenzio? Non dovrebbe essere, dal momento che lui stesso afferma infastidito di non leggere niente, nemmeno le recensioni dei suoi libri.
In compenso si esibisce in fuochi artificiali di battute feroci, perfidie, strepitosi aneddoti che spaziano dal bel mondo di Londra ai buoni selvaggi della Nuova Guinea. Racconta di quando è venuto a Milano la prima volta, con moglie e figli, ed è finito a dormire in un albergo a ore. E di quando, passeggiando studentello nei giardini di Oxford, incontrò su un piccolo ponte un signore minuscolo dalla grande criniera: Albert Einstein. Come rivolgergli la parola, non conoscendo il tedesco? Continuò a guardare nel fiumiciattolo, allungò un dito e disse: «Fish». «Ja», rispose con un benevolo sorriso il grand’uomo: «Ja, fish». «Così», conclude, «comunicai con il massimo rappresentante del nostro tempo, il Pitagora moderno».
E si diffonde sulla propria passione per il mondo greco, di cui tuttavia lo affascina non lo spirito razionale, ma la potenza devastante del Mito. Quel Mito che esprime il dolore del cosmo attraverso la voce dei poeti, una voce che proviene da remote regioni intime, non dalla ragione. Razionalizzare significa comunque rendere le cose comuni, un po’ ridicole. E non sono i poeti a dover credere in Dio, ma Dio in loro. E così via, così via, così via...
La notte è ormai fonda. Il vino è scorso a un ritmo terrificante («Chissà perché», chiede sconsolato, «gli scrittori inglesi non riescono a fare a meno di ubriacarsi?»). Seguire un filo logico, prendere appunti ragionati è impossibile. Non si riesce a infilarlo nell’ascensore dell’albergo. Ma finalmente ci entra, con le mani tra i capelli, lo sguardo folle, la barba rigata di lacrime, e parte. Dove andrà mai a finire?
Finisce regolarmente a casa sua, a Ebble Thatch, Bowerchalke, vicino a Salisbury, nel Wiltshire, da dove telefona subito (chi ha detto che non ha il telefono?) per assicurare che è arrivato sano e salvo. E chiede scusa. E chiede se non è stato troppo cattivo. E poi scrive: «Mio caro, ancora una volta grazie per essermi stato "guida filosofo e amico". Abbandonato a me stesso, Dio sa che cosa avrebbe potuto succedere. Bill».
Non sarebbe successo proprio niente, tutto si sarebbe svolto con assoluta regolarità e precisione. Perché il Cattivo che non è cattivo, il Colpevole che non è colpevole, l’Innocente-Vittima dei suoi romanzi il perseguitato dal Male dei Buoni — come ancora una volta sicuramente gli stanno dimostrando le inutili polemiche seguite all’assegnazione del Nobel — è lui, Bill Golding.
(Europeo, 29 ottobre 1983)
II.
Narra un antico e riservatissimo pettegolezzo londinese che un certo re d’Inghilterra, desiderando visitare molto assiduamente una certa signora, che non era la regina, non sapesse che pesci prendere. Londra era già una città grandicella, ma un re è pur sempre un re e non può non dare nell’occhio. Della delicata questione volle graziosamente occuparsi un nobile amico del sovrano, assicurandone la soluzione. Acquistò due case contigue, i cui portoni davano su due vie parallele. Assoldò dei muratori italiani, che non conoscevano l’inglese, fece loro bendare gli occhi e comandò che aprissero una porta segreta tra le due case. Così, mentre da uno dei due portoni il certo re faceva il suo ingresso in una delle due case, con il dichiarato intento di volersi piacevolmente intrattenere con alcuni carissimi amici di sesso rigorosamente maschile, dall’altro portone, sull’altra via, nell’altra casa faceva il suo lieto ingresso la certa signora, con l’altrettanto dichiarato intento di volersi frivolamente intrattenere con alcune dolcissime amiche, di sesso castissimamente femminile. E attraverso la porta segreta, aperta dai muratori italiani bendati...
Passati i secoli, le due case contigue sono diventate un vecchio albergo molto, molto esclusivo, di cui chi scrive è stato pregato di non fare il nome. E bisognerebbe forse anche tacere quello delle due vie su cui danno le porte dell’albergo, ma gli indiscreti prendano golosamente nota che si tratta di Abemarle Street e Dover Street, a due passi da Bond Street, a un tiro di archibugio da Piccadilly Circus. Tanto, in quell’albergo, non troveranno mai una camera. Mentre è proprio lì che chi scrive viene ricevuto da William Golding. Vi alloggia con assoluta regolarità da oltre venticinque anni, ogni volta che i casi della vita o dell’arte lo trascinano lontano dalla sua campagna e lo attirano nella capitale del Commonwealth.
William Golding — Bill per gli amici — è un vecchio signore dolcissimo e perfido, dallo sguardo mobilissimo e dalla barba patriarcalmente candida, elegantemente trasandato e impareggiabilmente spiritoso, capace di grandissimi slanci, di squisite cortesie e di cascate di battute estasianti, ma anche di profonde irritazioni e di raggelanti dispetti. Ha scritto nove romanzi di intensa qualità e di tortuosa complessità, in cui il suo humour travolgente si mescola esplosivamente con un senso lacerante del Male e del Dolore in questo mondo. Opere di grande valore e vigore, quasi impossibili da tradurre in altre lingue, che ne hanno fatto uno scrittore venerato dalle anime complicate e sdegnosamente contestato dalle mezzecalze.
Con lui, ad attendere l’amico italiano, dietro a un tavolino carico di finissime tartine e pronto per il più introvabile dei tè, c’è anche la moglie, Ann, amabilissima compagna di una lunga vita ricca di episodi notevoli e addirittura avventure, letterarie e umane. Una vita su cui, giovedì 6 ottobre, si è abbattuta come un fulmine a ciel sereno la notizia che William Golding, ex professore di letteratura inglese e greco, ex uomo di mare, gentleman di campagna e settantaduenne cavallerizzo neofita, appartato artefice di splendide e complesse cattedrali di parole, era diventato Premio Nobel 1983 per la letteratura.
MARIO BIONDI: Come ha avuto la notizia ?
WILLIAM GOLDING: Ero in casa quando, verso le dieci del mattino, è suonato il telefono. Era un giornalista svedese: mi informava che avevo il 50 per cento di possibilità di vincere il Premio Nobel. Sono rimasto allibito. Gli ho chiesto quando sarebbe arrivata la notizia definitiva. Nel giro di due o tre ore, mi ha risposto. L’ho ringraziato, ma in cuor mio l’ho mandato decisamente all’inferno. Ero furibondo. Spregevole individuo! Mi costringeva a passare due o tre ore di ansia tremenda, con le dita incrociate, a fare scongiuri. Non avevo mai nemmeno lontanamente pensato che il Nobel potesse toccare a me. Avevo sentito che Lech Walesa aveva avuto il premio per la pace e per me tutto finiva lì. Mi ero assolutamente dimenticato che di Premi Nobel ne vengono assegnati diversi, tra cui uno per la letteratura.
BIONDI: E poi?
GOLDING: Mi sono messo a lavorare al mio diario e, verso mezzogiorno, sono andato nella stanza dove teniamo la televisione. Mia moglie si è ritirata in un salotto, con la radio accesa. Anche la televisione era accesa, ma aveva il volume staccato. Ho visto che stavano per dare la notizia e, con il cuore in gola, ho fatto un autentico balzo per alzare il volume, ma proprio in quel momento, dall’altro locale, ho sentito un urlo terrificante. Mia moglie aveva sentito la notizia alla radio. Era assolutamente vero. Sono corso fuori, nel corridoio, e ci siamo letteralmente scontrati. Bang! Io purtroppo avevo ancora la mano sulla maniglia all’interno della porta che, in conseguenza dello scontro, si è chiusa di scatto. Sulla mano mi è venuto un livido enorme, che mi ha poi provocato pene spaventose, perché in quei giorni ho dovuto stringere decine di mani di vicini venuti per congratularsi. Ogni stretta di mano era un gemito. Ma credo che in tutto ciò vi sia qualcosa di profondamente simbolico. Lo sa che i francesi definiscono il Premio Nobel «une pierre tombale»? Ogni stretta di mano mi ricordava la tomba.
BIONDI: Insomma, il Dolore, massima espressione delle sue opere, la perseguita sempre.
GOLDING: Lasci perdere il Dolore, per adesso. Direi piuttosto che si tratta di puro spirito farsesco, di cui tutta la mia vita è intessuta e che credo di avere abbondantemente fatto filtrare anche nelle mie opere.
BIONDI: Già, il clown triste, a cui tutti chiedono di fare la parte di Amleto, come ha dichiarato in un’intervista.
GOLDING: Macché Amleto. Preferisco Pulcinella. E niente affatto triste. Allegrissimo e divertitissimo, invece. Perseguitato dalla farsa. Lo sa, per esempio, che Cobber, il mio cavallo, è diventato molto più famoso di me? Subito dopo l’arrivo della notizia, il telefono non voleva più stare zitto, per cui sono uscito a fare una cavalcata in campagna. E mi sono messo a ripetere, ad alta voce: «Ho vinto il Premio Nobel! Ho vinto il Premio Nobel!» Ma mi sono reso conto che né io né il cavallo riuscivamo a valutare a quale livello di importanza fossimo arrivati. Quando sono rientrato a casa ho trovato una troupe televisiva della Bbc. Non hanno voluto perdere l’occasione di riprendere anche Cobber, che immediatamente è diventato una star televisiva. Adesso il suo muso è molto più conosciuto della mia faccia. E subito dopo mi sono trovato catapultato a Parigi, in un convegno di Premi Nobel. Mi aggiravo come un ragazzino tra questi distintissimi signori e a un certo punto mi sono accorto che tutti quanti, tranne me, avevano all’occhiello un distintivo dorato. Solo dopo due giorni mi sono reso conto che sul distintivo c’era scritto: «Premio Nobel signor Tal dei Tali».
BIONDI: Ma che cosa ha pensato, che cosa ha fatto, che cosa ha detto nel momento in cui ha saputo la notizia? Era felice?
GOLDING: Molto felice... Quello che ho fatto, gliel’ho detto. Mi sono scontrato con mia moglie. Che cosa vuole che abbia detto? Ho detto: «Ahi!» Poi ho pensato che non potevo crederci. E ancora adesso stento a crederci. Mi sembra una cosa ridicola.
BIONDI: Posso scrivere questo aggettivo?
GOLDING: Certo che può. Ma cerchi di capire bene. Non intendo affatto dire che il Premio Nobel è una cosa ridicola. Trovo ridicolo che, nel mondo, abbiano scelto proprio me. Chissà perché.
BIONDI: Perché?
GOLDING: Probabilmente per i saggi contenuti nel mio libro A moving target (Bersaglio mobile). Non posso vedere altra ragione.
BIONDI: L’assegnazione del Premio ha in qualche modo cambiato la sua vita?
GOLDING: Dal punto di vista letterario un cambiamento c’è certamente stato. Ho conquistato la sicurezza. Le mie opere possono piacere o non piacere, ma hanno avuto il massimo riconoscimento che si possa avere. Ora ho la sicurezza della loro qualità. Dal punto di vista del denaro, invece, non credo ci sia stato alcun cambiamento. Mia moglie e io abbiamo bisogno di poco.
BIONDI: Molto bene. Messo in evidenza lo spirito farsesco e reso il dovuto omaggio alla previdenza, vogliamo ora parlare del Dolore? Perché ce n’è tanto nelle sue opere?
GOLDING: Perché il mondo ne è intriso. La mia è una grande tristezza per ciò che è in realtà la natura umana. E’ un’idea, una scoperta che mi ha colpito come una mazzata alla fine della guerra. Quando ho scoperto che tutte le atrocità attribuite ai tedeschi erano vere. Ho capito quanto male può esserci nell’uomo. E’ il vero nostro problema, ciò che dobbiamo combattere se vogliamo continuare a considerarci esseri civili. Questo è il dolore mio e dei miei libri. Tristezza all’ennesima potenza.
BIONDI: Quindi, nel nostro mondo il problema del Male è fondamentale.
GOLDING: Ce n’è tanto. In realtà, penso di aver addirittura aspirato a risolvere il problema del Male, come tanta gente ha fatto e continua a fare. Ma ora so che non ci sono riuscito. Ho solo messo in rilievo che il nostro problema è quello: il Male. Temo che sia insolubile, come del resto quello del Bene. Siamo qui, in bilico tra queste due forze opposte, entrambe in realtà incomprensibili, insolubili in quanto problemi, a cui ci si può solo accostare in termini di sentimento o di esperienza.
BIONDI: E l’Amore?
GOLDING: Oh Dio!... E’ un’espressione su cui la semantica entra in crisi. Quanti significati ha la parola Amore? C’è quello di una persona per un’altra, quello dei genitori, quello dei figli, quello di Dio o per Dio... Che cosa si può dire ancora, sull’Amore, se non che è un concetto universale?
BIONDI: Ma è stato importante nella sua vita?
GOLDING: Lo è stato, certamente. E’ ciò che tutti vanno cercando e, in un certo senso, credo che si possa definire criminale chi non è mai stato capace di trovarlo.
BIONDI: Lei crede in Dio? E se ci crede, come giustifica il fatto che Dio consenta a tanto Male di trionfare nel mondo?
GOLDING: Io credo in Dio, certamente. Ma alla sua domanda non so proprio rispondere. E’ un problema che è stato discusso per migliaia di anni dai sapienti. Io sono solo un narratore. Come posso conoscere le risposte? Posso solo, talvolta, porre i problemi.
BIONDI: Nient’altro?
GOLDING: Non le sembra abbastanza?
BIONDI: E per il futuro? Che progetti ha?
GOLDING: Ahimè! Prima di tutto devo scrivere il discorso per la cerimonia del Nobel. E una cosa che mi sta facendo impazzire. A settantadue anni si è detto tutto quello che si aveva da dire. Almeno trenta volte. E almeno sei lo si è scritto. E invece si pretende che un uomo, già con il piede nella fossa, abbia ancora qualcosa di nuovo da dire. Come preferirei dover scrivere il discorso di Walesa!
BIONDI: Crede che sia più facile?
GOLDING: E certamente più facile. Ci sono tante cose facili da dire. Badi bene: non intendo «poco importanti». Al contrario, sulla pace ci sono infinite cose della massima importanza che si possono dire in maniera facile. E, ovviamente, la cosa più importante è che l’America e la Russia arretrino entrambe. Di fronte a un simile problema, quelli della letteratura non sono niente... Ma mia moglie mi ha dato un ottimo consiglio. Affrontare questo problema dal punto di vista della letteratura. Perché i letterati sono esseri umani e come tali il problema della pace li investe direttamente, a prescindere dalle questioni politiche. Credo proprio che scriverò questo.
BIONDI: Sua moglie è stata importante anche per la sua attività letteraria?
GOLDING: Molto importante. Vivere con Ann è come avere in casa un consulente editoriale. Legge tutto quello che scrivo nella prima stesura, e poi mi dà i suoi consigli.
BIONDI: Nel suo romanzo di prossima uscita The paper men (Gli uomini di carta), c’è molta Italia. Come mai?
GOLDING: Mia moglie e io amiamo molto l’Italia. Ci siamo stati un’infinità di volte. L’abbiamo percorsa dalle Alpi alla Sicilia. I paesaggi. Un incredibile accumulo di storia. La bellezza della lingua. Dovreste continuamente cantarla, non parlarla. E la regolarità di fattezze della gente. Una cosa che fa pensare all’evoluzione definitiva e perfetta di una forma, di qualcosa che non è più migliorabile. Siamo spinti verso l’Italia dallo stesso spirito che animava Shelley, Byron, Keats, i Browning... Una volta ci siamo arrivati dalla Grecia. Siamo sbarcati a Brindisi, Ann, io e i due ragazzi. Doveva essere venticinque anni fa. Tempi magnifici. Di grande povertà e allegria. Non avevamo quasi più un soldo, ma io ho tranquillizzato tutti. A Milano — ho detto — c’è il mio editore italiano. Avrò ben maturato qualche diritto d’autore. Invece non c’era neanche una lira. Dei miei libri non si era praticamente venduta una copia. Povero me! Devo però dire che la mia famiglia si è comportata in un modo assai nobile. Per giorni e giorni si è nutrita di sola pasta, per consentire a me di nutrirmi di buon vino italiano. Ah, Italia...
BIONDI: Ci tornerà?
GOLDING: Senza dubbio. Spero nella prossima primavera. Prima andrò per un mese o due, o forse anche tre, in Egitto. Una casa editrice di grossi volumi illustrati mi ha chiesto un testo di impressioni su questo paese, che conosco già bene. Ci andrò con mia moglie e un fotografo, e avremo a nostra disposizione un battello, appositamente noleggiato, per andare su è giù a nostro piacimento lungo il Nilo. Sarà un’esperienza magnifica. E al ritorno conto proprio di fermarmi qualche giorno a Roma o a Milano.
BIONDI: E l’aneddoto che mi ha raccontato a proposito dell’albergo è vero?
GOLDING: Assolutamente no. Ma non lo trova bello?
(Amica, novembre 1983)