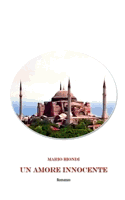Estratto da una recensione collettiva: “Le streghe di Eastwick” (1986)
E tantissimo ce ne vorrebbe per tradurre come si deve John Updike, autore di grande eleganza formale, anche se un po’ fatua e ormai molto logora, che nelle Streghe di Eastwick racconta al lettore il solipsismo della classe medio-alta White-Anglo-Saxon-Protestant. O, meglio, delle sue donne. Un solipsismo che rimane tale anche se lo si «finge» (fiction) gremito di attività, eventi e personaggi. Tre signore non più giovanissime cercano di ammazzare il tempo scrivendo cronachette mondane per il giornale locale, creando figurine di terracotta, suonando il violoncello, chiacchierando senza tregua, coprendo di contumelie le pari sesso, copulando con vari uomini assortiti tra cui un pastore unitario, reprimendo intime pulsioni lesbiche (uffa!), disputandosi un inventore di vernici che forse è addirittura il diavolo e che comunque anche lui... e compiendo perfidi malefici, con corollario di autentiche morti e improbabili matrimoni. Che bravura di costruzione! Che eleganza! Ma quanta freddezza!
John Updike, Le streghe di Eastwick, Rizzoli
Europeo, 22 marzo 1986