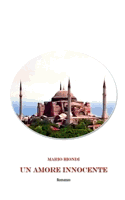Scrive di: Anne Tyler
Profilo letterario (1997)
Profilo letterario (1997)
© Mario Biondi
Divieto di riproduzione integrale
e obbligo di citazione (per cortesia...)
Stati Uniti, terra e società di contrasti forse mai visti nella storia dell’umanità. Scritta così, in apertura di un dossier su un’importante scrittrice, può sembrare una formidabile banalità. Invece non lo è e costituisce, al contrario, una profonda verità da cui la letteratura di quel paese ha tratto e trae grandissima parte della sua vita e vitalità. Spazi sterminati, ricchezze immense, straordinario sviluppo scientifico e tecnologico. E, per converso, località minuscole e rannicchiate nella propria angustia, grandi sacche di povertà materiale e spirituale, scuolette locali basate sul nozionismo più elementare.
La letteratura americana si è sviluppata di conseguenza, regalandoci indimenticabili figure di grandi gentiluomini e di tycoon: da Babbit di Sinclair Lewis a tanti personaggi di Henry James ed Edith Wharton, dai Morgan e Ford di Doctorow al diluvio di sfrenati super ricchi della narrativa tecno-popolare. Ma accanto a essi tanta gente semplice e tanta vita comune: dalla Spoon River Anthology a Tom Sawyer e Huckleberry Finn, da Ethan Frome (sempre Wharton) a "Coniglio" Angstrom di John Updike, dai personaggi minimi di John Cheever a quelli ancor più piccoli di Raymond Carver e della cosiddetta ed effimera onda "minimalista".
Tra i più recenti grandi creatori di "gente comune" spicca senza dubbio Anne Tyler, una narratrice che, di racconto in racconto, di romanzo in romanzo, è andata confermandosi come forse la più interessante esponente della penultima leva di scrittori Usa. Come ha scritto un’attenta commentatrice americana: «I suoi personaggi sono sempre un po’ eccentrici, ma al tempo stesso molto famigliari. Li si può riconoscere nella gente con cui si ha a che fare giorno per giorno... Persone comuni, che vivono una vita comune».
Il tutto però fatto vivere sulla pagina con straordinaria qualità di scrittura, sapiente capacità di strutturare e variegare la vicenda, acutezza di sguardo per i personaggi, delicato sense of humour. La frase di Anne Tyler scorre impeccabile, elegante, nervosa. La sua lingua è un americano splendido, intensamente sensibile alle sfumature gergali e dialettali. Eccezionali slanci di vis comica illuminano un tessuto di profonda malinconia.
A quanto sopra va tuttavia contrapposto almeno un difetto. La straordinaria capacità di creare un numero vastissimo di personaggi, inserendoli in composizioni sempre più ampie, tende qua e là a creare un senso di vuoto, larghi tratti in cui il lettore rischia di non seguire il filo della narrazione e di annoiarsi. Ma poi, di colpo, ecco la folgorante invenzione patetica o il formidabile scatto comico, e l’attenzione è nuovamente catturata. Non tutti i testi della Tyler sono di uguale livello letterario, ma il loro interesse (se non altro dal punto di vista umano) è sempre alto. Come ha argutamente scritto una commentatrice americana in una recensione del suo ultimo romanzo, diramata in rete telematica: «Avere un nuovo libro della Tyler è comunque meglio che non averlo».
Il difetto più largamente riscontrato e contestato alla scrittrice è tuttavia la debolezza del finale di molte sue composizioni, soprattutto le più vaste. La soluzione del finale malinconico, che lascia tutti vagamente scontenti, è una scappatoia. Come ha scritto la medesima arguta commentatrice: «Il romanzo Per puro caso offre brani mirabili. Ma l’intreccio cade come un vecchio collant sceso alle caviglie». E lo stesso si può dire per diversi altri suoi libri.
La strenua ed encomiabile determinazione con cui Anne Tyler difende la sua vita privata rende difficile scrivere di lei. Non ha mai, per esempio, voluto venire in Italia per uno dei canonici giri tra interviste distratte e sensazionalistiche, sfilate di moda e salotti televisivi che sembrano ormai l’unico modo per lanciare libri e scrittori nel nostro paese. Ma anche a casa sua si nega ostinatamente a interviste e apparizioni pubbliche. Ciò che per lei conta è il disciplinato mestiere di scrittrice. Un atteggiamento di cui si può soltanto prendere atto con profonda ammirazione.
Dopo i primi anni movimentati, Anne Tyler è quasi sempre vissuta a Baltimora, che fa da scenario alla stragrande maggioranza delle sue opere, con qualche escursione più o meno rapida nel Sud est degli Stati Uniti. Ben lungi dalle "mille luci di New York" e dal liberatorio mito west-californiano, da Jack London alla letteratura beatnick, a Moon Palace di Paul Auster. È quindi quasi sicuramente alle sue ambientazioni (oltre che probabilmente alla Pennsylvania di John Updike) che si riferiva Jay McInerney in un acido articolo contro la critica americana, pubblicato da Esquire, dove scriveva più o meno che, dopo un po’, dei veri o finti tic delle sterminate famiglie di Baltimora (o del medio Sud americano) non se ne può più. A prescindere dalle opinioni di McInerney (forse l’unico vero sopravvissuto dell’onda avventurosamente definita "minimalista)", di simili tic, nei libri di Anne Tyler, se ne trova veramente in eccesso.
Gente di Baltimora o gente del Sud est; "gente comune". Nei romanzi della Tyler può anche comparire la vedova ricchissima o la famiglia eminente, ma sempre colte nel momento della decadenza, della crisi, chiuse su se stesse e nei propri tic. E, soprattutto, rese reali proprio dal rapporto con un personaggio "comune" e pressoché inevitabilmente "svitato", quasi un "innocente" alla Mussorgski, un "idiota" alla Dostoevski: vengono in mente gli studi di letteratura russa fatti dall’autrice.
La Tyler coltiva un interesse per la marginalità così fondamentalmente radicato e scatenante che, chi basa l’analisi critica essenzialmente sugli elementi di autobiografismo, non può non ascriverlo alle sue stesse scelte di vita (il matrimonio con il medico di origine iraniana Modarressi, per esempio): ma anche l’interpretazione autobiografica è una scappatoia a cui il critico dovrebbe cedere con attentissima misura.
Il primo incontro del largo pubblico italiano con la Tyler avvenne una decina di anni or sono. Come non di rado capita, non fu un incontro di natura letteraria ma cinematografica: l’uscita del bel film Turista per caso (1988), tratto da uno dei suoi romanzi più belli, The Accidental Tourist (1985), che la Longanesi aveva già pubblicato nel 1986 con il non preciso titolo Il turista involontario. Fu, per fortuna, un incontro foriero di un’amicizia non esaltante in termini quantitativi ma solida e duratura (che è meglio). La fortuna fu tale che il pubblico italiano riscoprì Ristorante Nostalgia, bellissimo, malinconico romanzo con cui la Longanesi aveva cercato di lanciare l’autrice già agli inizi del 1984.
Pervicacemente decisa, come si è detto, a difendere la sua vita privata, e quindi immune da qualsiasi tipo di moda e sensazionalismo, la Tyler subisce tutti gli svantaggi di questo suo atteggiamento ma ne gode anche tutti i vantaggi, che sono superiori. Nei suoi confronti nessuno ha mai inneggiato al fenomeno letterario, alla novità assoluta, alla lettura travolgente, alla "star", ma i suoi lettori non la seguono con fedeltà.
La prima famiglia di "svitati" veramente indimenticabile che si incontra nei suoi libri è quella di Perla Tull, protagonista dell’amaro Ristorante Nostalgia. A tutti i suoi componenti — la stessa Perla e i suoi tre figli — manca precisamente il senso della famiglia. E con esso, in realtà, il senso di una vita appagante e compiuta. Invano il figlio Ezra continua per venticinque anni a invitare la madre, il fratello e la sorella nel suo ristorante (“Ristorante Nostalgia”, sì, ma più precisamente “Nostalgia di Casa”). Quelle che dovrebbero essere tranquille riunioni di famiglia, intese a trovare finalmente un comune linguaggio e modo di invecchiare con serenità, si trasformano ogni volta in amare occasioni di recriminazioni e nuove fratture.
La seconda indimenticabile famiglia di "svitati", ma questa volta allegramente comica, è quella di Macon Leary, protagonista di Turista per caso. Macon è un uomo di pedante precisione, ha suoi incrollabili sistemi che nessuno riuscirebbe a fargli modificare. A una serie di sistemi sono improntate la sua vita e la sua professione, quella di riluttante viaggiatore professionista (come starebbe più volentieri a casa!) in quanto compilatore di guide per altri professionisti del viaggio. Neanche il fatto che un giorno sua moglie gli annunci di aver deciso di andarsene riesce a scuotere tanta sistematicità.
Perplesso, Macon elabora un’altra serie di sistemi di pronto impiego da applicare alla nuova vita domestica di single: per esempio per risparmiare sui panni da mettere nel bucato e poi per lavarli. Ma una certa crisi c’è, e allora non rimane che ricorrere all’àncora rappresentata dalla famiglia, ai pensosi ma scombinatissimi fratelli, persone di mezza età che conducono tutte assieme una vita di pacifico, pedante e nevrotico celi-nubilato di gruppo.
L’equilibrio viene però definitivamente spezzato dalla comparsa nella vita di Macon della vera "innocente", una giovane ingaggiata per addestrare un cane non meno nevrotico di tutta la cerchia del proprietario. La diversità di Muriel, indipendente ragazza madre, forte di una sua logica strampalata ma ferrea, fa scoprire a Macon la vera vita in comune.
Le Lezioni di respiro sono quelle che vengono impartite negli ospedali non soltanto alle gestanti ma anche a chi fatica a respirare a causa dell’asma. Ed è questo il senso del titolo del romanzo che ha guadagnato ad Anne Tyler il Premio Pulitzer. La vita, con le sue minuscole contrarietà e disattenzioni, può veramente dare l’asma, far mancare il respiro. È ciò che arriva implicitamente a pensare Maggie Moran nel breve viaggio in auto che fa con il marito Ira per andare (da Baltimora) al funerale di quello della migliore amica. Pur nella sua brevità, il viaggio si converte in sottile e insistente motivo di riflessione sul senso della vita personale della protagonista e di quelle dei componenti il suo piccolo mondo di parenti e amici, non ancora antico ma già logoro.
Se i libri di Anne Tyler più amati dal pubblico sono probabilmente Turista per caso e Lezioni di respiro, quello che più amo personalmente è Possessi terreni. Divertente, commovente, a tratti addirittura emozionante, è inoltre il più prossimo allo spirito degli altri due (che per altro precede di ben otto e undici anni). Una madre di famiglia, incappata in un goffo tentativo di rapina in banca, viene rapita da uno squinternato gangster, un giovane che campa di espedienti. A poco a poco, però, durante la fuga, tra i due si crea una sorta di sempre più scoperta solidarietà. Sono entrambi sconfitti, lui dalla sua vita di drop out, lei dalla sua condizione di donna comune.
Mentre scappano su una sgangheratissima auto rubata, dove la donna è praticamente segregata, le buffe vicende della fuga (che ricordano da lontano quelle di film come Sugarland Express di Spielberg o Getaway di Pekimpah, rimanendo tuttavia esenti dal loro spirito di violenza — una vera e propria filosofia —, sostituendola con un profondo e malinconico senso di ironia) si intrecciano con quelle — rievocate — della vita della donna, dalla grigia infanzia e adolescenza fino all’ancor più grigia condizione di moglie e madre. (E le somiglianze tra il bambino adottivo della protagonista e il figlio della Muriel di Turista sono a dir poco impressionanti.)
Il romanzo raggiunge vertici di comicità e tenerezza quando i due fuggiaschi arrivano a rapire la giovanissima fidanzatina del balordo, incinta e rinchiusa in una casa di correzione. La fuga continua, finché la donna, ottenuta finalmente la libertà dal balordo — che ha stabilito con lei un vero e proprio rapporto madre-figlio — gli consegna un assegno da cento dollari affinché possa scappare lontano e libero con la sua ragazza. Erano i suoi "possessi terreni", quelli con cui sognava di sfuggire lei stessa al grigiore della propria vita, di conquistare la propria libertà.
L’archetipo del personaggio tyleriano di donna marginale in cerca di realizzazione è tuttavia la protagonista del giovanile A Slipping Down Life (più o meno Una vita tutta una frana), romanzo breve rimasto stranamente inedito in Italia. Una storia bellissima, di amaro, commovente spessore, molto giocata sulle distorsioni del linguaggio giovanile americano di quasi trent’anni fa, e forse per questo non ancora tradotta, in quanto difficile da rendere in tutte le sue sfumature. La vicenda è quella dello strampalato, dolente rapporto che si crea tra una adolescente grassa e brutta e un poco meno che coetaneo cantautore rock.
Per richiamare l’attenzione del ragazzo, durante un concerto la ragazzina arriva addirittura a incidersene sulla fronte il nome con un coltello. Il furbo compagno di band e manager del cantautore trasforma la cosa in elemento pubblicitario. Tutte le sere la ragazza viene portata al concerto e sistemata in prima fila con la sua scritta sulla fronte. Tra i due si crea un rapporto di odio-amore Quando però il ragazzo decide di togliersi dai piedi la spasimante, affrancandosi dalla sua tutela "promozionale", è il disastro. Il pubblico, che fino ad allora aveva dimostrato di amarlo, non lo vuole più. Il cantautore non trova più lavoro. La vita appare, appunto "tutta una frana".
La ragazza viene riesumata. Si arriva addirittura a un folle, sfortunato matrimonio tra i due. Alla fine, per cercare di rilanciare le sorti del giovane cantante, lei inventa un proprio rapimento. Ma al momento di metterlo in atto è impossibilitata a partecipare all’operazione: suo padre muore. Tutto va in fumo. La vita è sempre più "una frana". Fino alla desolata fine dell’assurdo rapporto matrimoniale tra i due sposi-ragazzi.
Il perenne amore di Anne Tyler per il mondo marginale nella sua versione giovanile le fa creare altri personaggi non totalmente riusciti, come quelli di The Clock Winder e If Morning Ever Comes (successivamente tradotti in Italia). Anche la protagonista del primo è una giovane non realizzata. È piombata per puro caso nelle vicende famigliari di un’anziana, ricchissima vedova, madre di uno stuolo di figli nevrotici e viziati, e vi si è istallata per fare il factotum di casa, "caricando gli orologi" (come dice il titolo), ma anche provocando un’irreparabile serie di pasticci, tra cui il suicidio di uno dei figli, invaghitosi di lei in un modo prossimo all’isteria.
Piano piano la giovane arriva a rendersi indispensabile, un altro figlio si innamora di lei, ma sulle prime lei non vuole neanche lui. Né di tutto ciò (ineluttabilità, innamoramenti) il lettore arriva mai a darsi motivo. Al di là dei suoi vestiti casualmente dimessi e dei suoi modi da ragazzaccio, non si capisce perché la presenza della giovane arrivi ad assumere una simile importanza catartica. A poco a poco la storia si sfilaccia, il catalogo di nevrosi dei personaggi diventa quasi intollerabile. Rimane la qualità della scrittura, ma appaiono in agguato, in prospettiva, il mini-minimalismo di David Leavitt e persino il dolciastro psicologizzare di Susan Minot sul rapporto genitori-figli.
A dominare If Morning Ever Comes è un’ennesima famiglia del Centro sud degli Stati Uniti. Una madre vedova e nervosa. Una nonna pazzerellona. Quattro o cinque sorelle (nei romanzi della Tyler i parenti sono sempre talmente tanti — e spesso così sbiaditi nella loro ordinarissima follia — che uno se li dimentica). L’unico maschio studia alla Columbia (come aveva fatto la Tyler). Gli arriva la notizia che la sorella maggiore ha piantato il marito ed è tornata a casa con la figlioletta. Corre a casa anche lui per vedere di mettere un po’ di ordine. In pratica lo mette soltanto perché ricompare il marito abbandonato. Dal canto suo, fatta un’appagante rimpatriata nelle nevrosi e memorie di famiglia, finisce con il tornare a New York portandosi dietro la sua ragazza dei felici tempi dell’adolescenza.
Meglio riusciti, per quanto lontani dall’essere perfetti, appaiono invece La moglie dell’attore e L'amore paziente. Il primo dei due promette moltissimo, ma mantiene assai meno. Morgan, il protagonista, mostra una certa affinità con l’indimenticabile Garp di John Irving, ma la distanza tra i due è enorme. Il suo strampalato modo di vivere, il suo assurdo abbigliamento non trovano nessuna autentica giustificazione. Ancora una volta il lettore non può fare a meno di chiedersi: Perché si comporta così? Quali i motivi di tanta bislaccheria?
Morgan è un signore sui cinquanta, felicemente sposato, noiosamente padre di uno stuolo di figlie (anche qui). Gestisce un negozio di ferramenta e casalinghi di proprietà della famiglia della moglie. In realtà non fa niente. Vive in una sorta di delirio privato, inventandosi praticamente la vita giorno per giorno. Indossa abiti bizzarri, ha un’autentica collezione di cappelli assurdi. Si fa passare ora per questo, ora per quello.
A un certo punto, spacciandosi per medico, irrompe nella vita di una giovane coppia di marionettisti; durante una recita lei (Emily) viene presa dalle doglie e finisce con il partorire nell’auto di Morgan. Tra i tre (più la neonata, più tutta la pletorica famiglia di Morgan) si crea un ennesimo rapporto vischioso che si conclude con l’innamoramento (una decina di anni più tardi) tra lui ed Emily, che scappano per farsi una nuova vita. Naturalmente portandosi dietro le marionette, ovvero piantando in asso la vita reale. La vicenda si va via via frantumando, la comicità va facendosi sempre più meccanica, macchiettistica. Rimane, di nuovo, la qualità della scrittura.
Ugualmente non riuscito fino in fondo è L'amore paziente, corposo romanzo che fino a due terzi si legge con autentica passione. Ma poi la nevrosi di gruppo dei personaggi diventa quasi intollerabile. Il finale può essere giudicato, a seconda dei gusti, straziante o pessimo. L’ambiente è l’imprescindibile Baltimora. Uno scapolone, sempre vissuto all’ombra della mamma, non esce mai di casa. Se ne sta tappato in camera sua a fare collage e sculture. Soffre di agorafobia e di quasi tutte le nevrosi note. Quando muore la mamma, è in agguato la catastrofe. Gli rimane sulla schiena la piccola pensione (nel senso di boarding house) gestita dalla defunta. Come per incanto vi arriva però una donna scappata dal marito con un amante, portandosi dietro la figlioletta di un paio d’anni.
Lui se ne innamora, di punto in bianco la vita gli si ribalta davanti. Quando anche l’amante si defila, è quasi inevitabile che lui si dichiari. Lei, commossa, dice di sì. Siccome il marito le ha scritto che non le concederà mai il divorzio, non possono sposarsi. Però fingono di averlo fatto e mettono al mondo cinque figli. La vita si fa rosa per entrambi. La vecchia boarding house si rinserra come una famiglia di nevrotiche zie affettuose sulla nevicata di pargoli.
Sempre discretamente squinternato, e comunque rigorosamente agorafobico, il protagonista diventa un artista quasi celebre. E fino a questo punto il libro è bellissimo. Poi comincia la frana. Ottenuto inopinatamente il divorzio, lei gli chiede di sposarla. Lui dice sì, certo, come no, ma poi viene preso da un autentico diluvio di dubbi, si immerge nel lavoro e si dimentica di farlo. Lei allora scappa con tutti e sei i figli, andando a rintanarsi in una baracca senza riscaldamento e senza niente. Lui precipita nell’ignavia, anche se vanamente gli si infila nel letto una giovanissima pensionante (assolutamente non plausibile). Finché trova il coraggio di munirsi di una carta di Baltimora, di uscire di casa e di prendere un autobus per andare dalla ex compagna e dai bambini che ama tanto.
Le cose vanno a finire bene, pensa il lettore. Lei torna a casa con quei poveri bambini, che sarebbe l’unica cosa logica dopo tanta confusione. Invece niente. Chissà perché, la tuttora innamoratissima e amatissima transfuga decide di rimanere nella sua baracca gelida, con i figli malati di scabbia e geloni. Il protagonista finisce i suoi giorni nella più totale ignavia, insieme a un’anziana pensionante.
In Searching for Caleb (successivamente pubblicato in Italia) i componenti della nevrotica, eminente famiglia decaduta di Baltimora non si riesce nemmeno a contarli, perché si estendono addirittura su quattro generazioni. I discendenti dei due rami, alla terza generazione, pur essendo cugini decidono giovanissimi di sposarsi, provocando un tremendo senso di disordine in tutta la famiglia. Comunque se la cavano benissimo. Lui, bastian contrario, per rompere l’ordinatissima e laboriosa tradizione di famiglia ha deciso di essere pervicacemente disordinato e strampalato. Fa mille mestieri scombinati. Lei scopre la lettura del futuro con le carte e la pratica con grande successo. Essendo lui decisamente (ma incomprensibilmente) "svitato", continuano a cambiare residenza, rimanendo però sempre (quasi una coazione) in un raggio di cento miglia da Baltimora.
Chi è il Caleb del titolo? È il fratello del pignolissimo nonno dei due, un ex giudice. È scomparso senza lasciare tracce, e il nonno lo sta cercando più o meno dal 1912. Se n’è andato perché è un maniaco della musica blues. Voleva suonare il violino all’angolo della strada, e niente affatto entrare nella (allora) florida azienda di famiglia. Dopo più o meno settant’anni un detective privato lo rintraccia vivo e vegeto in un ospizio. Per l’emozione, e anche per la rabbia di saperlo così mal ridotto, il fratello-nonno muore dopo avergli scritto una lettera piena di stizza e buon senso. Portato fuori dall’ospizio, il vecchio ex violinista blues (che dopo la fuga si era ovviamente stanziato a New Orleans) non si trova affatto bene in casa dei nipoti e torna (più o meno novantenne) a scappare.
I due ormai maturi nipoti, nella loro rosea "svitataggine", trovano la cosa del tutto normale, anche se sono un po’ amareggiati. Tanto per cambiare vanno a vivere in un camper, forse mettendosi a dirigere un piccolo lunapark viaggiante: siamo sempre nell’ambito del finale dove il lettore deve capire tutto e niente. Una storia fluviale e assolutamente scombinata, con pezzi di grandissima scrittura ma poco di più.
Il valore di The Tin Can Tree, secondo, inconsistente romanzo di una Tyler venticinquenne, risiede unicamente nella sfolgorante qualità della scrittura, in un gergo meridionale alla Mark Twain usato con grande sapienza sperimentale (e quindi praticamente intraducibile in italiano). Una volta tanto le famiglie non sono pletoriche, ma sempre molto nevrotiche. In una catapecchia ai margini di una cittadina del sud (ambiente agricolo, vento, tabacco, pop corn e come massimo frisson il drive-in) vivono due fratelli venti-trentenni, dei quali uno quasi normale ma scappato di casa perché non sopportava il padre.
L’altro, invece, ipocondriaco e afflitto da crisi mistiche, campa alle sue spalle. Di fianco a loro vivono due anziane sorelle che soffrono d’insonnia e picchiettano sul muro affettuosamente preoccupate appena da loro si sente un qualsiasi rumore, a ogni ora della notte. Nella terza parte della baracca vive una famigliola formata da padre, madre, figlio decenne e figlioletta. Quest’ultima muore cadendo da un trattore. La madre perde quasi la testa. La cugina che vive con loro, una giovane depressa, stanca di aspettare che il fratello semisavio mandi a quel paese quello ipocondriaco e la sposi, monta su un autobus e se ne va per tornare a casa sua. (A fare che cosa? Non si sa.)
Il fratellino della bimba morta, afflitto dal clima che aleggia in casa dopo la tragedia, scappa anche lui e va dal vecchissimo padre (a sua volta nevrotico) dei due fratelli. Perché lo faccia, ancora una volta non si capisce. Tutto comunque finisce come si deve. Ciascuno torna a casa, a morire di noia come prima.
Un tipo del tutto particolare di "svitato", di "innocente", è Ian Bedloe, personaggio centrale di Quasi un santo. In lui gli atteggiamenti misticheggianti o esoterizzanti di tanti personaggi della Tyler diventano vero e proprio impulso mistico. Il senso di responsabilità per una tragedia esplosa nella — e soprattutto per effetto della — solita vischiosità della gabbia famigliare gli impone di cercare espiazione e quiete mentale in una comunità religiosa. Per la prima volta, in questo romanzo, l’autrice affonda esplicitamente e spericolatamente il tema della spiritualità.
Non perfettamente riuscito, pur nella qualità complessivamente alta, appare infine Per puro caso, centrato sul personaggio di Delia Grinstead, una quarantenne che vive... dove? A Baltimora. È sposata con un medico e madre di tre figli musoni, ormai grandi. Per quanto si arrovelli non riesce a capire il senso dei rapporti che ha con gli altri, e di conseguenza il senso della sua stessa vita. Durante una vacanza alla spiaggia decide di scegliere la libertà: trova un passaggio su un furgone e sparisce, ancora praticamente in costume da bagno. È appunto sull’annuncio giornalistico della sua scomparsa che fa perno il romanzo. Com’era vestita quando se ne sono perse le tracce? Il marito non se lo ricorda nemmeno. Come i figli, in effetti non l’ha mai "vista", nemmeno nella sua realtà fisica. Figurarsi nello spirito. Ma per fortuna Delia ha con sé i soldi sufficienti per comperarsi un po’ di indumenti e uno spazzolino per i denti con cui affrontare la nuova vita. Una vita che, come sempre, è uno "svitato" misto di allegria e malinconia, tra gente inevitabilmente "comune".
Non verrà mai sottolineato abbastanza quale importanza abbia, per il laboratorio del narratore, affrontare la forma "racconto": lo studio e la composizione di nuclei narrativi da elaborare sperimentalmente in vista (almeno in prospettiva) di forme narrative più complesse: schidionate o incorniciate in disegni più vasti, le loro strutture potranno successivamente servire per la composizione di un romanzo. E il lettore non può non riconoscere nelle donne, nei mariti e nel padre di tre racconti di Anne Tyler — recentemente raccolti in Italia sotto il titolo Il tuo posto è vuoto — i modelli di tanti personaggi poi visti nei romanzi che li hanno seguiti.
Vi sono paesi dove a lettura e scrittura viene ancora annessa un’importanza quasi sacrale. Gli Stati Uniti, per esempio. Si potrà discutere a lungo se ciò abbia antiche radici socio-culturali o dipenda soprattutto dal fatto che milioni di cittadini statunitensi passano giornalmente almeno un paio di ore sui commuting trains, i treni locali che li portano al lavoro in centro dai loro sobborghi residenziali di estrema periferia (e di nuovo a casa). In quelle due ore la televisione è necessariamente sconfitta: che cosa fare di meglio se non leggere un rapido, buon racconto?
Quali che siano le radici della perdurante e imponente fioritura di racconti in quel paese, sta di fatto che le università e gli istituti di istruzione superiore considerano un dovere avere nel loro staff un writer in residence, uno scrittore residente nel campus e stipendiato proprio per insegnare agli studenti a scrivere, a compilare tesi, tesine, prove scritte d’esame e persino lettere. Ma anche a cimentarsi nella scrittura creativa, nell’ambito di quei corsi di creative writing che negli anni Ottanta hanno prodotto un vero diluvio di giovanissimi scrittori di buone speranze. Non ne è rimasto molto, ma qualcosa sì: la sperimentazione sulla creatività non è fatta per produrre quantità ma per distillare qualità. Ci mancherebbe altro che da ogni corso di fisica uscissero trenta Einstein.
E sta anche di fatto che in quel paese i giornali vengono comperati per essere letti. Quindi hanno l’esigenza di essere scritti. Non soltanto il paludato "New Yorker", ma anche i leggeri e modaioli "Vanity Fair", "Esquire" e "Gentlemen Quarterly", per fare soltanto qualche esempio, non rinuncerebbero per niente al mondo ad avere i loro, per così dire writer in residence: ne andrebbe del loro prestigio e si troverebbero a scontrarsi con la disaffezione dei lettori. Devono pubblicare racconti e persino poesie.
Così sono arrivate fino a noi piccole perle — veri e propri nuclei di laboratorio narrativo — come i racconti di I. B. Singer, di John Cheever, di John Updike eccetera. Un elenco completo riempirebbe le pagine gialle. Tra di essi la smagliante Anne Tyler, che negli anni Settanta, conclusi l’università e gli studi di letteratura russa, fu una delle colonne delle rubriche di racconti pubblicate da "Seventeen" e dal "New Yorker".
Il tuo posto è vuoto è composto da tre racconti omogenei (5 in una successiva edizione), pubblicati tra il ’75 e il ’77 appunto su quest’ultima, raffinata rivista. Il patetico, trepidante incontro di una madre venuta dall’Iran con il figlio emigrato a fare il medico negli Stati Uniti (evidente ombra narrativa del marito della signora Tyler Modarressi): gli effetti di straniamento da marginalità realizzati in “Il tuo posto è vuoto” sono tra i più alti raggiunti dalla Tyler. In “Il bernoccolo delle lingue” viene raccontata la visita al padre, nella remota campagna Usa, di una giovane sposata con un docente italiano (altra marginalità): di quanti padri dei romanzi della Tyler appare l’archetipo. Infine le minuscole problematiche interpersonali di una coppia americana, scatenate dal maniacale presunto malfunzionamento di un’auto che serve da cartina di tornasole per un sottile scontro di caratteri: in “Chi tiene in piedi la baracca” sembra di leggere un concentrato dei motivi di Lezioni di respiro e di Per puro caso.
Vi è infine la recensione al romanzo Quando eravamo grandi, a suo tempo pubblicata sul defunto InfiniteStorie.it nell’autunno 2001 con il titolo “Un mondo splendidamente trasognato”. È un testo mio, di mia proprietà, lo riprendo qui sotto:
Che mondo splendidamente trasognato ci regala Anne Tyler con ogni suo libro. Microcosmi della mente sempre imperniati sulla città di Baltimora, dove (o vicino a dove, o partendo da dove) si svolgono tutte le sue storie. Famiglie in genere pletoriche i cui componenti sono sempre afflitti da tic piccoli o grandi, vissuti come un gioco o irreparabili. Come dimenticare anzitutto, quella del Turista involontario, che molti considerano il suo capolavoro? (Per altri il suo capolavoro è invece Ristorante Nostalgia, e personalmente preferisco lo straordinario Possessi Terreni.)
Nell'ambito di queste famiglie si accalcano personaggi che vivono sempre una vita reale e parallelamente un'altra da sogno, più o meno maniacale, confondendo l'una con l'altra senza più riuscire a distinguerle. Il tutto raccontato con una scrittura di un'eleganza essenziale, fatta di understatement, di notazioni piccole ma sempre nitidissime, di uno humour sottile e (anche per questo) di grande efficacia. Un "piccolo mondo moderno" americano, insomma.
In Quando eravamo grandi la pletorica famiglia è quella dei Davitch, una quantità sterminata di personaggi che va dal centenario prozio Poppy al neonato Abdul. Al centro di essa, quasi per caso, quasi in un sogno (come sempre), si è venuta a collocare la protagonista, Rebecca (Beck), arrivatavi per matrimonio con Joe, che aveva già tre figlie. Beck è rimasta vedova molto presto, e ancora giovanissima si è trovata sulle spalle tutto il peso della famiglia e dell'attività di cui essa campa: l'affitto dell'ottocentesca, grandissima e ormai cadente residenza padronale per feste di vario genere sotto l'insegna commerciale "A Braccia Aperte".
Il prozio è diventato vecchissimo (e nessuno sa fino in fondo perché viva lì). Le tre figliastre (più la quarta figlia, naturale) sono cresciute a hanno a loro volta generato uno stuolo di figli (con un discreto numero di mariti). Tutto attorno ruota un'altra sequela di amici, conoscenti, fornitori, artigiani, che entrano ed escono dalla dimora come se fosse casa loro, sempre ben accolti, sempre ascoltati sia pure nella limitata capacità di attenzione per gli altri che connota tutti i Davitch. "La loro vita", pensa Beck, "era una specie di patchwork di eventi scollegati..."
Una situazione che discende molto da vicino da quella del Turista involontario, come da quel bambino (e da quelli di Possessi Terreni) discende il ragazzino Peter (acquisito alla famiglia per matrimonio), timido e introverso nelle attività proprie della sua giovanissima età, ma in realtà un piccolo genio della tecnica. Così, di evento bizzarro in eventi bizzarro, di personaggio strampalato in personaggio strampalato, Beck si è ritrovata ad avere cinquantatré anni e a chiedersi come sia finita lì, e dove sia invece andata a finire la sua vera vita di studentessa modello, appassionata di Storia e quasi sicuramente destinata all'attività accademica (come il suo ragazzo di allora). E si chiede se sia in qualche modo possibile tornare a quella vita. Ma, incalza il centenario Poppy: "La vera vita non esiste. La vera vita è quella che capita di vivere, qualunque sia". Così Beck rinuncia al vagheggiato quanto improbabile ricongiungimento con il passato e - non diversamente dalla Charlotte di Possessi terreni - finisce con il rimanere lì, nel suo piccolo, affollato e bislacco microcosmo da sogno, aggiungendo una piccola perla alla corposa bibliografia di Anne Tyler (15 libri, di cui 11 tradotti in Italia) (allora, nda).
A riprova della sua popolarità basterebbe guardare il numero delle "recensioni di lettori" che compaiono nel sito di Amazon.com. C'è chi il libro lo ha amato moltissimo, chi così così, chi niente (pochissimi, per altro): è la normale sfida che affronta ogni scrittore quando sottopone il suo lavoro al giudizio del pubblico. Ma le recensioni sono 111. Non capita a molti di avere tanti lettori così appassionati da scrivere e inviare una recensione telematica. Anche in questo modo Anne Tyler si conferma, oltre che forse la miglior scrittrice americana vivente, sicuramente una delle più popolari.
Anne Tyler è nata il 25 ottobre 1941 a Minneapolis (Minnesota) e nel 1961 ha conseguito un Bachelor of Arts presso la Duke University di Durham (North Carolina). Quindi ha studiato letteratura russa alla Columbia University di New York. Vive a Baltimora. Ha praticamente sempre scritto, visto che la sua prima pubblicazione risale al 1965. Nel 1989 le è stato assegnato il Pulitzer Prize per il romanzo Breathing Lessons (Lezioni di respiro).
La letteratura americana si è sviluppata di conseguenza, regalandoci indimenticabili figure di grandi gentiluomini e di tycoon: da Babbit di Sinclair Lewis a tanti personaggi di Henry James ed Edith Wharton, dai Morgan e Ford di Doctorow al diluvio di sfrenati super ricchi della narrativa tecno-popolare. Ma accanto a essi tanta gente semplice e tanta vita comune: dalla Spoon River Anthology a Tom Sawyer e Huckleberry Finn, da Ethan Frome (sempre Wharton) a "Coniglio" Angstrom di John Updike, dai personaggi minimi di John Cheever a quelli ancor più piccoli di Raymond Carver e della cosiddetta ed effimera onda "minimalista".
Tra i più recenti grandi creatori di "gente comune" spicca senza dubbio Anne Tyler, una narratrice che, di racconto in racconto, di romanzo in romanzo, è andata confermandosi come forse la più interessante esponente della penultima leva di scrittori Usa. Come ha scritto un’attenta commentatrice americana: «I suoi personaggi sono sempre un po’ eccentrici, ma al tempo stesso molto famigliari. Li si può riconoscere nella gente con cui si ha a che fare giorno per giorno... Persone comuni, che vivono una vita comune».
Il tutto però fatto vivere sulla pagina con straordinaria qualità di scrittura, sapiente capacità di strutturare e variegare la vicenda, acutezza di sguardo per i personaggi, delicato sense of humour. La frase di Anne Tyler scorre impeccabile, elegante, nervosa. La sua lingua è un americano splendido, intensamente sensibile alle sfumature gergali e dialettali. Eccezionali slanci di vis comica illuminano un tessuto di profonda malinconia.
A quanto sopra va tuttavia contrapposto almeno un difetto. La straordinaria capacità di creare un numero vastissimo di personaggi, inserendoli in composizioni sempre più ampie, tende qua e là a creare un senso di vuoto, larghi tratti in cui il lettore rischia di non seguire il filo della narrazione e di annoiarsi. Ma poi, di colpo, ecco la folgorante invenzione patetica o il formidabile scatto comico, e l’attenzione è nuovamente catturata. Non tutti i testi della Tyler sono di uguale livello letterario, ma il loro interesse (se non altro dal punto di vista umano) è sempre alto. Come ha argutamente scritto una commentatrice americana in una recensione del suo ultimo romanzo, diramata in rete telematica: «Avere un nuovo libro della Tyler è comunque meglio che non averlo».
Il difetto più largamente riscontrato e contestato alla scrittrice è tuttavia la debolezza del finale di molte sue composizioni, soprattutto le più vaste. La soluzione del finale malinconico, che lascia tutti vagamente scontenti, è una scappatoia. Come ha scritto la medesima arguta commentatrice: «Il romanzo Per puro caso offre brani mirabili. Ma l’intreccio cade come un vecchio collant sceso alle caviglie». E lo stesso si può dire per diversi altri suoi libri.
La strenua ed encomiabile determinazione con cui Anne Tyler difende la sua vita privata rende difficile scrivere di lei. Non ha mai, per esempio, voluto venire in Italia per uno dei canonici giri tra interviste distratte e sensazionalistiche, sfilate di moda e salotti televisivi che sembrano ormai l’unico modo per lanciare libri e scrittori nel nostro paese. Ma anche a casa sua si nega ostinatamente a interviste e apparizioni pubbliche. Ciò che per lei conta è il disciplinato mestiere di scrittrice. Un atteggiamento di cui si può soltanto prendere atto con profonda ammirazione.
Dopo i primi anni movimentati, Anne Tyler è quasi sempre vissuta a Baltimora, che fa da scenario alla stragrande maggioranza delle sue opere, con qualche escursione più o meno rapida nel Sud est degli Stati Uniti. Ben lungi dalle "mille luci di New York" e dal liberatorio mito west-californiano, da Jack London alla letteratura beatnick, a Moon Palace di Paul Auster. È quindi quasi sicuramente alle sue ambientazioni (oltre che probabilmente alla Pennsylvania di John Updike) che si riferiva Jay McInerney in un acido articolo contro la critica americana, pubblicato da Esquire, dove scriveva più o meno che, dopo un po’, dei veri o finti tic delle sterminate famiglie di Baltimora (o del medio Sud americano) non se ne può più. A prescindere dalle opinioni di McInerney (forse l’unico vero sopravvissuto dell’onda avventurosamente definita "minimalista)", di simili tic, nei libri di Anne Tyler, se ne trova veramente in eccesso.
Gente di Baltimora o gente del Sud est; "gente comune". Nei romanzi della Tyler può anche comparire la vedova ricchissima o la famiglia eminente, ma sempre colte nel momento della decadenza, della crisi, chiuse su se stesse e nei propri tic. E, soprattutto, rese reali proprio dal rapporto con un personaggio "comune" e pressoché inevitabilmente "svitato", quasi un "innocente" alla Mussorgski, un "idiota" alla Dostoevski: vengono in mente gli studi di letteratura russa fatti dall’autrice.
La Tyler coltiva un interesse per la marginalità così fondamentalmente radicato e scatenante che, chi basa l’analisi critica essenzialmente sugli elementi di autobiografismo, non può non ascriverlo alle sue stesse scelte di vita (il matrimonio con il medico di origine iraniana Modarressi, per esempio): ma anche l’interpretazione autobiografica è una scappatoia a cui il critico dovrebbe cedere con attentissima misura.
Il primo incontro del largo pubblico italiano con la Tyler avvenne una decina di anni or sono. Come non di rado capita, non fu un incontro di natura letteraria ma cinematografica: l’uscita del bel film Turista per caso (1988), tratto da uno dei suoi romanzi più belli, The Accidental Tourist (1985), che la Longanesi aveva già pubblicato nel 1986 con il non preciso titolo Il turista involontario. Fu, per fortuna, un incontro foriero di un’amicizia non esaltante in termini quantitativi ma solida e duratura (che è meglio). La fortuna fu tale che il pubblico italiano riscoprì Ristorante Nostalgia, bellissimo, malinconico romanzo con cui la Longanesi aveva cercato di lanciare l’autrice già agli inizi del 1984.
Pervicacemente decisa, come si è detto, a difendere la sua vita privata, e quindi immune da qualsiasi tipo di moda e sensazionalismo, la Tyler subisce tutti gli svantaggi di questo suo atteggiamento ma ne gode anche tutti i vantaggi, che sono superiori. Nei suoi confronti nessuno ha mai inneggiato al fenomeno letterario, alla novità assoluta, alla lettura travolgente, alla "star", ma i suoi lettori non la seguono con fedeltà.
La prima famiglia di "svitati" veramente indimenticabile che si incontra nei suoi libri è quella di Perla Tull, protagonista dell’amaro Ristorante Nostalgia. A tutti i suoi componenti — la stessa Perla e i suoi tre figli — manca precisamente il senso della famiglia. E con esso, in realtà, il senso di una vita appagante e compiuta. Invano il figlio Ezra continua per venticinque anni a invitare la madre, il fratello e la sorella nel suo ristorante (“Ristorante Nostalgia”, sì, ma più precisamente “Nostalgia di Casa”). Quelle che dovrebbero essere tranquille riunioni di famiglia, intese a trovare finalmente un comune linguaggio e modo di invecchiare con serenità, si trasformano ogni volta in amare occasioni di recriminazioni e nuove fratture.
La seconda indimenticabile famiglia di "svitati", ma questa volta allegramente comica, è quella di Macon Leary, protagonista di Turista per caso. Macon è un uomo di pedante precisione, ha suoi incrollabili sistemi che nessuno riuscirebbe a fargli modificare. A una serie di sistemi sono improntate la sua vita e la sua professione, quella di riluttante viaggiatore professionista (come starebbe più volentieri a casa!) in quanto compilatore di guide per altri professionisti del viaggio. Neanche il fatto che un giorno sua moglie gli annunci di aver deciso di andarsene riesce a scuotere tanta sistematicità.
Perplesso, Macon elabora un’altra serie di sistemi di pronto impiego da applicare alla nuova vita domestica di single: per esempio per risparmiare sui panni da mettere nel bucato e poi per lavarli. Ma una certa crisi c’è, e allora non rimane che ricorrere all’àncora rappresentata dalla famiglia, ai pensosi ma scombinatissimi fratelli, persone di mezza età che conducono tutte assieme una vita di pacifico, pedante e nevrotico celi-nubilato di gruppo.
L’equilibrio viene però definitivamente spezzato dalla comparsa nella vita di Macon della vera "innocente", una giovane ingaggiata per addestrare un cane non meno nevrotico di tutta la cerchia del proprietario. La diversità di Muriel, indipendente ragazza madre, forte di una sua logica strampalata ma ferrea, fa scoprire a Macon la vera vita in comune.
Le Lezioni di respiro sono quelle che vengono impartite negli ospedali non soltanto alle gestanti ma anche a chi fatica a respirare a causa dell’asma. Ed è questo il senso del titolo del romanzo che ha guadagnato ad Anne Tyler il Premio Pulitzer. La vita, con le sue minuscole contrarietà e disattenzioni, può veramente dare l’asma, far mancare il respiro. È ciò che arriva implicitamente a pensare Maggie Moran nel breve viaggio in auto che fa con il marito Ira per andare (da Baltimora) al funerale di quello della migliore amica. Pur nella sua brevità, il viaggio si converte in sottile e insistente motivo di riflessione sul senso della vita personale della protagonista e di quelle dei componenti il suo piccolo mondo di parenti e amici, non ancora antico ma già logoro.
Se i libri di Anne Tyler più amati dal pubblico sono probabilmente Turista per caso e Lezioni di respiro, quello che più amo personalmente è Possessi terreni. Divertente, commovente, a tratti addirittura emozionante, è inoltre il più prossimo allo spirito degli altri due (che per altro precede di ben otto e undici anni). Una madre di famiglia, incappata in un goffo tentativo di rapina in banca, viene rapita da uno squinternato gangster, un giovane che campa di espedienti. A poco a poco, però, durante la fuga, tra i due si crea una sorta di sempre più scoperta solidarietà. Sono entrambi sconfitti, lui dalla sua vita di drop out, lei dalla sua condizione di donna comune.
Mentre scappano su una sgangheratissima auto rubata, dove la donna è praticamente segregata, le buffe vicende della fuga (che ricordano da lontano quelle di film come Sugarland Express di Spielberg o Getaway di Pekimpah, rimanendo tuttavia esenti dal loro spirito di violenza — una vera e propria filosofia —, sostituendola con un profondo e malinconico senso di ironia) si intrecciano con quelle — rievocate — della vita della donna, dalla grigia infanzia e adolescenza fino all’ancor più grigia condizione di moglie e madre. (E le somiglianze tra il bambino adottivo della protagonista e il figlio della Muriel di Turista sono a dir poco impressionanti.)
Il romanzo raggiunge vertici di comicità e tenerezza quando i due fuggiaschi arrivano a rapire la giovanissima fidanzatina del balordo, incinta e rinchiusa in una casa di correzione. La fuga continua, finché la donna, ottenuta finalmente la libertà dal balordo — che ha stabilito con lei un vero e proprio rapporto madre-figlio — gli consegna un assegno da cento dollari affinché possa scappare lontano e libero con la sua ragazza. Erano i suoi "possessi terreni", quelli con cui sognava di sfuggire lei stessa al grigiore della propria vita, di conquistare la propria libertà.
L’archetipo del personaggio tyleriano di donna marginale in cerca di realizzazione è tuttavia la protagonista del giovanile A Slipping Down Life (più o meno Una vita tutta una frana), romanzo breve rimasto stranamente inedito in Italia. Una storia bellissima, di amaro, commovente spessore, molto giocata sulle distorsioni del linguaggio giovanile americano di quasi trent’anni fa, e forse per questo non ancora tradotta, in quanto difficile da rendere in tutte le sue sfumature. La vicenda è quella dello strampalato, dolente rapporto che si crea tra una adolescente grassa e brutta e un poco meno che coetaneo cantautore rock.
Per richiamare l’attenzione del ragazzo, durante un concerto la ragazzina arriva addirittura a incidersene sulla fronte il nome con un coltello. Il furbo compagno di band e manager del cantautore trasforma la cosa in elemento pubblicitario. Tutte le sere la ragazza viene portata al concerto e sistemata in prima fila con la sua scritta sulla fronte. Tra i due si crea un rapporto di odio-amore Quando però il ragazzo decide di togliersi dai piedi la spasimante, affrancandosi dalla sua tutela "promozionale", è il disastro. Il pubblico, che fino ad allora aveva dimostrato di amarlo, non lo vuole più. Il cantautore non trova più lavoro. La vita appare, appunto "tutta una frana".
La ragazza viene riesumata. Si arriva addirittura a un folle, sfortunato matrimonio tra i due. Alla fine, per cercare di rilanciare le sorti del giovane cantante, lei inventa un proprio rapimento. Ma al momento di metterlo in atto è impossibilitata a partecipare all’operazione: suo padre muore. Tutto va in fumo. La vita è sempre più "una frana". Fino alla desolata fine dell’assurdo rapporto matrimoniale tra i due sposi-ragazzi.
Il perenne amore di Anne Tyler per il mondo marginale nella sua versione giovanile le fa creare altri personaggi non totalmente riusciti, come quelli di The Clock Winder e If Morning Ever Comes (successivamente tradotti in Italia). Anche la protagonista del primo è una giovane non realizzata. È piombata per puro caso nelle vicende famigliari di un’anziana, ricchissima vedova, madre di uno stuolo di figli nevrotici e viziati, e vi si è istallata per fare il factotum di casa, "caricando gli orologi" (come dice il titolo), ma anche provocando un’irreparabile serie di pasticci, tra cui il suicidio di uno dei figli, invaghitosi di lei in un modo prossimo all’isteria.
Piano piano la giovane arriva a rendersi indispensabile, un altro figlio si innamora di lei, ma sulle prime lei non vuole neanche lui. Né di tutto ciò (ineluttabilità, innamoramenti) il lettore arriva mai a darsi motivo. Al di là dei suoi vestiti casualmente dimessi e dei suoi modi da ragazzaccio, non si capisce perché la presenza della giovane arrivi ad assumere una simile importanza catartica. A poco a poco la storia si sfilaccia, il catalogo di nevrosi dei personaggi diventa quasi intollerabile. Rimane la qualità della scrittura, ma appaiono in agguato, in prospettiva, il mini-minimalismo di David Leavitt e persino il dolciastro psicologizzare di Susan Minot sul rapporto genitori-figli.
A dominare If Morning Ever Comes è un’ennesima famiglia del Centro sud degli Stati Uniti. Una madre vedova e nervosa. Una nonna pazzerellona. Quattro o cinque sorelle (nei romanzi della Tyler i parenti sono sempre talmente tanti — e spesso così sbiaditi nella loro ordinarissima follia — che uno se li dimentica). L’unico maschio studia alla Columbia (come aveva fatto la Tyler). Gli arriva la notizia che la sorella maggiore ha piantato il marito ed è tornata a casa con la figlioletta. Corre a casa anche lui per vedere di mettere un po’ di ordine. In pratica lo mette soltanto perché ricompare il marito abbandonato. Dal canto suo, fatta un’appagante rimpatriata nelle nevrosi e memorie di famiglia, finisce con il tornare a New York portandosi dietro la sua ragazza dei felici tempi dell’adolescenza.
Meglio riusciti, per quanto lontani dall’essere perfetti, appaiono invece La moglie dell’attore e L'amore paziente. Il primo dei due promette moltissimo, ma mantiene assai meno. Morgan, il protagonista, mostra una certa affinità con l’indimenticabile Garp di John Irving, ma la distanza tra i due è enorme. Il suo strampalato modo di vivere, il suo assurdo abbigliamento non trovano nessuna autentica giustificazione. Ancora una volta il lettore non può fare a meno di chiedersi: Perché si comporta così? Quali i motivi di tanta bislaccheria?
Morgan è un signore sui cinquanta, felicemente sposato, noiosamente padre di uno stuolo di figlie (anche qui). Gestisce un negozio di ferramenta e casalinghi di proprietà della famiglia della moglie. In realtà non fa niente. Vive in una sorta di delirio privato, inventandosi praticamente la vita giorno per giorno. Indossa abiti bizzarri, ha un’autentica collezione di cappelli assurdi. Si fa passare ora per questo, ora per quello.
A un certo punto, spacciandosi per medico, irrompe nella vita di una giovane coppia di marionettisti; durante una recita lei (Emily) viene presa dalle doglie e finisce con il partorire nell’auto di Morgan. Tra i tre (più la neonata, più tutta la pletorica famiglia di Morgan) si crea un ennesimo rapporto vischioso che si conclude con l’innamoramento (una decina di anni più tardi) tra lui ed Emily, che scappano per farsi una nuova vita. Naturalmente portandosi dietro le marionette, ovvero piantando in asso la vita reale. La vicenda si va via via frantumando, la comicità va facendosi sempre più meccanica, macchiettistica. Rimane, di nuovo, la qualità della scrittura.
Ugualmente non riuscito fino in fondo è L'amore paziente, corposo romanzo che fino a due terzi si legge con autentica passione. Ma poi la nevrosi di gruppo dei personaggi diventa quasi intollerabile. Il finale può essere giudicato, a seconda dei gusti, straziante o pessimo. L’ambiente è l’imprescindibile Baltimora. Uno scapolone, sempre vissuto all’ombra della mamma, non esce mai di casa. Se ne sta tappato in camera sua a fare collage e sculture. Soffre di agorafobia e di quasi tutte le nevrosi note. Quando muore la mamma, è in agguato la catastrofe. Gli rimane sulla schiena la piccola pensione (nel senso di boarding house) gestita dalla defunta. Come per incanto vi arriva però una donna scappata dal marito con un amante, portandosi dietro la figlioletta di un paio d’anni.
Lui se ne innamora, di punto in bianco la vita gli si ribalta davanti. Quando anche l’amante si defila, è quasi inevitabile che lui si dichiari. Lei, commossa, dice di sì. Siccome il marito le ha scritto che non le concederà mai il divorzio, non possono sposarsi. Però fingono di averlo fatto e mettono al mondo cinque figli. La vita si fa rosa per entrambi. La vecchia boarding house si rinserra come una famiglia di nevrotiche zie affettuose sulla nevicata di pargoli.
Sempre discretamente squinternato, e comunque rigorosamente agorafobico, il protagonista diventa un artista quasi celebre. E fino a questo punto il libro è bellissimo. Poi comincia la frana. Ottenuto inopinatamente il divorzio, lei gli chiede di sposarla. Lui dice sì, certo, come no, ma poi viene preso da un autentico diluvio di dubbi, si immerge nel lavoro e si dimentica di farlo. Lei allora scappa con tutti e sei i figli, andando a rintanarsi in una baracca senza riscaldamento e senza niente. Lui precipita nell’ignavia, anche se vanamente gli si infila nel letto una giovanissima pensionante (assolutamente non plausibile). Finché trova il coraggio di munirsi di una carta di Baltimora, di uscire di casa e di prendere un autobus per andare dalla ex compagna e dai bambini che ama tanto.
Le cose vanno a finire bene, pensa il lettore. Lei torna a casa con quei poveri bambini, che sarebbe l’unica cosa logica dopo tanta confusione. Invece niente. Chissà perché, la tuttora innamoratissima e amatissima transfuga decide di rimanere nella sua baracca gelida, con i figli malati di scabbia e geloni. Il protagonista finisce i suoi giorni nella più totale ignavia, insieme a un’anziana pensionante.
In Searching for Caleb (successivamente pubblicato in Italia) i componenti della nevrotica, eminente famiglia decaduta di Baltimora non si riesce nemmeno a contarli, perché si estendono addirittura su quattro generazioni. I discendenti dei due rami, alla terza generazione, pur essendo cugini decidono giovanissimi di sposarsi, provocando un tremendo senso di disordine in tutta la famiglia. Comunque se la cavano benissimo. Lui, bastian contrario, per rompere l’ordinatissima e laboriosa tradizione di famiglia ha deciso di essere pervicacemente disordinato e strampalato. Fa mille mestieri scombinati. Lei scopre la lettura del futuro con le carte e la pratica con grande successo. Essendo lui decisamente (ma incomprensibilmente) "svitato", continuano a cambiare residenza, rimanendo però sempre (quasi una coazione) in un raggio di cento miglia da Baltimora.
Chi è il Caleb del titolo? È il fratello del pignolissimo nonno dei due, un ex giudice. È scomparso senza lasciare tracce, e il nonno lo sta cercando più o meno dal 1912. Se n’è andato perché è un maniaco della musica blues. Voleva suonare il violino all’angolo della strada, e niente affatto entrare nella (allora) florida azienda di famiglia. Dopo più o meno settant’anni un detective privato lo rintraccia vivo e vegeto in un ospizio. Per l’emozione, e anche per la rabbia di saperlo così mal ridotto, il fratello-nonno muore dopo avergli scritto una lettera piena di stizza e buon senso. Portato fuori dall’ospizio, il vecchio ex violinista blues (che dopo la fuga si era ovviamente stanziato a New Orleans) non si trova affatto bene in casa dei nipoti e torna (più o meno novantenne) a scappare.
I due ormai maturi nipoti, nella loro rosea "svitataggine", trovano la cosa del tutto normale, anche se sono un po’ amareggiati. Tanto per cambiare vanno a vivere in un camper, forse mettendosi a dirigere un piccolo lunapark viaggiante: siamo sempre nell’ambito del finale dove il lettore deve capire tutto e niente. Una storia fluviale e assolutamente scombinata, con pezzi di grandissima scrittura ma poco di più.
Il valore di The Tin Can Tree, secondo, inconsistente romanzo di una Tyler venticinquenne, risiede unicamente nella sfolgorante qualità della scrittura, in un gergo meridionale alla Mark Twain usato con grande sapienza sperimentale (e quindi praticamente intraducibile in italiano). Una volta tanto le famiglie non sono pletoriche, ma sempre molto nevrotiche. In una catapecchia ai margini di una cittadina del sud (ambiente agricolo, vento, tabacco, pop corn e come massimo frisson il drive-in) vivono due fratelli venti-trentenni, dei quali uno quasi normale ma scappato di casa perché non sopportava il padre.
L’altro, invece, ipocondriaco e afflitto da crisi mistiche, campa alle sue spalle. Di fianco a loro vivono due anziane sorelle che soffrono d’insonnia e picchiettano sul muro affettuosamente preoccupate appena da loro si sente un qualsiasi rumore, a ogni ora della notte. Nella terza parte della baracca vive una famigliola formata da padre, madre, figlio decenne e figlioletta. Quest’ultima muore cadendo da un trattore. La madre perde quasi la testa. La cugina che vive con loro, una giovane depressa, stanca di aspettare che il fratello semisavio mandi a quel paese quello ipocondriaco e la sposi, monta su un autobus e se ne va per tornare a casa sua. (A fare che cosa? Non si sa.)
Il fratellino della bimba morta, afflitto dal clima che aleggia in casa dopo la tragedia, scappa anche lui e va dal vecchissimo padre (a sua volta nevrotico) dei due fratelli. Perché lo faccia, ancora una volta non si capisce. Tutto comunque finisce come si deve. Ciascuno torna a casa, a morire di noia come prima.
Un tipo del tutto particolare di "svitato", di "innocente", è Ian Bedloe, personaggio centrale di Quasi un santo. In lui gli atteggiamenti misticheggianti o esoterizzanti di tanti personaggi della Tyler diventano vero e proprio impulso mistico. Il senso di responsabilità per una tragedia esplosa nella — e soprattutto per effetto della — solita vischiosità della gabbia famigliare gli impone di cercare espiazione e quiete mentale in una comunità religiosa. Per la prima volta, in questo romanzo, l’autrice affonda esplicitamente e spericolatamente il tema della spiritualità.
Non perfettamente riuscito, pur nella qualità complessivamente alta, appare infine Per puro caso, centrato sul personaggio di Delia Grinstead, una quarantenne che vive... dove? A Baltimora. È sposata con un medico e madre di tre figli musoni, ormai grandi. Per quanto si arrovelli non riesce a capire il senso dei rapporti che ha con gli altri, e di conseguenza il senso della sua stessa vita. Durante una vacanza alla spiaggia decide di scegliere la libertà: trova un passaggio su un furgone e sparisce, ancora praticamente in costume da bagno. È appunto sull’annuncio giornalistico della sua scomparsa che fa perno il romanzo. Com’era vestita quando se ne sono perse le tracce? Il marito non se lo ricorda nemmeno. Come i figli, in effetti non l’ha mai "vista", nemmeno nella sua realtà fisica. Figurarsi nello spirito. Ma per fortuna Delia ha con sé i soldi sufficienti per comperarsi un po’ di indumenti e uno spazzolino per i denti con cui affrontare la nuova vita. Una vita che, come sempre, è uno "svitato" misto di allegria e malinconia, tra gente inevitabilmente "comune".
Non verrà mai sottolineato abbastanza quale importanza abbia, per il laboratorio del narratore, affrontare la forma "racconto": lo studio e la composizione di nuclei narrativi da elaborare sperimentalmente in vista (almeno in prospettiva) di forme narrative più complesse: schidionate o incorniciate in disegni più vasti, le loro strutture potranno successivamente servire per la composizione di un romanzo. E il lettore non può non riconoscere nelle donne, nei mariti e nel padre di tre racconti di Anne Tyler — recentemente raccolti in Italia sotto il titolo Il tuo posto è vuoto — i modelli di tanti personaggi poi visti nei romanzi che li hanno seguiti.
Vi sono paesi dove a lettura e scrittura viene ancora annessa un’importanza quasi sacrale. Gli Stati Uniti, per esempio. Si potrà discutere a lungo se ciò abbia antiche radici socio-culturali o dipenda soprattutto dal fatto che milioni di cittadini statunitensi passano giornalmente almeno un paio di ore sui commuting trains, i treni locali che li portano al lavoro in centro dai loro sobborghi residenziali di estrema periferia (e di nuovo a casa). In quelle due ore la televisione è necessariamente sconfitta: che cosa fare di meglio se non leggere un rapido, buon racconto?
Quali che siano le radici della perdurante e imponente fioritura di racconti in quel paese, sta di fatto che le università e gli istituti di istruzione superiore considerano un dovere avere nel loro staff un writer in residence, uno scrittore residente nel campus e stipendiato proprio per insegnare agli studenti a scrivere, a compilare tesi, tesine, prove scritte d’esame e persino lettere. Ma anche a cimentarsi nella scrittura creativa, nell’ambito di quei corsi di creative writing che negli anni Ottanta hanno prodotto un vero diluvio di giovanissimi scrittori di buone speranze. Non ne è rimasto molto, ma qualcosa sì: la sperimentazione sulla creatività non è fatta per produrre quantità ma per distillare qualità. Ci mancherebbe altro che da ogni corso di fisica uscissero trenta Einstein.
E sta anche di fatto che in quel paese i giornali vengono comperati per essere letti. Quindi hanno l’esigenza di essere scritti. Non soltanto il paludato "New Yorker", ma anche i leggeri e modaioli "Vanity Fair", "Esquire" e "Gentlemen Quarterly", per fare soltanto qualche esempio, non rinuncerebbero per niente al mondo ad avere i loro, per così dire writer in residence: ne andrebbe del loro prestigio e si troverebbero a scontrarsi con la disaffezione dei lettori. Devono pubblicare racconti e persino poesie.
Così sono arrivate fino a noi piccole perle — veri e propri nuclei di laboratorio narrativo — come i racconti di I. B. Singer, di John Cheever, di John Updike eccetera. Un elenco completo riempirebbe le pagine gialle. Tra di essi la smagliante Anne Tyler, che negli anni Settanta, conclusi l’università e gli studi di letteratura russa, fu una delle colonne delle rubriche di racconti pubblicate da "Seventeen" e dal "New Yorker".
Il tuo posto è vuoto è composto da tre racconti omogenei (5 in una successiva edizione), pubblicati tra il ’75 e il ’77 appunto su quest’ultima, raffinata rivista. Il patetico, trepidante incontro di una madre venuta dall’Iran con il figlio emigrato a fare il medico negli Stati Uniti (evidente ombra narrativa del marito della signora Tyler Modarressi): gli effetti di straniamento da marginalità realizzati in “Il tuo posto è vuoto” sono tra i più alti raggiunti dalla Tyler. In “Il bernoccolo delle lingue” viene raccontata la visita al padre, nella remota campagna Usa, di una giovane sposata con un docente italiano (altra marginalità): di quanti padri dei romanzi della Tyler appare l’archetipo. Infine le minuscole problematiche interpersonali di una coppia americana, scatenate dal maniacale presunto malfunzionamento di un’auto che serve da cartina di tornasole per un sottile scontro di caratteri: in “Chi tiene in piedi la baracca” sembra di leggere un concentrato dei motivi di Lezioni di respiro e di Per puro caso.
Vi è infine la recensione al romanzo Quando eravamo grandi, a suo tempo pubblicata sul defunto InfiniteStorie.it nell’autunno 2001 con il titolo “Un mondo splendidamente trasognato”. È un testo mio, di mia proprietà, lo riprendo qui sotto:
Che mondo splendidamente trasognato ci regala Anne Tyler con ogni suo libro. Microcosmi della mente sempre imperniati sulla città di Baltimora, dove (o vicino a dove, o partendo da dove) si svolgono tutte le sue storie. Famiglie in genere pletoriche i cui componenti sono sempre afflitti da tic piccoli o grandi, vissuti come un gioco o irreparabili. Come dimenticare anzitutto, quella del Turista involontario, che molti considerano il suo capolavoro? (Per altri il suo capolavoro è invece Ristorante Nostalgia, e personalmente preferisco lo straordinario Possessi Terreni.)
Nell'ambito di queste famiglie si accalcano personaggi che vivono sempre una vita reale e parallelamente un'altra da sogno, più o meno maniacale, confondendo l'una con l'altra senza più riuscire a distinguerle. Il tutto raccontato con una scrittura di un'eleganza essenziale, fatta di understatement, di notazioni piccole ma sempre nitidissime, di uno humour sottile e (anche per questo) di grande efficacia. Un "piccolo mondo moderno" americano, insomma.
In Quando eravamo grandi la pletorica famiglia è quella dei Davitch, una quantità sterminata di personaggi che va dal centenario prozio Poppy al neonato Abdul. Al centro di essa, quasi per caso, quasi in un sogno (come sempre), si è venuta a collocare la protagonista, Rebecca (Beck), arrivatavi per matrimonio con Joe, che aveva già tre figlie. Beck è rimasta vedova molto presto, e ancora giovanissima si è trovata sulle spalle tutto il peso della famiglia e dell'attività di cui essa campa: l'affitto dell'ottocentesca, grandissima e ormai cadente residenza padronale per feste di vario genere sotto l'insegna commerciale "A Braccia Aperte".
Il prozio è diventato vecchissimo (e nessuno sa fino in fondo perché viva lì). Le tre figliastre (più la quarta figlia, naturale) sono cresciute a hanno a loro volta generato uno stuolo di figli (con un discreto numero di mariti). Tutto attorno ruota un'altra sequela di amici, conoscenti, fornitori, artigiani, che entrano ed escono dalla dimora come se fosse casa loro, sempre ben accolti, sempre ascoltati sia pure nella limitata capacità di attenzione per gli altri che connota tutti i Davitch. "La loro vita", pensa Beck, "era una specie di patchwork di eventi scollegati..."
Una situazione che discende molto da vicino da quella del Turista involontario, come da quel bambino (e da quelli di Possessi Terreni) discende il ragazzino Peter (acquisito alla famiglia per matrimonio), timido e introverso nelle attività proprie della sua giovanissima età, ma in realtà un piccolo genio della tecnica. Così, di evento bizzarro in eventi bizzarro, di personaggio strampalato in personaggio strampalato, Beck si è ritrovata ad avere cinquantatré anni e a chiedersi come sia finita lì, e dove sia invece andata a finire la sua vera vita di studentessa modello, appassionata di Storia e quasi sicuramente destinata all'attività accademica (come il suo ragazzo di allora). E si chiede se sia in qualche modo possibile tornare a quella vita. Ma, incalza il centenario Poppy: "La vera vita non esiste. La vera vita è quella che capita di vivere, qualunque sia". Così Beck rinuncia al vagheggiato quanto improbabile ricongiungimento con il passato e - non diversamente dalla Charlotte di Possessi terreni - finisce con il rimanere lì, nel suo piccolo, affollato e bislacco microcosmo da sogno, aggiungendo una piccola perla alla corposa bibliografia di Anne Tyler (15 libri, di cui 11 tradotti in Italia) (allora, nda).
A riprova della sua popolarità basterebbe guardare il numero delle "recensioni di lettori" che compaiono nel sito di Amazon.com. C'è chi il libro lo ha amato moltissimo, chi così così, chi niente (pochissimi, per altro): è la normale sfida che affronta ogni scrittore quando sottopone il suo lavoro al giudizio del pubblico. Ma le recensioni sono 111. Non capita a molti di avere tanti lettori così appassionati da scrivere e inviare una recensione telematica. Anche in questo modo Anne Tyler si conferma, oltre che forse la miglior scrittrice americana vivente, sicuramente una delle più popolari.
Anne Tyler è nata il 25 ottobre 1941 a Minneapolis (Minnesota) e nel 1961 ha conseguito un Bachelor of Arts presso la Duke University di Durham (North Carolina). Quindi ha studiato letteratura russa alla Columbia University di New York. Vive a Baltimora. Ha praticamente sempre scritto, visto che la sua prima pubblicazione risale al 1965. Nel 1989 le è stato assegnato il Pulitzer Prize per il romanzo Breathing Lessons (Lezioni di respiro).