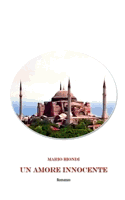Scrive di: Ernest Hemingway
Introduzione a un'edizione italiana di Per chi suona la campana (1996)
Introduzione a un'edizione italiana di Per chi suona la campana (1996)
© Mario Biondi
Divieto di riproduzione integrale
e obbligo di citazione (per cortesia...)
Diverse le motivazioni che, nel corso di almeno tre periodi storici cadenzati e distinti, spinsero gli intellettuali americani a trasferirsi per periodi più o meno lunghi nel "Vecchio Paese", quell’Europa a cui appartenevano e a cui li richiamavano le loro origini. A cavallo tra `800 e `900, a spingere verso l’Europa Henry James ed Edith Wharton, Gertrude Stein e la sua amica e compagna Alice Toklas fu l’angustia culturale del loro paese, la cappa di puritanesimo sotto cui la loro diversità personale e intellettuale si sentiva soffocare.
Negli anni Venti la cappa di puritanesimo aveva forse in parte cominciato a sollevarsi, ma sull’orizzonte incombevano le durezze della crisi economica finalmente esplosa con il crollo di Wall Street nel `29. A fare da tramite e da anfitriona per la nuova ondata di emigrati fu l’acuta, inquieta intelligenza di Gertrude Stein, che li definì scherzosamente la "Lost Generation", la "Generazione Perduta" (altri li chiamarono i "Sad Young Men", i "Giovani Tristi") e spalancò loro le porte del suo salotto parigino.
Vi arrivò Fitzgerald, vi passò per breve tempo Sherwood Anderson, vi entravano e uscivano E.E. Cummings, Archibald McLeish, John Dos Passos; vi si istallò con la sua massiccia presenza un giovanotto («un ventitreenne di straordinario bell’aspetto», secondo le parole della stessa Stein) che si era coperto di insanguinata gloria sul fronte italiano della Grande Guerra e già appariva predestinato a diventare uno dei numi tutelari della letteratura degli Stati Uniti: Ernest Hemingway.
Diverse ancora le motivazioni che, negli anni Cinquanta, spinsero un’altra ondata di intellettuali e artisti di varia specializzazione (scrittori, pittori, jazzisti) a raccogliersi a Parigi attorno alla mitica (e programmaticamente sgangherata) redazione della Paris Review. L’angusta realtà che li aveva spinti all’emigrazione non era più quella del puritanesimo ma quella dell’intolleranza maccartista abbattutasi sul loro paese dopo lo slancio di solidarietà e rinnovamento del New Deal.
Una realtà che Hemingway aveva fatto preannunciare da Robert Jordan in una pagina fatidicamente memorabile di Per chi suona la campana. Come tanti altri intellettuali imbevuti di spirito roosveltiano, Jordan è partito di slancio per andare a combattere contro il fascismo in Spagna. Ma, così facendo, si è autoimposto il marchio di "rosso": al ritorno, riflette con amarezza, scoprirà probabilmente che nell’università in cui insegnava non c’è più posto per lui. Com’è noto, lui non tornerà, ma per molti volontari reduci dalle battaglie dell’antifascismo europeo le cose sarebbero andate esattamente così.
Nella presunta riscoperta della libertà in Europa, comunque, questi esponenti della terza emigrazione non erano più "Sad Young Men": erano, anzi, sfrenatamente allegri — giovani, irriverenti, vincitori di due guerre mondiali, ricchi dei loro non molti dollari in un’Europa che si curava ancora le profonde piaghe della guerra —, capaci di demenziali follie in nome di un "esistenzialismo" frettolosamente ingerito e sommariamente assimilato, come ha ricordato un maestro del giornalismo narrativo, il calabro-americano Gay Talese.
Lo fece in uno scintillante articolo apparso nel 1960 su Esquire e intitolato "Looking for Hemingway", in cui appunto ricostruiva clima e vicende della redazione parigina della Paris Review. Hemingway non era più a Parigi, viveva i suoi accigliati autoesili, ma loro si erano trasferiti in massa lì proprio nel suo ricordo. Più che seduti nel chiuso della redazione della rivista, i redattori lavoravano tumultuosamente di cervello nei café della Rive Gauche, discutendo articoli e pezzi creativi mentre tenevano ansiosamente d’occhio la terribile mangiasoldi di quei tempi, la "pinball machine", il flipper, in attesa che venisse il loro turno di piazzarsi ai pulsanti.
Così facendo, con giovanilissima irriverenza e irruenza, riuscivano a editare una rivista destinata a rimanere mitica negli annali della letteratura mondiale. Bevevano assenzio, come fa Robert Jordan in Per chi suona la campana, si trasferivano in massa in Spagna per fremere di emozione per le strade di Pamplona con l’alito rovente dei torelli sul collo, nel riverente ricordo di Fiesta e di Morte nel pomeriggio. Ma "Papa" Ernest non era più lì. E, se fosse stato lì, sarebbe probabilmente inorridito nel vederli, esattamente come loro ostentavano orrore alla vista degli sciami di "turisti" loro compatrioti che avevano cominciato ad affollare Parigi e l’Europa.
Come era arrivato, il ventitreenne Ernest Hemingway, nell’aperto ma esigente salotto di Gertrude Stein dalla lontana e sonnolenta cittadina di Oak Park, nell’Illinois, dove era nato il 21 luglio 1899, figlio di un malinconico medico e di un’ispirata seguace delle arti che avrebbe voluto farne un musicista? Il viaggio era stata lungo, nonostante la giovane età.
Prima tappa, Kansas City, città in pieno boom, dove il ragazzo Ernest si trasferisce a 18 anni per fare il cronista praticante presso un giornale. Intimidito ma ferreamente motivato a imparare il mestiere, tesserino infilato nella tesa del cappello e taccuino in mano, corre qua e là a fare gavetta. Ma, passati pochi mesi di assestamento ed esperienza, la sua sete di novità, la sua curiosità vitalistica, il suo spirito avventuroso prevalgono.
In Europa imperversa la Grande guerra, e lui vuole andarci a tutti i costi, anche se un difetto all’occhio sinistro lo ha fatto scartare alla visita di leva. Non demorde: si aggrega alla Croce Rossa e si distingue sul fronte carsico, dove ha il primo massiccio contatto con quella "morte" che successivamente avrà un’importanza basilare nella sua carriera letteraria quanto nella vicenda personale, due fenomeni sempre tesi a comporsi in un unicum totalizzante. Viene ferito gravemente da un mortaio austriaco, ottiene la Medaglia al Valore dalle autorità italiane. Trascorre la convalescenza a Milano e in Lombardia: ha visto e sperimentato tutto ciò che gli servirà, di lì a qualche anno, per scrivere Addio alle armi.
La guerra, le visioni di morte, la stessa constatazione di quanto sia facile morire lo hanno segnato profondamente nello spirito oltre che nella carne. Congedato, torna a Oak Park, dove tuttavia non riesce più a inserirsi. Poco più che ventenne, ha vissuto e visto troppo per potersi riadeguare alla routine della provincia americana. Litiga con la (mai sopportata) madre, scappa a Chicago, dove campa scrivendo articoli per il "Toronto Star" e facendo lo sparring partner per i boxeur. Appartiene ormai senza scampo alla schiera dei "Giovani tristi", malati di Europa. Decide di tornarci, di trasferirsi a Parigi, un posto dove «l’arte viene presa sul serio» (Sherwood Anderson).
Parigi non poteva significare che Gertrude Stein, con il suo fondamentale credo letterario di concisione, semplicità, pregnanza narrativa. Ci arrivò pronto ad assorbire come una spugna visioni, sensazioni e suggestioni. Se ne andò e tornò più volte, dando il via a una vera e propria forma di inquieto pendolarismo personale e culturale. Ormai non aveva più ventitré anni ma ventisei. A un certo punto parve che «tutti questi giovanotti avessero ventisei anni", ha scritto ancora Gertrude Stein: «Era evidentemente l’età giusta per quel luogo e quei tempi».
Ebbene, a ventisei anni Ernest Hemingway aveva già assorbito tutto ciò che gli serviva per la sua carriera letteraria in fieri: il senso della guerra, la Spagna, il viaggio ramingo, l’idea fissa dell’uomo come essere che vive soltanto per confrontarsi con la morte. «La vita di ciascun uomo finisce nello stesso modo», avrebbe dichiarato, secondo un articolo pubblicato postumo in Sunday Times. «A distinguere un uomo dall’altro sono solamente i particolari del modo in cui è vissuto ed è morto.»
E lui aveva assistito alla morte di tanti uomini, aveva perduto il padre per un suicidio che avrebbe dovuto essergli premonitore e che invece aveva suscitato in lui uno sdegno feroce, aveva visto combattere con le unghie e con i denti, si era sentito penetrare nel sangue la Spagna dei toreri e degli intellettuali, delle chiromanti gitane e dei combattenti antifascisti. A fare da collante per il tutto si aggiunga una sapienza letteraria istintiva che partiva, dall’alto, dalle estenuate tensioni linguistiche di Mark Twain. «Tutta la letteratura americana», avrebbe scritto in Verdi Colline d’Africa, «viene da un solo libro di Mark Twain: Huckleberry Finn.» Ma a fare da solido sostegno a questa sapienza istintiva c’era la lezione delle visionarie capacità narrative di Jack London, cementate dalla breve ma intensa esperienza di praticante cronista.
Di tutto ciò non sapevamo niente noi, ginnasiali turbolenti dell’Italietta poco più che postbellica che ci passavamo avidamente di mano in mano Per chi suona la campana. Le pagine in cui la guapa Maria si infila nel sacco a pelo di Robert Jordan erano consunte, piene di orecchie. Una novità sconvolgente, per quei tempi di estremo pudore ipocrita, di cui il famoso puritanesimo da cui Hemingway e i suoi simili fuggivano non era probabilmente che un’ombra pallida. A Roma si prendeva a schiaffi una signora soltanto perché aveva osato sedersi in un caffè all’aperto esibendo le spalle nude. Di lì a poco — ma non tanto poco —, una malcapitata danzatrice del ventre turca che aveva osato concludere il suo spettacolo con il gesto che in quell’antica arte scenica è canonico da secoli, lo scoprimento del seno, avrebbe provocato un putiferio tale da far chiudere il locale e da ispirare a Federico Fellini il nocciolo de La dolce vita. Che tempi.
Letteratura, per noi ginnasiali inquieti e curiosi, doveva significare sentimenti non soltanto "buoni" ma addirittura "sublimi". Dante Alighieri e Alessandro Manzoni, naturalmente, Petrarca e Leopardi, Alfieri e Berchet. Le cavalline storne e gli asini bigi. Senza, soprattutto, dimenticare le maestrine dalla penna rossa, le piccole vedette lombarde, i piccoli scrivani fiorentini, il buon Garrone e il perfido Franti. Pochissimi, ardimentosi, osavano spingersi fino al Verga.
Ricordo un coscienzioso direttore di biblioteca pubblica che convocò perentoriamente nel suo ufficio mia madre per significarle quanto poco consono gli sembrasse che un adolescente chiedesse in prestito i romanzi di Vitaliano Brancati. Lasciò velatamente intendere che appartenevano di pieno diritto a quei libri che, secondo l’arguto motto di un celebre statista padre della patria, «gli adolescenti leggono con una mano sola». Di nuovo: che tempi.
Una mano o due, per fortuna, la madre perentoriamente convocata era del tutto convinta che la cultura abbia la sua inestirpabile radice nei libri. Firmò senza battere ciglio l’autorizzazione a che suo figlio prendesse in prestito tutti i libri che voleva. Secondo lei, leggere non avrebbe mai potuto fare male a nessuno. La copia di Per chi suona la campana che feci passare di mano in mano, con dovizia di orecchie di riferimento per i punti "scottanti" (come viene da sorridere, adesso, vedendo che cosa consente di esporre a qualsiasi sguardo la semplice pubblicità televisiva di una mutanda o di un deodorante!), apparteneva alla sua biblioteca personale.
Che novità incredibile! Che immediatezza di linguaggio, che fulminante crudezza di situazioni. Concludere le frasi dei nostri primi timidi esperimenti letterari con i canonici «... dissi ... disse», sembrava diventato un obbligo imprescindibile. Soltanto molto più tardi, rileggendo i libri di Hemingway in americano, avremmo capito (ma non tutti) quanta sapienza letteraria possa andare persa nella traduzione: in tutte le traduzioni, si badi bene, anche le più eccelse. La sequela di «dissi-disse» dei romanzi americani, quando viene trasposta nella nostra lingua è probabilmente meglio renderla con verbi diversi: dissi, replicò, ripetei, ribatté, riflettei, considerò. Già basterebbe considerare che gli americani scrivono «disse» anche nelle frasi interrogative, dove per noi è d’obbligo scrivere «chiese».
Poco male. Anzi: molto bene. Ancora oggi, leggere Per chi suona la campana è un’esperienza di intensa emozione, una magnifica lezione dal vivo di scrittura creativa. Ri-leggerlo in americano, poi, significa scoprire un autentico patrimonio di preziosità letterarie mai adeguatamente apprezzate. Il profumo di latinità, per esempio, che (ben al di là delle sommarie semplificazioni «dissi-disse») promana dalle conversazioni di Robert Jordan e dei suoi compagni spagnoli di lotta partigiana, la sanguigna Pilar, il torpido Pablo, l’onesto Anselmo, la guapa Maria, lo zingaro, gli altri. Conversazioni sempre condotte con il thou-thee, ovvero con il tu-te, che nella lingua inglese — e ancora di più in quella americana — appartiene ormai soltanto alle formulazioni arcaiche, sostituita dal più immediato e semplicistico you, che serve alla stessa stregua per il tu come per il voi unificando le due forme verbali della seconda persona singolare e plurale.
Per l’orecchio istintivamente letterato di Hemingway, in questa specifica occasione, lo you non sarebbe mai potuto bastare. Gli spagnoli parlano con il "tu", e proprio da questo uso del "tu" derivano la musicalità e una certa solennità della loro lingua. Di conseguenza, per rendere queste cadenze musicali e solenni (esempio: invece di «have you?», «hast thou?», eccetera), Hemingway mette in atto una sequela di autentici miracoli di equilibrismo linguistico — più che mai riconducibili a Mark Twain, al suo uso magistrale di dialetti, sottodialetti, idioletti e inflessioni locali —, mescolandola in maniera inscindibile con la sua visionarietà narrativa alla Jack London e ottenendone un effetto letterario esplosivo. Un effetto, purtroppo, che nella traduzione italiana — essendo per noi il tu un fatto del tutto normale —, non può che andare perduto. Si pensi, per tentativo di esempio, alle singolari tonalità e coloriture che assumerebbe un romanzo contemporaneo in cui i personaggi dovessero essere fatti parlare con il voi invece che con il lei.
Il lettore che non conosce l’americano prenda dunque con molte riserve le critiche italiane che parlano di Hemingway come di uno scrittore povero di stile, tutto trama e niente lingua. Non è affatto così, e Per chi suona la campana ne costituisce l’esempio principe. Ma a quei tempi (fine anni `40) le traduzioni venivano fatte e rifatte con cura certosina, sicché, anche se qua e là privato del piacere di cogliere alcune finezze, il lettore non anglofono troverà comunque straordinario appagamento nel tumultuoso, inarrestabile svolgersi della vicenda, nel secco splendore delle descrizioni ambientali (probabilmente impareggiate nella prosa hemingwaiana), nell’emergere prepotente dalla pagina di personaggi come Pilar o il vecchio Anselmo, magnifico, dolente preannunzio di un altro grande vecchio hemingwayano: quello tutto solo, sulla sua barca, alle prese con il grande pesce spada e con il mare.
La vicenda partigiana di Robert Jordan, la sua inevitabile marcia verso una morte più volte annunciata, con il suo contorno di sangue e violenza, di combattenti popolani e di popolani filosofi, di esotismo ispanico e di suggestioni gitane, di "sombra y sol" come nella più canonica delle arene di tori, è uno specchio variegato e fedelissimo dell’arte di Ernest Hemingway, un’arte che non comincia là dove finisce la vita ma che con la vita si confonde fino a renderli due fatti non semplicemente paralleli ma indistinguibili.
Il partigiano antifascista volontario Robert Jordan non è semplicemente una proiezione dell’autore; Robert Jordan è Ernest Hemingway, per il semplice motivo che i libri di "Papa" Hemingway sono una proiezione della sua vita e, reciprocamente, sulla sua vita proiettano le loro ombre: un progressivo e sempre più amaro rimuginare sulla sorte dell’uomo nel suo confronto obbligato con la morte.
Tante volte ferito nella carne (e nello spirito) nell’avventuroso ma non lungo dipanarsi della sua vita, da un certo punto in avanti Ernest Hemingway dovette andare convincendosi sempre più della vanità delle cose umane. Se per tutta la gioventù aveva manifestato un feroce sdegno per il cedimento del padre, per la sua mancanza di coraggio davanti alle difficoltà della vita, già in Per chi suona la campana il lettore coglie toni totalmente diversi. Al trasfigurato ricordo del suicida, Robert Jordan dedica pensieri di profonda delicatezza e commozione. Al momento di mettersi letterariamente nei suoi panni, Hemingway aveva con ogni probabilità intuito per chi era in procinto di suonare la campana, aveva già avvistato, in fondo alla discesa precipite che stava diventando la sua vita, quale ne sarebbe stata la conclusione inevitabile. Anche per lui, come già per il padre, un atto di suprema codardia rivalutato, umanizzato in quanto atto di suprema autoaffermazione: il suicidio.
Di fronte al doppio colpo di fucile con cui il 2 luglio 1961, all’età di quasi 63 anni, Ernest Hemingway si tolse la vita, non è forse possibile pensare ad altro se non all’unica conclusione possibile di una vita tutta strenuamente vissuta come inscindibile altra faccia dell’arte. All’inevitabile proiettarsi nella realtà delle morti di Robert Jordan, di Francis Macomber, del torero Finito e dei tanti mitizzati attori del vitalistico e tragico spettacolo detto corrida. La definitiva autoaffermazione del vecchio costretto ad avventurarsi da solo nel mare della vita.
Introduzione a: Per chi suona la campana, Newton Compton
Negli anni Venti la cappa di puritanesimo aveva forse in parte cominciato a sollevarsi, ma sull’orizzonte incombevano le durezze della crisi economica finalmente esplosa con il crollo di Wall Street nel `29. A fare da tramite e da anfitriona per la nuova ondata di emigrati fu l’acuta, inquieta intelligenza di Gertrude Stein, che li definì scherzosamente la "Lost Generation", la "Generazione Perduta" (altri li chiamarono i "Sad Young Men", i "Giovani Tristi") e spalancò loro le porte del suo salotto parigino.
Vi arrivò Fitzgerald, vi passò per breve tempo Sherwood Anderson, vi entravano e uscivano E.E. Cummings, Archibald McLeish, John Dos Passos; vi si istallò con la sua massiccia presenza un giovanotto («un ventitreenne di straordinario bell’aspetto», secondo le parole della stessa Stein) che si era coperto di insanguinata gloria sul fronte italiano della Grande Guerra e già appariva predestinato a diventare uno dei numi tutelari della letteratura degli Stati Uniti: Ernest Hemingway.
Diverse ancora le motivazioni che, negli anni Cinquanta, spinsero un’altra ondata di intellettuali e artisti di varia specializzazione (scrittori, pittori, jazzisti) a raccogliersi a Parigi attorno alla mitica (e programmaticamente sgangherata) redazione della Paris Review. L’angusta realtà che li aveva spinti all’emigrazione non era più quella del puritanesimo ma quella dell’intolleranza maccartista abbattutasi sul loro paese dopo lo slancio di solidarietà e rinnovamento del New Deal.
Una realtà che Hemingway aveva fatto preannunciare da Robert Jordan in una pagina fatidicamente memorabile di Per chi suona la campana. Come tanti altri intellettuali imbevuti di spirito roosveltiano, Jordan è partito di slancio per andare a combattere contro il fascismo in Spagna. Ma, così facendo, si è autoimposto il marchio di "rosso": al ritorno, riflette con amarezza, scoprirà probabilmente che nell’università in cui insegnava non c’è più posto per lui. Com’è noto, lui non tornerà, ma per molti volontari reduci dalle battaglie dell’antifascismo europeo le cose sarebbero andate esattamente così.
Nella presunta riscoperta della libertà in Europa, comunque, questi esponenti della terza emigrazione non erano più "Sad Young Men": erano, anzi, sfrenatamente allegri — giovani, irriverenti, vincitori di due guerre mondiali, ricchi dei loro non molti dollari in un’Europa che si curava ancora le profonde piaghe della guerra —, capaci di demenziali follie in nome di un "esistenzialismo" frettolosamente ingerito e sommariamente assimilato, come ha ricordato un maestro del giornalismo narrativo, il calabro-americano Gay Talese.
Lo fece in uno scintillante articolo apparso nel 1960 su Esquire e intitolato "Looking for Hemingway", in cui appunto ricostruiva clima e vicende della redazione parigina della Paris Review. Hemingway non era più a Parigi, viveva i suoi accigliati autoesili, ma loro si erano trasferiti in massa lì proprio nel suo ricordo. Più che seduti nel chiuso della redazione della rivista, i redattori lavoravano tumultuosamente di cervello nei café della Rive Gauche, discutendo articoli e pezzi creativi mentre tenevano ansiosamente d’occhio la terribile mangiasoldi di quei tempi, la "pinball machine", il flipper, in attesa che venisse il loro turno di piazzarsi ai pulsanti.
Così facendo, con giovanilissima irriverenza e irruenza, riuscivano a editare una rivista destinata a rimanere mitica negli annali della letteratura mondiale. Bevevano assenzio, come fa Robert Jordan in Per chi suona la campana, si trasferivano in massa in Spagna per fremere di emozione per le strade di Pamplona con l’alito rovente dei torelli sul collo, nel riverente ricordo di Fiesta e di Morte nel pomeriggio. Ma "Papa" Ernest non era più lì. E, se fosse stato lì, sarebbe probabilmente inorridito nel vederli, esattamente come loro ostentavano orrore alla vista degli sciami di "turisti" loro compatrioti che avevano cominciato ad affollare Parigi e l’Europa.
Come era arrivato, il ventitreenne Ernest Hemingway, nell’aperto ma esigente salotto di Gertrude Stein dalla lontana e sonnolenta cittadina di Oak Park, nell’Illinois, dove era nato il 21 luglio 1899, figlio di un malinconico medico e di un’ispirata seguace delle arti che avrebbe voluto farne un musicista? Il viaggio era stata lungo, nonostante la giovane età.
Prima tappa, Kansas City, città in pieno boom, dove il ragazzo Ernest si trasferisce a 18 anni per fare il cronista praticante presso un giornale. Intimidito ma ferreamente motivato a imparare il mestiere, tesserino infilato nella tesa del cappello e taccuino in mano, corre qua e là a fare gavetta. Ma, passati pochi mesi di assestamento ed esperienza, la sua sete di novità, la sua curiosità vitalistica, il suo spirito avventuroso prevalgono.
In Europa imperversa la Grande guerra, e lui vuole andarci a tutti i costi, anche se un difetto all’occhio sinistro lo ha fatto scartare alla visita di leva. Non demorde: si aggrega alla Croce Rossa e si distingue sul fronte carsico, dove ha il primo massiccio contatto con quella "morte" che successivamente avrà un’importanza basilare nella sua carriera letteraria quanto nella vicenda personale, due fenomeni sempre tesi a comporsi in un unicum totalizzante. Viene ferito gravemente da un mortaio austriaco, ottiene la Medaglia al Valore dalle autorità italiane. Trascorre la convalescenza a Milano e in Lombardia: ha visto e sperimentato tutto ciò che gli servirà, di lì a qualche anno, per scrivere Addio alle armi.
La guerra, le visioni di morte, la stessa constatazione di quanto sia facile morire lo hanno segnato profondamente nello spirito oltre che nella carne. Congedato, torna a Oak Park, dove tuttavia non riesce più a inserirsi. Poco più che ventenne, ha vissuto e visto troppo per potersi riadeguare alla routine della provincia americana. Litiga con la (mai sopportata) madre, scappa a Chicago, dove campa scrivendo articoli per il "Toronto Star" e facendo lo sparring partner per i boxeur. Appartiene ormai senza scampo alla schiera dei "Giovani tristi", malati di Europa. Decide di tornarci, di trasferirsi a Parigi, un posto dove «l’arte viene presa sul serio» (Sherwood Anderson).
Parigi non poteva significare che Gertrude Stein, con il suo fondamentale credo letterario di concisione, semplicità, pregnanza narrativa. Ci arrivò pronto ad assorbire come una spugna visioni, sensazioni e suggestioni. Se ne andò e tornò più volte, dando il via a una vera e propria forma di inquieto pendolarismo personale e culturale. Ormai non aveva più ventitré anni ma ventisei. A un certo punto parve che «tutti questi giovanotti avessero ventisei anni", ha scritto ancora Gertrude Stein: «Era evidentemente l’età giusta per quel luogo e quei tempi».
Ebbene, a ventisei anni Ernest Hemingway aveva già assorbito tutto ciò che gli serviva per la sua carriera letteraria in fieri: il senso della guerra, la Spagna, il viaggio ramingo, l’idea fissa dell’uomo come essere che vive soltanto per confrontarsi con la morte. «La vita di ciascun uomo finisce nello stesso modo», avrebbe dichiarato, secondo un articolo pubblicato postumo in Sunday Times. «A distinguere un uomo dall’altro sono solamente i particolari del modo in cui è vissuto ed è morto.»
E lui aveva assistito alla morte di tanti uomini, aveva perduto il padre per un suicidio che avrebbe dovuto essergli premonitore e che invece aveva suscitato in lui uno sdegno feroce, aveva visto combattere con le unghie e con i denti, si era sentito penetrare nel sangue la Spagna dei toreri e degli intellettuali, delle chiromanti gitane e dei combattenti antifascisti. A fare da collante per il tutto si aggiunga una sapienza letteraria istintiva che partiva, dall’alto, dalle estenuate tensioni linguistiche di Mark Twain. «Tutta la letteratura americana», avrebbe scritto in Verdi Colline d’Africa, «viene da un solo libro di Mark Twain: Huckleberry Finn.» Ma a fare da solido sostegno a questa sapienza istintiva c’era la lezione delle visionarie capacità narrative di Jack London, cementate dalla breve ma intensa esperienza di praticante cronista.
Di tutto ciò non sapevamo niente noi, ginnasiali turbolenti dell’Italietta poco più che postbellica che ci passavamo avidamente di mano in mano Per chi suona la campana. Le pagine in cui la guapa Maria si infila nel sacco a pelo di Robert Jordan erano consunte, piene di orecchie. Una novità sconvolgente, per quei tempi di estremo pudore ipocrita, di cui il famoso puritanesimo da cui Hemingway e i suoi simili fuggivano non era probabilmente che un’ombra pallida. A Roma si prendeva a schiaffi una signora soltanto perché aveva osato sedersi in un caffè all’aperto esibendo le spalle nude. Di lì a poco — ma non tanto poco —, una malcapitata danzatrice del ventre turca che aveva osato concludere il suo spettacolo con il gesto che in quell’antica arte scenica è canonico da secoli, lo scoprimento del seno, avrebbe provocato un putiferio tale da far chiudere il locale e da ispirare a Federico Fellini il nocciolo de La dolce vita. Che tempi.
Letteratura, per noi ginnasiali inquieti e curiosi, doveva significare sentimenti non soltanto "buoni" ma addirittura "sublimi". Dante Alighieri e Alessandro Manzoni, naturalmente, Petrarca e Leopardi, Alfieri e Berchet. Le cavalline storne e gli asini bigi. Senza, soprattutto, dimenticare le maestrine dalla penna rossa, le piccole vedette lombarde, i piccoli scrivani fiorentini, il buon Garrone e il perfido Franti. Pochissimi, ardimentosi, osavano spingersi fino al Verga.
Ricordo un coscienzioso direttore di biblioteca pubblica che convocò perentoriamente nel suo ufficio mia madre per significarle quanto poco consono gli sembrasse che un adolescente chiedesse in prestito i romanzi di Vitaliano Brancati. Lasciò velatamente intendere che appartenevano di pieno diritto a quei libri che, secondo l’arguto motto di un celebre statista padre della patria, «gli adolescenti leggono con una mano sola». Di nuovo: che tempi.
Una mano o due, per fortuna, la madre perentoriamente convocata era del tutto convinta che la cultura abbia la sua inestirpabile radice nei libri. Firmò senza battere ciglio l’autorizzazione a che suo figlio prendesse in prestito tutti i libri che voleva. Secondo lei, leggere non avrebbe mai potuto fare male a nessuno. La copia di Per chi suona la campana che feci passare di mano in mano, con dovizia di orecchie di riferimento per i punti "scottanti" (come viene da sorridere, adesso, vedendo che cosa consente di esporre a qualsiasi sguardo la semplice pubblicità televisiva di una mutanda o di un deodorante!), apparteneva alla sua biblioteca personale.
Che novità incredibile! Che immediatezza di linguaggio, che fulminante crudezza di situazioni. Concludere le frasi dei nostri primi timidi esperimenti letterari con i canonici «... dissi ... disse», sembrava diventato un obbligo imprescindibile. Soltanto molto più tardi, rileggendo i libri di Hemingway in americano, avremmo capito (ma non tutti) quanta sapienza letteraria possa andare persa nella traduzione: in tutte le traduzioni, si badi bene, anche le più eccelse. La sequela di «dissi-disse» dei romanzi americani, quando viene trasposta nella nostra lingua è probabilmente meglio renderla con verbi diversi: dissi, replicò, ripetei, ribatté, riflettei, considerò. Già basterebbe considerare che gli americani scrivono «disse» anche nelle frasi interrogative, dove per noi è d’obbligo scrivere «chiese».
Poco male. Anzi: molto bene. Ancora oggi, leggere Per chi suona la campana è un’esperienza di intensa emozione, una magnifica lezione dal vivo di scrittura creativa. Ri-leggerlo in americano, poi, significa scoprire un autentico patrimonio di preziosità letterarie mai adeguatamente apprezzate. Il profumo di latinità, per esempio, che (ben al di là delle sommarie semplificazioni «dissi-disse») promana dalle conversazioni di Robert Jordan e dei suoi compagni spagnoli di lotta partigiana, la sanguigna Pilar, il torpido Pablo, l’onesto Anselmo, la guapa Maria, lo zingaro, gli altri. Conversazioni sempre condotte con il thou-thee, ovvero con il tu-te, che nella lingua inglese — e ancora di più in quella americana — appartiene ormai soltanto alle formulazioni arcaiche, sostituita dal più immediato e semplicistico you, che serve alla stessa stregua per il tu come per il voi unificando le due forme verbali della seconda persona singolare e plurale.
Per l’orecchio istintivamente letterato di Hemingway, in questa specifica occasione, lo you non sarebbe mai potuto bastare. Gli spagnoli parlano con il "tu", e proprio da questo uso del "tu" derivano la musicalità e una certa solennità della loro lingua. Di conseguenza, per rendere queste cadenze musicali e solenni (esempio: invece di «have you?», «hast thou?», eccetera), Hemingway mette in atto una sequela di autentici miracoli di equilibrismo linguistico — più che mai riconducibili a Mark Twain, al suo uso magistrale di dialetti, sottodialetti, idioletti e inflessioni locali —, mescolandola in maniera inscindibile con la sua visionarietà narrativa alla Jack London e ottenendone un effetto letterario esplosivo. Un effetto, purtroppo, che nella traduzione italiana — essendo per noi il tu un fatto del tutto normale —, non può che andare perduto. Si pensi, per tentativo di esempio, alle singolari tonalità e coloriture che assumerebbe un romanzo contemporaneo in cui i personaggi dovessero essere fatti parlare con il voi invece che con il lei.
Il lettore che non conosce l’americano prenda dunque con molte riserve le critiche italiane che parlano di Hemingway come di uno scrittore povero di stile, tutto trama e niente lingua. Non è affatto così, e Per chi suona la campana ne costituisce l’esempio principe. Ma a quei tempi (fine anni `40) le traduzioni venivano fatte e rifatte con cura certosina, sicché, anche se qua e là privato del piacere di cogliere alcune finezze, il lettore non anglofono troverà comunque straordinario appagamento nel tumultuoso, inarrestabile svolgersi della vicenda, nel secco splendore delle descrizioni ambientali (probabilmente impareggiate nella prosa hemingwaiana), nell’emergere prepotente dalla pagina di personaggi come Pilar o il vecchio Anselmo, magnifico, dolente preannunzio di un altro grande vecchio hemingwayano: quello tutto solo, sulla sua barca, alle prese con il grande pesce spada e con il mare.
La vicenda partigiana di Robert Jordan, la sua inevitabile marcia verso una morte più volte annunciata, con il suo contorno di sangue e violenza, di combattenti popolani e di popolani filosofi, di esotismo ispanico e di suggestioni gitane, di "sombra y sol" come nella più canonica delle arene di tori, è uno specchio variegato e fedelissimo dell’arte di Ernest Hemingway, un’arte che non comincia là dove finisce la vita ma che con la vita si confonde fino a renderli due fatti non semplicemente paralleli ma indistinguibili.
Il partigiano antifascista volontario Robert Jordan non è semplicemente una proiezione dell’autore; Robert Jordan è Ernest Hemingway, per il semplice motivo che i libri di "Papa" Hemingway sono una proiezione della sua vita e, reciprocamente, sulla sua vita proiettano le loro ombre: un progressivo e sempre più amaro rimuginare sulla sorte dell’uomo nel suo confronto obbligato con la morte.
Tante volte ferito nella carne (e nello spirito) nell’avventuroso ma non lungo dipanarsi della sua vita, da un certo punto in avanti Ernest Hemingway dovette andare convincendosi sempre più della vanità delle cose umane. Se per tutta la gioventù aveva manifestato un feroce sdegno per il cedimento del padre, per la sua mancanza di coraggio davanti alle difficoltà della vita, già in Per chi suona la campana il lettore coglie toni totalmente diversi. Al trasfigurato ricordo del suicida, Robert Jordan dedica pensieri di profonda delicatezza e commozione. Al momento di mettersi letterariamente nei suoi panni, Hemingway aveva con ogni probabilità intuito per chi era in procinto di suonare la campana, aveva già avvistato, in fondo alla discesa precipite che stava diventando la sua vita, quale ne sarebbe stata la conclusione inevitabile. Anche per lui, come già per il padre, un atto di suprema codardia rivalutato, umanizzato in quanto atto di suprema autoaffermazione: il suicidio.
Di fronte al doppio colpo di fucile con cui il 2 luglio 1961, all’età di quasi 63 anni, Ernest Hemingway si tolse la vita, non è forse possibile pensare ad altro se non all’unica conclusione possibile di una vita tutta strenuamente vissuta come inscindibile altra faccia dell’arte. All’inevitabile proiettarsi nella realtà delle morti di Robert Jordan, di Francis Macomber, del torero Finito e dei tanti mitizzati attori del vitalistico e tragico spettacolo detto corrida. La definitiva autoaffermazione del vecchio costretto ad avventurarsi da solo nel mare della vita.
Introduzione a: Per chi suona la campana, Newton Compton