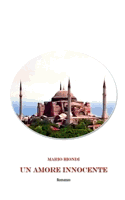Scrive di: Ismail Kadare
Il Palazzo dei Sogni (2023)
Il Palazzo dei Sogni (2023)
© Mario Biondi
Divieto di riproduzione integrale
e obbligo di citazione (per cortesia...)
Sulla sponda asiatica del Bosforo, a una trentina di chilometri dalla Istanbul europea, c’è Polonezköy, il “villaggio dei polacchi”. Proprio dei polacchi, creato dal principe Czartoryski per stanziarvi una comunità di conterranei emigrati dopo la fallita insurrezione del 1831 contro i russi. Circa trecento dei loro discendenti abitano ancora lì, attorno alla chiesa cattolica che hanno eretto. Appena fuori della città, verso il Mar Nero, sulla sponda europea, si estende invece l’immensa “Foresta di Belgrado”: prende il nome dalle migliaia di serbi deportati e stanziati lì dagli ottomani dopo la conquista di quella città effettuata da Solimano nel 1521. Sul Bosforo, sempre costa europea, appena fuori dal centro, si incontra poi Arnavutköy, il “villaggio degli albanesi”. A prescindere dal vecchio nucleo greco bizantino sopravvissuto nel Fener (o Phanari in greco) attorno al Patriarcato di Costantinopoli, è di gran lunga il più elegante e ricco dei quartieri diciamo così “etnici”. Quante etnie (40, mi pare scriva Ismail Kadare), quante religioni, quante lingue in quella che rimane la metropoli più cosmopolita del mondo, l’unica a cavallo di due continenti.
L’immenso sultanato dei turchi attirava e/o assimilava a forza. Aveva un bisogno vitale di nuovi cittadini (e non era così stupido da fingere di non saperlo); di soldati, soprattutto, ma anche — per la propria sempre più pletorica burocrazia e contabilità — di gente che sapesse leggere, scrivere e far di conto. Era potentissima e ricchissima, la capitale del Gran Turco: i migliori giovani dei territori conquistati e resi vassalli vi accorrevano a frotte nella dorata prospettiva di farvi carriera. Tanti altri — decine di migliaia — vi venivano invece portati di peso per effetto del devşirme, la “Leva dei giovani”, tassa obbligatoria in forma di esseri umani — adolescenti — cui erano soggetti i territori sottomessi, a partire da quelli della Repubblica di Venezia e viciniori. I più apprezzati, questi ultimi, o perlomeno quelli dimostratisi nel tempo più capaci di entrare nelle grazie del Sultano e di fare carriera. Magari poi lasciandoci la testa, ma — testa o croce — è l’altro lato della medaglia. Tra di essi, imponente e addirittura impressionante il numero degli albanesi.
Apparteneva a quest’ultima schiera, per esempio, un ragazzo di nome Muhammad Ali, nato nella (adesso greca) Kavala e destinato a una sfolgorante carriera militare nell’esercito ottomano, tale da consentirgli di far suo l’Egitto, rapinandolo con audacia ai suoi stessi padroni di Istanbul, e di trasformarlo da provincia turca in regno. Il fondatore dell’Egitto moderno, insomma. Ma soprattutto, ai fini di questo scritto, vi apparteneva il giovanissimo Mehmet, nato nel villaggio di Rudnik, sangiaccato di Berat (attuale Albania), portato nella reggia di Topkapı per farvi il paggio, ivi istruito e divenuto il capostipite di un’intera genealogia di Gran Vizir (cinque di seguito), i famosi Koprülü, i “del Ponte”. Una famiglia tanto potente da divenire seconda soltanto a quella del sultano e da dare il proprio nome a un’intera epoca ottomana, dal 1656 al 1703.
Venendo finalmente all’oggetto di questo scritto, ovvero allo scrittore Ismail Kadare, appartiene a un ramo collaterale di quest’ultima famiglia Mark-Adem, protagonista del romanzo Il palazzo dei sogni, pubblicato nel lontano 1991 dalla Longanesi in traduzione dal francese e ora riproposto dalla Nave di Teseo in traduzione diretta dall’albanese. Da un testo revisionato, immagino, o forse, meglio, da una versione originale, visto che fra le due edizioni italiane esiste una non esigua diversità, se non altro di struttura. Il romanzo albanese ha infatti dovuto essere abilmente contrabbandato in almeno tre (credo) successive configurazioni per poter sfuggire — ma alla fine non del tutto — alla stupida censura di allora in quel paese.
Ho conosciuto e frequentato Kadare nel 1981 e poi nel 1982, quando ancora il suo cognome si scriveva Kadaré con l’accento acuto, alla francese: viveva in semi esilio a Parigi (più tardi in vero e proprio esilio) e vi pubblicava i suoi libri tradotti in quella lingua. E da quella lingua voleva che fossero tradotti: problema di gestione dei diritti d’autore, mi permetto di immaginare, che in Albania non erano riconosciuti, come del resto negli altri paesi comunisti. La casa editrice per la quale lavoravo, la battagliera Longanesi di allora (due Nobel tra 1978 e 1983, una sfilza di Premi Campiello, Vittorio Gassman e Carmelo Bene tra gli autori di contorno), aveva pubblicato il suo Tamburi della pioggia, e io gli avevo fatto da ufficio stampa. Era la prima autorità letteraria (e anche un importante esponente politico) del suo paese, dove, per quella mia attività sono stato invitato dalla potente Lega degli Scrittori l’anno dopo.
Esperienza di grande interesse e discreta complicazione che ho raccontato allora su un importante settimanale e molto più tardi in uno dei miei libri di viaggio. Pare io abbia avuto l’onore di derivarne, in una circolare del Comitato Centrale del Partito del Lavoro albanese, la definizione di “esponente del nemico capitalista che manda i suoi scrittori per denigrare l'Albania Socialista”. Così almeno mi è stato scritto. E sul versante opposto sono anche stato sgridato per lettera dall’allora ambasciatore italiano a Tirana. Un successone, dunque. Ma tutto questo c’entra poco.
C’entra invece il fatto che sono sempre stato affascinato da Istanbul e interessatissimo alla cultura ottomana oltre che alle sue origini asiatiche e successive diramazioni, e I tamburi della pioggia mi aveva dato l’impulso a scrivere il mio romanzo Il cielo della mezzaluna, dove metto in scena diversi personaggi di origine europea (e albanese) provenienti dalla citata “Leva dei giovani”: tutto sommato anche il giovanissimo protagonista, nato a Venezia e divenuto adulto al fianco del sultano Maometto II, il conquistatore di Costantinopoli. E sull’argomento, oltre al romanzo di Kadare mi sono state di notevole utilità diverse sue indicazioni. Non mi ha tuttavia mai parlato del suo testo di ambiente istanbulino, appunto Il palazzo dei sogni, pubblicato proprio allora in Albania ma da me scoperto soltanto alla sua prima traduzione in italiano (1990), e questo mi ha stupito. Sulle prime ho pensato che nel 1981-82 la cosa fosse dipesa dal fatto che il romanzo non era ancora stato tradotto in francese (come avrei potuto leggerlo in albanese?), finché non ho capito che il libro era fortemente osteggiato dalle forze che governavano quel paese.
Kadare mi suggeriva soprattutto di leggere le cronache del veneziano-albanese Marino Barlezio (da lui chiamato Marin Barleti all’albanese). Quanto ai suoi libri, dopo I tamburi della pioggia avrei subito dovuto leggere Il ponte a tre archi. Me l’ha regalato in francese, con dedica, insieme ad altri due. E via via che sarei andato leggendoli (questi tre e altri, anche se non tutti), avrei poi capito che con i suoi romanzi — da vero grande narratore onnisciente — egli intende creare un’unica grande realtà non autentica ma possibile, in cui tutto si tiene. Così il “ponte a tre archi” di cui sopra sarebbe quello da cui origina il cognome dei “del Ponte-Köprülü”, che all’albanese lui chiama Qyprillinj. La storia di questo ponte assomiglia molto a quella del Ponte sulla Drina (Ivo Andrić, Premio Nobel): è un mito dei Balcani. Ma quando l’osservazione mi è scappata fuori in una conversazione con esponenti della Lega degli Scrittori di Albania, sempre di una cordialità addirittura fraterna, li ho visti in un lampo farsi lupacchiotti a denti scoperti in difesa del loro Akela, sono stato sommerso dalle proteste. Sapevano quasi sicuramente che l’amato capo era in disgrazia, io no. È una vicenda albanese — dicevano —, come si è permesso il croato Andrić di usarla? Be’, lo aveva fatto nei primi anni 1940, quindi un bel po’ prima, e comunque le leggende non hanno proprietari e confini…
Fosse come fosse, ho capito che era meglio lasciar perdere, siamo passati ad altre considerazioni. Il Mar Baltico si chiama così perché è colore del fango, che in albanese si dice “balta”. E Bucarest (București in romeno) deve il nome al fatto che in albanese “bucur” significa “bello”, e i soldati illirici arruolati nelle legioni romane d’oriente, al vederla avrebbero esclamato come un solo uomo in sincretico albanese-latino: “Bucur est”, “è bella!”) Eccetera.
Secondo gli storici quel ponte, köprü, del cognome Köprülü-Qyprillinj sarebbe da tutt’altra parte turca, in Anatolia, su verso il Mar Nero — e d’altra parte è forse meglio tornare alle origini e lasciar perdere il potere conseguito con il potente straniero (i sovietici? Stalin come il sultano?): il cognome vero è Ura, ovvero “ponte” in albanese, rimugina qua e là Mark-Adem —, ma, in ambito di romanzo, a Kadare la Storia con la esse maiuscola interessa assai poco, e giustamente: la realtà (narrativa, fittizia) è quella che il narratore demiurgo crea con le sue invenzioni e con il loro intrecciarsi e integrarsi. E la fiction di Kadare fa tesoro di miti e leggende popolari. Di cui il narratore si appropria, piegandoli alle proprie esigenze e facendoli propri. (Quindi ne aveva diritto anche Ivo Andrić. O no?)
Comunque è assolutamente vero, e l’ho sostenuto io stesso più volte. La Storia dei suoi testi narrativi la crea il narratore, e così la Istanbul del Palazzo dei sogni non assomiglia affatto a se stessa ma singolarmente a Tirana. Quell’Edificio-Ministero dà sinistramente l’idea di essere la sede del Comitato Centrale del Partito dei Lavoratori di Albania, passando davanti al quale bisognava addirittura cambiare marciapiede (lo facevo disciplinatamente). Perché quella che Kadare vuole adombrare con il suo romanzo apparentemente storico e centrato sul potere assoluto del Sultano di Istanbul e del suo apparato di repressione, è in realtà una serrata critica delle opacità politiche dell’Albania di Enver Hoxha. Di lì le difficoltà incontrate a suo tempo.
Nel presunto istanbulino Palazzo dei sogni, il Tabir Saraj, in un labirinto di Accettazione, Selezione, Interpretazione e via via fino alla scelta definitiva, si analizzano e interpretano i sogni fatti pervenire in forma scritta alla capitale da tutto l’impero per trarne oroscopi circa il futuro. In realtà il turco tabir, più che “sogno” (rüya) significa precisamente “interpretazione, spiegazione, descrizione”; in particolare “dei sogni”. Ogni venerdì quindi “Il Palazzo (dell’Interpretazione) dei Sogni” presenta al sultano quello selezionato, il Sogno-Guida, l’Arcisogno, affinché egli si orienti nelle proprie azioni.
Ma, attenzione, parallelo al Tabir “scoperto” ne opera un altro, “segreto”… E poi: si tratta di sogni veri o inventati, macchinazioni? È il dubbio che lascia cripticamente intendere il Visir del sultano, zio del protagonista, che si trova a essere il Köprülü-Qyprillinj potente del momento. È stato il potentissimo zio a trovargli l’impiego al Saraj, e per il nipote il dubbio diviene un cruccio: non è per caso che lui è stato infilato lì dentro — con una carriera addirittura fulminea — come quinta colonna, ovvero proprio al fine di squilibrare il potere del sultano e controbilanciarlo con quello riconquistato dalla famiglia Qyripillinj nella persona del suo ultimo Visir, lo zio? Con addirittura il corollario di lasciar giustiziare un fratello dello stesso Visir-zio? Ad altri l’ardua sentenza, la battaglia fra i potentati dell’Albania comunista è cosa del passato, chiarirne i misteri pertiene alla storiografia scientifica, non a chi legge i romanzi di “invenzione”. Che poi magari qualche altro ambasciatore mi sgrida.
A me personalmente, a margine di questo ottimo romanzo (di sicuro uno dei migliori dell’autore), rimane un grosso dubbio. Era davvero comunista l’Albania di Enver Hoxha? Mah. È vero, sosteneva tra l’altro, in nome della ragione, di aver eliminato la religione, ostentava addirittura (a Shkodra, appena entrati dal Montenegro) un Museo dell’ateismo (un altro Palazzo dei sogni?). Ma la cultura, le idee, sono una questione impalpabilmente omnidirezionale, si muovono come vogliono loro. I giovani albanesi finiti a Istanbul, ogni tanto tornavano a casa, portandosi dietro i fenomeni culturali con cui erano entrati in contatto là. E uno dei più importanti fenomeni culturali è sempre la religione, in questo caso l’Islam. In una sua variante molto particolare, però: la quasi eresia sciita dei dervisci bektashi, che aveva fatto forte presa tra i giovani del devşirme, della “Leva dei giovani”, divenuti giannizzeri e poi comandanti della potentissima arma. E tra di essi, quanti albanesi…
Troppo lunga e complessa la vicenda di quella (davvero affascinante) quasi eresia per essere spiegata qui, ma sta di fatto che, bandita nel XIX secolo dal rinnovatore Mahmut II, rinchiusasi in una sorta di setta segreta e definitivamente messa al bando da Kemal Atatürk, essa aveva trovato rifugio e nuova linfa proprio in Albania. Erano tutti ferventi comunisti e risoluti atei, gli amici della Lega degli Scrittori, ma chissà come mai poi si lasciavano regolarmente andare a spiegarmi che, loro ovviamente no, ma la loro famiglia era di fede bektashi. Tutte le famiglie. Anche quella dell’incontestabile capo Hoxha, nato ad Argirocastro. E quella di Kadare? “K”, tra l’altro (vien da strologare), come Köprülü… Era anch’essa originaria della bella Città d’argento. E qualcuno mormorava che a governare l’Albania fosse proprio l’alleanza delle famiglie potenti di quella città. Insomma, molto prima che comunisti erano tutti seguaci del mistico Haji Bektash Veli. Negatori non della religione in sé, ma di quella di stato nell’impero (l’Islam sunnita) in quanto bektashi. Cugini della shiia e della cultura sufi.
Leggendo Il palazzo dei sogni è quasi (banalmente) d’obbligo pensare a Orwell e anche a Kafka, ma a me sono venute soprattutto in mente certe oscurissime e inquietanti considerazioni politiche sui bektashi che si leggono nel Libro nero di Orhan Pamuk (che è posteriore a Kadare, ma attinge moltissimo alla cultura sufi). E, di contorno, romanzi turchi come Nur Baba di Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1922, per i bektashi) e anche L’istituto per la regolazione degli orologi di Ahmet Hamdi Tanpınar (1962, per il kafkiano palazzo-ministero).
Come mi piacerebbe incontrare di nuovo il gentiluomo delle lettere albanesi Ismail Kadare per parlare con lui di queste considerazioni sul (mio presunto) sufismo. Chissà che, come a quei remoti tempi di oltre quarant’anni fa, non possa darmi lo spunto per un nuovo romanzo.
Ismail Kadare, Il Palazzo dei Sogni (2023)
L’immenso sultanato dei turchi attirava e/o assimilava a forza. Aveva un bisogno vitale di nuovi cittadini (e non era così stupido da fingere di non saperlo); di soldati, soprattutto, ma anche — per la propria sempre più pletorica burocrazia e contabilità — di gente che sapesse leggere, scrivere e far di conto. Era potentissima e ricchissima, la capitale del Gran Turco: i migliori giovani dei territori conquistati e resi vassalli vi accorrevano a frotte nella dorata prospettiva di farvi carriera. Tanti altri — decine di migliaia — vi venivano invece portati di peso per effetto del devşirme, la “Leva dei giovani”, tassa obbligatoria in forma di esseri umani — adolescenti — cui erano soggetti i territori sottomessi, a partire da quelli della Repubblica di Venezia e viciniori. I più apprezzati, questi ultimi, o perlomeno quelli dimostratisi nel tempo più capaci di entrare nelle grazie del Sultano e di fare carriera. Magari poi lasciandoci la testa, ma — testa o croce — è l’altro lato della medaglia. Tra di essi, imponente e addirittura impressionante il numero degli albanesi.
Apparteneva a quest’ultima schiera, per esempio, un ragazzo di nome Muhammad Ali, nato nella (adesso greca) Kavala e destinato a una sfolgorante carriera militare nell’esercito ottomano, tale da consentirgli di far suo l’Egitto, rapinandolo con audacia ai suoi stessi padroni di Istanbul, e di trasformarlo da provincia turca in regno. Il fondatore dell’Egitto moderno, insomma. Ma soprattutto, ai fini di questo scritto, vi apparteneva il giovanissimo Mehmet, nato nel villaggio di Rudnik, sangiaccato di Berat (attuale Albania), portato nella reggia di Topkapı per farvi il paggio, ivi istruito e divenuto il capostipite di un’intera genealogia di Gran Vizir (cinque di seguito), i famosi Koprülü, i “del Ponte”. Una famiglia tanto potente da divenire seconda soltanto a quella del sultano e da dare il proprio nome a un’intera epoca ottomana, dal 1656 al 1703.
Venendo finalmente all’oggetto di questo scritto, ovvero allo scrittore Ismail Kadare, appartiene a un ramo collaterale di quest’ultima famiglia Mark-Adem, protagonista del romanzo Il palazzo dei sogni, pubblicato nel lontano 1991 dalla Longanesi in traduzione dal francese e ora riproposto dalla Nave di Teseo in traduzione diretta dall’albanese. Da un testo revisionato, immagino, o forse, meglio, da una versione originale, visto che fra le due edizioni italiane esiste una non esigua diversità, se non altro di struttura. Il romanzo albanese ha infatti dovuto essere abilmente contrabbandato in almeno tre (credo) successive configurazioni per poter sfuggire — ma alla fine non del tutto — alla stupida censura di allora in quel paese.
Ho conosciuto e frequentato Kadare nel 1981 e poi nel 1982, quando ancora il suo cognome si scriveva Kadaré con l’accento acuto, alla francese: viveva in semi esilio a Parigi (più tardi in vero e proprio esilio) e vi pubblicava i suoi libri tradotti in quella lingua. E da quella lingua voleva che fossero tradotti: problema di gestione dei diritti d’autore, mi permetto di immaginare, che in Albania non erano riconosciuti, come del resto negli altri paesi comunisti. La casa editrice per la quale lavoravo, la battagliera Longanesi di allora (due Nobel tra 1978 e 1983, una sfilza di Premi Campiello, Vittorio Gassman e Carmelo Bene tra gli autori di contorno), aveva pubblicato il suo Tamburi della pioggia, e io gli avevo fatto da ufficio stampa. Era la prima autorità letteraria (e anche un importante esponente politico) del suo paese, dove, per quella mia attività sono stato invitato dalla potente Lega degli Scrittori l’anno dopo.
Esperienza di grande interesse e discreta complicazione che ho raccontato allora su un importante settimanale e molto più tardi in uno dei miei libri di viaggio. Pare io abbia avuto l’onore di derivarne, in una circolare del Comitato Centrale del Partito del Lavoro albanese, la definizione di “esponente del nemico capitalista che manda i suoi scrittori per denigrare l'Albania Socialista”. Così almeno mi è stato scritto. E sul versante opposto sono anche stato sgridato per lettera dall’allora ambasciatore italiano a Tirana. Un successone, dunque. Ma tutto questo c’entra poco.
C’entra invece il fatto che sono sempre stato affascinato da Istanbul e interessatissimo alla cultura ottomana oltre che alle sue origini asiatiche e successive diramazioni, e I tamburi della pioggia mi aveva dato l’impulso a scrivere il mio romanzo Il cielo della mezzaluna, dove metto in scena diversi personaggi di origine europea (e albanese) provenienti dalla citata “Leva dei giovani”: tutto sommato anche il giovanissimo protagonista, nato a Venezia e divenuto adulto al fianco del sultano Maometto II, il conquistatore di Costantinopoli. E sull’argomento, oltre al romanzo di Kadare mi sono state di notevole utilità diverse sue indicazioni. Non mi ha tuttavia mai parlato del suo testo di ambiente istanbulino, appunto Il palazzo dei sogni, pubblicato proprio allora in Albania ma da me scoperto soltanto alla sua prima traduzione in italiano (1990), e questo mi ha stupito. Sulle prime ho pensato che nel 1981-82 la cosa fosse dipesa dal fatto che il romanzo non era ancora stato tradotto in francese (come avrei potuto leggerlo in albanese?), finché non ho capito che il libro era fortemente osteggiato dalle forze che governavano quel paese.
Kadare mi suggeriva soprattutto di leggere le cronache del veneziano-albanese Marino Barlezio (da lui chiamato Marin Barleti all’albanese). Quanto ai suoi libri, dopo I tamburi della pioggia avrei subito dovuto leggere Il ponte a tre archi. Me l’ha regalato in francese, con dedica, insieme ad altri due. E via via che sarei andato leggendoli (questi tre e altri, anche se non tutti), avrei poi capito che con i suoi romanzi — da vero grande narratore onnisciente — egli intende creare un’unica grande realtà non autentica ma possibile, in cui tutto si tiene. Così il “ponte a tre archi” di cui sopra sarebbe quello da cui origina il cognome dei “del Ponte-Köprülü”, che all’albanese lui chiama Qyprillinj. La storia di questo ponte assomiglia molto a quella del Ponte sulla Drina (Ivo Andrić, Premio Nobel): è un mito dei Balcani. Ma quando l’osservazione mi è scappata fuori in una conversazione con esponenti della Lega degli Scrittori di Albania, sempre di una cordialità addirittura fraterna, li ho visti in un lampo farsi lupacchiotti a denti scoperti in difesa del loro Akela, sono stato sommerso dalle proteste. Sapevano quasi sicuramente che l’amato capo era in disgrazia, io no. È una vicenda albanese — dicevano —, come si è permesso il croato Andrić di usarla? Be’, lo aveva fatto nei primi anni 1940, quindi un bel po’ prima, e comunque le leggende non hanno proprietari e confini…
Fosse come fosse, ho capito che era meglio lasciar perdere, siamo passati ad altre considerazioni. Il Mar Baltico si chiama così perché è colore del fango, che in albanese si dice “balta”. E Bucarest (București in romeno) deve il nome al fatto che in albanese “bucur” significa “bello”, e i soldati illirici arruolati nelle legioni romane d’oriente, al vederla avrebbero esclamato come un solo uomo in sincretico albanese-latino: “Bucur est”, “è bella!”) Eccetera.
Secondo gli storici quel ponte, köprü, del cognome Köprülü-Qyprillinj sarebbe da tutt’altra parte turca, in Anatolia, su verso il Mar Nero — e d’altra parte è forse meglio tornare alle origini e lasciar perdere il potere conseguito con il potente straniero (i sovietici? Stalin come il sultano?): il cognome vero è Ura, ovvero “ponte” in albanese, rimugina qua e là Mark-Adem —, ma, in ambito di romanzo, a Kadare la Storia con la esse maiuscola interessa assai poco, e giustamente: la realtà (narrativa, fittizia) è quella che il narratore demiurgo crea con le sue invenzioni e con il loro intrecciarsi e integrarsi. E la fiction di Kadare fa tesoro di miti e leggende popolari. Di cui il narratore si appropria, piegandoli alle proprie esigenze e facendoli propri. (Quindi ne aveva diritto anche Ivo Andrić. O no?)
Comunque è assolutamente vero, e l’ho sostenuto io stesso più volte. La Storia dei suoi testi narrativi la crea il narratore, e così la Istanbul del Palazzo dei sogni non assomiglia affatto a se stessa ma singolarmente a Tirana. Quell’Edificio-Ministero dà sinistramente l’idea di essere la sede del Comitato Centrale del Partito dei Lavoratori di Albania, passando davanti al quale bisognava addirittura cambiare marciapiede (lo facevo disciplinatamente). Perché quella che Kadare vuole adombrare con il suo romanzo apparentemente storico e centrato sul potere assoluto del Sultano di Istanbul e del suo apparato di repressione, è in realtà una serrata critica delle opacità politiche dell’Albania di Enver Hoxha. Di lì le difficoltà incontrate a suo tempo.
Nel presunto istanbulino Palazzo dei sogni, il Tabir Saraj, in un labirinto di Accettazione, Selezione, Interpretazione e via via fino alla scelta definitiva, si analizzano e interpretano i sogni fatti pervenire in forma scritta alla capitale da tutto l’impero per trarne oroscopi circa il futuro. In realtà il turco tabir, più che “sogno” (rüya) significa precisamente “interpretazione, spiegazione, descrizione”; in particolare “dei sogni”. Ogni venerdì quindi “Il Palazzo (dell’Interpretazione) dei Sogni” presenta al sultano quello selezionato, il Sogno-Guida, l’Arcisogno, affinché egli si orienti nelle proprie azioni.
Ma, attenzione, parallelo al Tabir “scoperto” ne opera un altro, “segreto”… E poi: si tratta di sogni veri o inventati, macchinazioni? È il dubbio che lascia cripticamente intendere il Visir del sultano, zio del protagonista, che si trova a essere il Köprülü-Qyprillinj potente del momento. È stato il potentissimo zio a trovargli l’impiego al Saraj, e per il nipote il dubbio diviene un cruccio: non è per caso che lui è stato infilato lì dentro — con una carriera addirittura fulminea — come quinta colonna, ovvero proprio al fine di squilibrare il potere del sultano e controbilanciarlo con quello riconquistato dalla famiglia Qyripillinj nella persona del suo ultimo Visir, lo zio? Con addirittura il corollario di lasciar giustiziare un fratello dello stesso Visir-zio? Ad altri l’ardua sentenza, la battaglia fra i potentati dell’Albania comunista è cosa del passato, chiarirne i misteri pertiene alla storiografia scientifica, non a chi legge i romanzi di “invenzione”. Che poi magari qualche altro ambasciatore mi sgrida.
A me personalmente, a margine di questo ottimo romanzo (di sicuro uno dei migliori dell’autore), rimane un grosso dubbio. Era davvero comunista l’Albania di Enver Hoxha? Mah. È vero, sosteneva tra l’altro, in nome della ragione, di aver eliminato la religione, ostentava addirittura (a Shkodra, appena entrati dal Montenegro) un Museo dell’ateismo (un altro Palazzo dei sogni?). Ma la cultura, le idee, sono una questione impalpabilmente omnidirezionale, si muovono come vogliono loro. I giovani albanesi finiti a Istanbul, ogni tanto tornavano a casa, portandosi dietro i fenomeni culturali con cui erano entrati in contatto là. E uno dei più importanti fenomeni culturali è sempre la religione, in questo caso l’Islam. In una sua variante molto particolare, però: la quasi eresia sciita dei dervisci bektashi, che aveva fatto forte presa tra i giovani del devşirme, della “Leva dei giovani”, divenuti giannizzeri e poi comandanti della potentissima arma. E tra di essi, quanti albanesi…
Troppo lunga e complessa la vicenda di quella (davvero affascinante) quasi eresia per essere spiegata qui, ma sta di fatto che, bandita nel XIX secolo dal rinnovatore Mahmut II, rinchiusasi in una sorta di setta segreta e definitivamente messa al bando da Kemal Atatürk, essa aveva trovato rifugio e nuova linfa proprio in Albania. Erano tutti ferventi comunisti e risoluti atei, gli amici della Lega degli Scrittori, ma chissà come mai poi si lasciavano regolarmente andare a spiegarmi che, loro ovviamente no, ma la loro famiglia era di fede bektashi. Tutte le famiglie. Anche quella dell’incontestabile capo Hoxha, nato ad Argirocastro. E quella di Kadare? “K”, tra l’altro (vien da strologare), come Köprülü… Era anch’essa originaria della bella Città d’argento. E qualcuno mormorava che a governare l’Albania fosse proprio l’alleanza delle famiglie potenti di quella città. Insomma, molto prima che comunisti erano tutti seguaci del mistico Haji Bektash Veli. Negatori non della religione in sé, ma di quella di stato nell’impero (l’Islam sunnita) in quanto bektashi. Cugini della shiia e della cultura sufi.
Leggendo Il palazzo dei sogni è quasi (banalmente) d’obbligo pensare a Orwell e anche a Kafka, ma a me sono venute soprattutto in mente certe oscurissime e inquietanti considerazioni politiche sui bektashi che si leggono nel Libro nero di Orhan Pamuk (che è posteriore a Kadare, ma attinge moltissimo alla cultura sufi). E, di contorno, romanzi turchi come Nur Baba di Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1922, per i bektashi) e anche L’istituto per la regolazione degli orologi di Ahmet Hamdi Tanpınar (1962, per il kafkiano palazzo-ministero).
Come mi piacerebbe incontrare di nuovo il gentiluomo delle lettere albanesi Ismail Kadare per parlare con lui di queste considerazioni sul (mio presunto) sufismo. Chissà che, come a quei remoti tempi di oltre quarant’anni fa, non possa darmi lo spunto per un nuovo romanzo.
Ismail Kadare, Il Palazzo dei Sogni (2023)