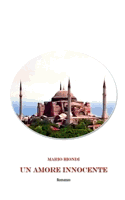Un’intervista (1987)
Cielo! Dove sono l’abbigliamento da giungla, la giacca termica, la carabina da caccia agli elefanti, la bussola, gli stivaloni da pesca, le canne e le lenze? Come: neanche un po’ di acciarino e pietra focaia? Wilbur Smith - 54 anni portati splendidamente, completo blu, sobria cravatta bordò, scarpe lucidissime, barba perfettamente rasata, vago sentore di una colonia molto fine - scoppia a ridere. «Vede», replica, «da noi c’è la leggenda del "cimitero degli elefanti", non so se esiste anche qui.» Esiste, esiste. «Be’, tutte le cose di cui scherzava lei, ovvero tutto il buon abbigliamento sportivo e trasandato in cui mi trovavo tanto a mio agio in ogni momento della mia vita fino a qualche anno fa, è scomparso nel momento in cui nella suddetta mia vita è entrata quella donna. Sparito nel cimitero degli elefanti. Pardon: degli abiti.»
«Quella donna» - che partecipa con un sorriso dalla poltrona di fronte, nella luminosissima suite del Principe di Savoia a Milano - è Danielle, la sua terza moglie. Gli ha dato tre figli (più un quarto da lei stessa avuto in un precedente matrimonio), gli ha organizzato la vita, gli ha buttato via gli stracci folcloristici con cui amava travestirsi da scrittore di avventure e, con la sua collaborazione sapiente di ricercatrice e consigliera letteraria lo ha fatto diventare - come tutto il mondo riconosce - il «leader» degli scrittori d’avventura. Il più bravo. Il più letto, se le cifre valgono qualcosa: ventuno romanzi per un totale di più di quaranta milioni di copie vendute nel mondo (due milioni solamente in Italia, dei quattordici titoli usciti fino a ora). Tre di essi già ridotti in versione cinematografica, almeno altri tre pronti a esserlo. Citiamone qualcuno: Come il mare (forse il più famoso), Il destino del leone (forse il più bello), L’orma del califfo, La spiaggia infuocata, Quando vola il falco.
E in questi giorni, almeno in Italia, Il potere della spada, (Longanesi) quinto volume della saga della famiglia sudafricana dei Courteney. Per questo è qui, per il lancio, per farsi conoscere di persona anche dal nostro pubblico, che lo ama moltissimo ma non ha mai avuto il piacere di vederlo dal vivo. Wilbur Smith, infatti, non ama particolamente la pubblicità. Preferisce starsene al riparo nella sua bella casa ai piedi di Table Mountain, a Città del Capo, a trecento metri dal più magnifico e lussureggiante dei giardini botanici, oppure nel pezzo di isola che possiede alle Seychelles, oppure ancora in giro, ai comandi di un’aereo da turismo, della sua barchetta da pesca in alto mare, vestito alla vecchia maniera, a godersi le bellezze del nostro mondo e a raccogliere idee per i suoi romanzi. Non è certamente un animale da salotto. Ma finalmente è arrivato anche qui, non solamente in incognito, per informarsi sui dettami della moda, per comperare abiti e - soprattutto - scarpe, ma nella sua veste ufficiale di «leader» mondiale degli scrittori di avventure.
E’ arrivato da Londra, dove ha festeggiato l’uscita del ventunesimo romanzo, Rage (ovvero «Furore»), sesto e forse conclusivo volume della saga dei Courteney. «Ma», precisa, «non è affatto detto che finisca. Come faccio a sapere quali intenzioni hanno veramente i miei personaggi? I Courteney potrebbero persino, un giorno o l’altro, incontrarsi con i Ballantyne. Non si sa mai. Non mettiamo limiti alla provvidenza romanzesca.» I Ballantyne sono i protagonisti dell’altra sua granda saga, quella rhodesiana (finora in Italia sono usciti il primo e il quarto volume, Quando vola il falco e La spiaggia infuocata, mentre è annunciata la prossima uscita del secondo, Men of Men, che non ha ancora un titolo italiano ma significa “Uomini veri”.)
La vita di Wilbur Smith, infatti, da quando nel 1933 è nato in quella che allora era la Rhodesia del Nord e ora è lo Zambia, si è quasi tutta svolta nei territori meridionali dell’Africa: le due Rhodesie, Sudafrica, Namibia. E lì - con non poche fughe a New York, Londra, Roma, Atene, Tel Aviv eccetera - sono in larghissima misura ambientati i suoi romanzi, in questo secolo come in quello passato. Diamanti, oro, zulu, boscimani, leoni, gazzelle, navi negriere, petroliere oceaniche, jet da combattimento, ragazzi stupendi, fanciulle dolcissime, uomini poderosi, donne intrepide, spioni, traditori, amore, odio, sangue, vita e morte. Un miscuglio affascinante e travolgente. Ma com’è stata la sua vita in quelle terre remote?
«Mio padre era un allevatore, forniva bestiame da macello per il personale delle miniere di rame della Rhodesia del Nord. Era una persona benestante, e quindi ho avuto un’infanzia molto sicura. Ma nel paese non c’erano scuole, per cui ho frequentato quelle del Sudafrica, andandovi con il treno per quattro giorni alla settimana. Finita l’università, mi sarebbe piaciuto fare il giornalista, ma mio padre non ha voluto sentirne parlare. "Figlio mio", mi ha detto, "i giornalisti muoiono di fame." E ho dovuto fare il contabile. Il più triste dei contabili, sempre con il tarlo dello scrivere. Così, di notte e nei ritagli di tempo, ho scritto il mio primo romanzo, riempiendolo di tutti gli errori tipici della prima opera di un dilettante. L’ho mandato a non so quanti editori, che l’hanno respinto tutti. Bene, mi sono detto, evidentemente il mestiere dello scrittore non è il mio pane. Poi è successo una specie di miracolo. Una delle persone a cui avevo mandato il manoscritto era una agente letteraria di Londra, che dopo un anno circa mi scrisse per chiedermi se per caso ne avessi scritto un altro. Le risposi che mi era sembrato meglio smettere. Peccato, replicò, perché nel suo testo c’era molto di buono. Trovato nuovo entusiasmo - ingrediente fondamentale del successo letterario - scrissi Il destino del leone. Un editore mi rispose nel giro di una settimana. Da allora ho chiuso la mia attività di contabile. Faccio il disoccupato.»
E ride, beato. Quaranta milioni di copie, quanto vorranno dire, in termini economici? Proviamo a pensare soltanto a una media di mille lire a copia... Be’, meglio lasciar perdere. Ma com’è stato essere giovani, da quelle parti? «Vede, lo Zambia era un paese molto poco popolato, con pochissimi bianchi, e la mia gioventù l’ho passata essenzialmente all’aperto, nella foresta. Quando ero a casa da scuola, prendevo con me una coperta e un fucile, e andavo. Avevo due carissimi amici neri, partivamo assieme, stavamo via cinque, otto, dieci giorni, a caccia, dormendo di notte vicino al fuoco da campo, loro due sui lati e io in mezzo, per ripararmi nel loro calore. Faceva un freddo tremendo, ma era magnifico. E’ da lì che viene il mio grande amore per l’Africa, per la foresta, per gli animali. E’ così che ho acquisito la coscienza di essere africano.»
Ma i rapporti con altri bianchi? «In effetti a casa erano rari. Ma ho avuto la fortuna di frequentare le scuole pubbliche sudafricane di allora, identiche a quelle inglesi, con la stessa disciplina rigidissima e la stessa qualità di insegnamento. Ho avuto degli ottimi maestri, che mi hanno insegnato a leggere. A dodici, tredici anni, leggevo moltissimo, anche di notte, nascosto sotto le coperte. Viene da lì il mio amore per i libri, per la lettura. Bisogna leggere moltissimo e bene per imparare a scrivere. E’ quello che consiglio sempre agli aspiranti scrittori. E’ la condizione essenziale. La tecnica del romanzo si può apprendere soltanto leggendone sempre di più. E poi scrivendo, scrivendo tanto, senza perdere tempo al bar a parlare di scrittura, ma praticandola. A quindici, sedici anni, ho cominciato a sognare di diventare uno scrittore anch’io.»
E ora che lo è diventato, e con tanto successo, quando non scrive, che cosa fa? «Mi piace soprattutto andare a pesca. Ho una barca apposta, non molto grande, otto metri circa, in modo da poterla attaccare all’auto e correre dove ci sono le passate dei tonni. Ogni anno, poi, andiamo in Alaska, per i salmoni. A mia moglie, infine, piace moltissimo pescare la trota nei torrenti. E andiamo a farlo in Nuova Zelanda, in Sudamerica. E’ durante questi spostamenti che mi vengono gran parte delle idee che uso per i romanzi. Ne discuto con Danielle, che prima di tutto mi espone il lato femminile di vedere le cose e poi legge ogni pagina che scrivo, giorno per giorno, dandomi i suoi suggerimenti.»
Ma torniamo alla vita libera. «Ci piace molto anche sciare. Infatti proprio adesso siamo reduci da un periodo in Svizzera, a Davos, con neve magnifica. E poi ho ricominciato ad andare a caccia. Avevo smesso, non volevo più veder morire animali, ma ora mi sono convinto che la caccia controllata dal governo secondo principi rigidamente etici sia un’arma fortissima per la salvaguardia delle specie selvatiche africane. Quindi, dopo venti anni, ho ricominciato. Credo che sia addirittura una forma di amore nei confronti degli animali.»
Che cos’è l’amore, signor Smith? «In sé è la scusa mistica dell’esistenza. Senza amore tutto il resto non ha sapore. Amore non significa soltanto sesso, tenersi per mano, scambiarsi sguardi e altre simili bellissime cose. E’ fiducia. Sostegno. Capacità e possibilità di dividere con un’altra persona la più grande delle gioie come la più tremenda delle tragedie.»
(Max, maggio 1987)
«Quella donna» - che partecipa con un sorriso dalla poltrona di fronte, nella luminosissima suite del Principe di Savoia a Milano - è Danielle, la sua terza moglie. Gli ha dato tre figli (più un quarto da lei stessa avuto in un precedente matrimonio), gli ha organizzato la vita, gli ha buttato via gli stracci folcloristici con cui amava travestirsi da scrittore di avventure e, con la sua collaborazione sapiente di ricercatrice e consigliera letteraria lo ha fatto diventare - come tutto il mondo riconosce - il «leader» degli scrittori d’avventura. Il più bravo. Il più letto, se le cifre valgono qualcosa: ventuno romanzi per un totale di più di quaranta milioni di copie vendute nel mondo (due milioni solamente in Italia, dei quattordici titoli usciti fino a ora). Tre di essi già ridotti in versione cinematografica, almeno altri tre pronti a esserlo. Citiamone qualcuno: Come il mare (forse il più famoso), Il destino del leone (forse il più bello), L’orma del califfo, La spiaggia infuocata, Quando vola il falco.
E in questi giorni, almeno in Italia, Il potere della spada, (Longanesi) quinto volume della saga della famiglia sudafricana dei Courteney. Per questo è qui, per il lancio, per farsi conoscere di persona anche dal nostro pubblico, che lo ama moltissimo ma non ha mai avuto il piacere di vederlo dal vivo. Wilbur Smith, infatti, non ama particolamente la pubblicità. Preferisce starsene al riparo nella sua bella casa ai piedi di Table Mountain, a Città del Capo, a trecento metri dal più magnifico e lussureggiante dei giardini botanici, oppure nel pezzo di isola che possiede alle Seychelles, oppure ancora in giro, ai comandi di un’aereo da turismo, della sua barchetta da pesca in alto mare, vestito alla vecchia maniera, a godersi le bellezze del nostro mondo e a raccogliere idee per i suoi romanzi. Non è certamente un animale da salotto. Ma finalmente è arrivato anche qui, non solamente in incognito, per informarsi sui dettami della moda, per comperare abiti e - soprattutto - scarpe, ma nella sua veste ufficiale di «leader» mondiale degli scrittori di avventure.
E’ arrivato da Londra, dove ha festeggiato l’uscita del ventunesimo romanzo, Rage (ovvero «Furore»), sesto e forse conclusivo volume della saga dei Courteney. «Ma», precisa, «non è affatto detto che finisca. Come faccio a sapere quali intenzioni hanno veramente i miei personaggi? I Courteney potrebbero persino, un giorno o l’altro, incontrarsi con i Ballantyne. Non si sa mai. Non mettiamo limiti alla provvidenza romanzesca.» I Ballantyne sono i protagonisti dell’altra sua granda saga, quella rhodesiana (finora in Italia sono usciti il primo e il quarto volume, Quando vola il falco e La spiaggia infuocata, mentre è annunciata la prossima uscita del secondo, Men of Men, che non ha ancora un titolo italiano ma significa “Uomini veri”.)
La vita di Wilbur Smith, infatti, da quando nel 1933 è nato in quella che allora era la Rhodesia del Nord e ora è lo Zambia, si è quasi tutta svolta nei territori meridionali dell’Africa: le due Rhodesie, Sudafrica, Namibia. E lì - con non poche fughe a New York, Londra, Roma, Atene, Tel Aviv eccetera - sono in larghissima misura ambientati i suoi romanzi, in questo secolo come in quello passato. Diamanti, oro, zulu, boscimani, leoni, gazzelle, navi negriere, petroliere oceaniche, jet da combattimento, ragazzi stupendi, fanciulle dolcissime, uomini poderosi, donne intrepide, spioni, traditori, amore, odio, sangue, vita e morte. Un miscuglio affascinante e travolgente. Ma com’è stata la sua vita in quelle terre remote?
«Mio padre era un allevatore, forniva bestiame da macello per il personale delle miniere di rame della Rhodesia del Nord. Era una persona benestante, e quindi ho avuto un’infanzia molto sicura. Ma nel paese non c’erano scuole, per cui ho frequentato quelle del Sudafrica, andandovi con il treno per quattro giorni alla settimana. Finita l’università, mi sarebbe piaciuto fare il giornalista, ma mio padre non ha voluto sentirne parlare. "Figlio mio", mi ha detto, "i giornalisti muoiono di fame." E ho dovuto fare il contabile. Il più triste dei contabili, sempre con il tarlo dello scrivere. Così, di notte e nei ritagli di tempo, ho scritto il mio primo romanzo, riempiendolo di tutti gli errori tipici della prima opera di un dilettante. L’ho mandato a non so quanti editori, che l’hanno respinto tutti. Bene, mi sono detto, evidentemente il mestiere dello scrittore non è il mio pane. Poi è successo una specie di miracolo. Una delle persone a cui avevo mandato il manoscritto era una agente letteraria di Londra, che dopo un anno circa mi scrisse per chiedermi se per caso ne avessi scritto un altro. Le risposi che mi era sembrato meglio smettere. Peccato, replicò, perché nel suo testo c’era molto di buono. Trovato nuovo entusiasmo - ingrediente fondamentale del successo letterario - scrissi Il destino del leone. Un editore mi rispose nel giro di una settimana. Da allora ho chiuso la mia attività di contabile. Faccio il disoccupato.»
E ride, beato. Quaranta milioni di copie, quanto vorranno dire, in termini economici? Proviamo a pensare soltanto a una media di mille lire a copia... Be’, meglio lasciar perdere. Ma com’è stato essere giovani, da quelle parti? «Vede, lo Zambia era un paese molto poco popolato, con pochissimi bianchi, e la mia gioventù l’ho passata essenzialmente all’aperto, nella foresta. Quando ero a casa da scuola, prendevo con me una coperta e un fucile, e andavo. Avevo due carissimi amici neri, partivamo assieme, stavamo via cinque, otto, dieci giorni, a caccia, dormendo di notte vicino al fuoco da campo, loro due sui lati e io in mezzo, per ripararmi nel loro calore. Faceva un freddo tremendo, ma era magnifico. E’ da lì che viene il mio grande amore per l’Africa, per la foresta, per gli animali. E’ così che ho acquisito la coscienza di essere africano.»
Ma i rapporti con altri bianchi? «In effetti a casa erano rari. Ma ho avuto la fortuna di frequentare le scuole pubbliche sudafricane di allora, identiche a quelle inglesi, con la stessa disciplina rigidissima e la stessa qualità di insegnamento. Ho avuto degli ottimi maestri, che mi hanno insegnato a leggere. A dodici, tredici anni, leggevo moltissimo, anche di notte, nascosto sotto le coperte. Viene da lì il mio amore per i libri, per la lettura. Bisogna leggere moltissimo e bene per imparare a scrivere. E’ quello che consiglio sempre agli aspiranti scrittori. E’ la condizione essenziale. La tecnica del romanzo si può apprendere soltanto leggendone sempre di più. E poi scrivendo, scrivendo tanto, senza perdere tempo al bar a parlare di scrittura, ma praticandola. A quindici, sedici anni, ho cominciato a sognare di diventare uno scrittore anch’io.»
E ora che lo è diventato, e con tanto successo, quando non scrive, che cosa fa? «Mi piace soprattutto andare a pesca. Ho una barca apposta, non molto grande, otto metri circa, in modo da poterla attaccare all’auto e correre dove ci sono le passate dei tonni. Ogni anno, poi, andiamo in Alaska, per i salmoni. A mia moglie, infine, piace moltissimo pescare la trota nei torrenti. E andiamo a farlo in Nuova Zelanda, in Sudamerica. E’ durante questi spostamenti che mi vengono gran parte delle idee che uso per i romanzi. Ne discuto con Danielle, che prima di tutto mi espone il lato femminile di vedere le cose e poi legge ogni pagina che scrivo, giorno per giorno, dandomi i suoi suggerimenti.»
Ma torniamo alla vita libera. «Ci piace molto anche sciare. Infatti proprio adesso siamo reduci da un periodo in Svizzera, a Davos, con neve magnifica. E poi ho ricominciato ad andare a caccia. Avevo smesso, non volevo più veder morire animali, ma ora mi sono convinto che la caccia controllata dal governo secondo principi rigidamente etici sia un’arma fortissima per la salvaguardia delle specie selvatiche africane. Quindi, dopo venti anni, ho ricominciato. Credo che sia addirittura una forma di amore nei confronti degli animali.»
Che cos’è l’amore, signor Smith? «In sé è la scusa mistica dell’esistenza. Senza amore tutto il resto non ha sapore. Amore non significa soltanto sesso, tenersi per mano, scambiarsi sguardi e altre simili bellissime cose. E’ fiducia. Sostegno. Capacità e possibilità di dividere con un’altra persona la più grande delle gioie come la più tremenda delle tragedie.»
(Max, maggio 1987)