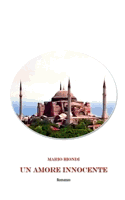Scrive di: Sabriye Tenberken
Recensione: “Vedere con il cuore” (2008)
Recensione: “Vedere con il cuore” (2008)
© Mario Biondi
Divieto di riproduzione integrale
e obbligo di citazione (per cortesia...)
Straordinario paese, il Tibet, misterioso e affascinante proprio perché ancora in buona parte chiuso su se stesso e sulla propria intricata cultura-religione, dopo essere stato per secoli letteralmente sprangato. Un rifiuto, una quasi ripugnanza nei confronti del mondo esterno che ha spesso assunto tratti violenti, come hanno dovuto sperimentare i viaggiatori che vi si sono insinuati a rischio della vita fino a una cinquantina di anni fa. Dai missionari portoghesi di Goa nel Seicento giù giù fino allo spericolato Sven Hedin, dispostissimo a lasciarci la pelle pur di riuscire a mappare il territorio e a individuare in maniera incontrovertibile le sorgenti dei grandi fiumi dell'Asia, che partono tutti da lì. Dalla inarrestabile viaggiatrice franco-buddista Alexandra David-Neel ai vari personaggi che riuscirono a salire tra quelle asperrime montagne negli anni Trenta e Quaranta del Novecento: erano, stranamente, tutti amici del Führer e del Duce. Essendo questi ultimi due alleati dei giapponesi che in quegli anni invadevano e martirizzavano la Cina, non è azzardato ipotizzare che tramite loro la teocrazia tibetana aspirasse a conseguire quell'entità di stato che in realtà la zona non ha mai avuto nella sua totalità in un modo organico e storicamente documentato. Führer e Duce erano inoltre in guerra con i britannici, rei di aver invaso nel 1903 il Tibet salendo dall'India, entrandovi a raffiche di mitraglia e facendo qualche migliaio di morti, agli ordini del discutibile colonnello Younghusband.
È convinzione largamente diffusa che si tratti di un paese di "non violenti", ma le cronache di viaggio dei sopra indicati personaggi lascerebbero pensare esattamente il contrario: a ogni piè sospinto, nelle loro peregrinazioni e nei loro accampamenti notturni, si trovavano di fronte al dilemma "o la borsa o la vita", persino Heinrich Harrer, appartenente di pieno diritto alla schiera degli amici del Führer e assurto addirittura a precettore dell'attuale Dalai Lama. Anche se ormai non è più difficile entrare nel Tibet e viaggiarci (a meno che, stando alle cronache, non si sia giornalisti accreditati), di questa favoleggiata "non violenza" è stata fatta oggetto qualche anno fa anche una tra i più singolari visitatori di quel remoto paese: la tedesca Sabriye Tenberken, che almeno due volte si è trovata a percorrervi lunghi itinerari a cavallo, venendo con discreta regolarità braccata, minacciata e depredata. I tibetani non sono di sicuro tutti così, ci mancherebbe altro, ma persino alcune ascensioni all'Everest sono state messe più che a repentaglio dalle razzie di cui sono state fatte oggetto le loro scorte vitali.
Sabriye Tenberken non viaggiava (e non viaggia) da quelle parti per egoistici motivi di turismo, ma per cercare di portarvi letteralmente “la luce”. Non nel senso tecnologico della corrente elettrica — che, piaccia o non piaccia, è stata portata lì dai cinesi insieme a ospedali, scuole, strade, aerei, treni —, ma in quello molto più profondamente umano della “vista”. La coraggiosa viaggiatrice, infatti, è divenuta cieca in giovanissima età, e da poco dopo, con ferrea determinazione, ha cominciato ad adoperarsi per il miglioramento della condizione dei suoi simili. Per questo è arrivata fino in Tibet: per diffondervi l'alfabeto Braille tibetano da lei stessa creato e cercare di crearvi strutture di sostegno per non vedenti, prima con una scuola per bambini a Lhasa e poi con una fattoria per adulti vicino a Shigatse, dove sorge il monastero di Tashilhunpo, sede del Panchen Lama, perenne avversario del (e secondo i suoi seguaci addirittura superiore di grado al) Dalai Lama.
Un'impresa particolarmente delicata, quella affrontata da Sabriye Ternbeken, perché nella logica dei buddisti tibetani il non vedente pagherebbe con la sua condizione le conseguenze di un karma negativo, dovuto ai peccati della vita precedente. E di non vedenti ce ne sono tanti, a causa dell'avitaminosi, dell'alimentazione scadente, della luce sfolgorante e della grassa fuliggine sprigionata dallo sterco di yak usato come combustibile a causa della penuria se non addirittura assenza di legname. Così i ciechi, anche quando circondati da relativo affetto nell'ambiente famigliare, devono però essere protetti dal mondo esterno, che nella sua presunta non-violenza aggiunge molto alla punizione del karma. Se non sono tenuti prigionieri in casa, capita di vederli trascinarsi furtivamente nei mercati popolari alla ricerca di un po' di elemosina, e fanno veramente stringere il cuore.
La prima parte di questa sua appassionante vicenda (il complicato arrivo in Tibet e l'altrettanto complicata creazione della scuola di Lhasa, con relative depredazioni ma anche con straordinari gesti di liberalità) Sabryie l'aveva raccontata alcuni anni fa in La mia strada porta in Tibet. In Vedere con il cuore, invece, uscito in questi giorni, racconta l'evolversi dell'impresa in una vicenda davvero ai limiti del possibile: l'ascesa dei suoi ragazzini ciechi al Laghpa Ri, un 7000 metri di fianco all'Everest. Ascesa (credo non si debba parlare di vera e propria scalata) voluta e organizzata da una cineasta americana in collaborazione con il primo cieco arrivato in vetta all'Everest (un giovane americano, ma ogni 15 giorni circa si legge di una "prima" particolarissima sulla Vetta del Mondo, dello scalatore doppiamente amputato, di quello di età sempre più veneranda, di quello in elicottero, eccetera). Il fine dell'azzardata impresa dei ragazzini ciechi era un film, che è infatti stato distribuito in questi giorni nel mondo.
La realizzazione del film ha richiesto un intervento in diretta non soltanto dei responsabili della scuola (Sabriye, il suo compagno Paul e gli insegnanti locali) ma soprattutto dei giovani allievi, a cui è stato chiesto di raccontare davanti alla videocamera la loro storia. Storie toccanti, che nel libro sono riportate direttamente dalle registrazioni in voce. Addirittura straziante il racconto del più "difficile" dei ragazzini, che sembrava vivere in una sua privatissima monade di disperazione senza voler comunicare con nessuno. Davanti alla video camera invece si lascia andare e parla, raccontando una terribile vicenda personale di abbandono, addirittura di scambio, da parte del padre (cinese).
Raccolte le testimonianze necessarie, la spedizione si avvia verso la sua scalata, per un'impresa senza dubbio eccezionale ma non tale, tutto considerato, da non suscitare parecchi dubbi: i record "estremi" servono senz'altro a scatenare la ridda promozionale mediatica, ma in genere contribuiscono molto poco ad aiutare sul serio chi soffre di condizioni difficili. Per fortuna, però, nel corso del bel libro si arriva presto (e con sollievo) a capire che dai medesimi dubbi, e fortissimi, è attanagliata Sabriye: sa che ai suoi protetti quell'impresa, tra l'altro estranea allo spirito dei tibetani, non porterà praticamente niente, se non al più (fatto tuttavia da non trascurare) un supplemento di quei finanziamenti di cui la sua iniziativa è sempre famelica. Il film è stato realizzato, e i finanziamenti si spera siano arrivati, quindi è soltanto con sollievo che nel finale si legge della saggia rinuncia, una volta arrivati sui 6000 metri, tra ghiacci quasi da favola, a completare l'ascesa per non mettere a vero repentaglio le vite dei giovanissimi. Lungi dal diminuire l'interesse del libro, questa onesta rinuncia gli conferisce al contrario autentica emozione, derubricando la vicenda da un ambiguo "troppo umano" a una profonda, toccante e incontestabile umanità.
Sabriye Tenberken, “Vedere con il cuore”, Corbaccio
È convinzione largamente diffusa che si tratti di un paese di "non violenti", ma le cronache di viaggio dei sopra indicati personaggi lascerebbero pensare esattamente il contrario: a ogni piè sospinto, nelle loro peregrinazioni e nei loro accampamenti notturni, si trovavano di fronte al dilemma "o la borsa o la vita", persino Heinrich Harrer, appartenente di pieno diritto alla schiera degli amici del Führer e assurto addirittura a precettore dell'attuale Dalai Lama. Anche se ormai non è più difficile entrare nel Tibet e viaggiarci (a meno che, stando alle cronache, non si sia giornalisti accreditati), di questa favoleggiata "non violenza" è stata fatta oggetto qualche anno fa anche una tra i più singolari visitatori di quel remoto paese: la tedesca Sabriye Tenberken, che almeno due volte si è trovata a percorrervi lunghi itinerari a cavallo, venendo con discreta regolarità braccata, minacciata e depredata. I tibetani non sono di sicuro tutti così, ci mancherebbe altro, ma persino alcune ascensioni all'Everest sono state messe più che a repentaglio dalle razzie di cui sono state fatte oggetto le loro scorte vitali.
Sabriye Tenberken non viaggiava (e non viaggia) da quelle parti per egoistici motivi di turismo, ma per cercare di portarvi letteralmente “la luce”. Non nel senso tecnologico della corrente elettrica — che, piaccia o non piaccia, è stata portata lì dai cinesi insieme a ospedali, scuole, strade, aerei, treni —, ma in quello molto più profondamente umano della “vista”. La coraggiosa viaggiatrice, infatti, è divenuta cieca in giovanissima età, e da poco dopo, con ferrea determinazione, ha cominciato ad adoperarsi per il miglioramento della condizione dei suoi simili. Per questo è arrivata fino in Tibet: per diffondervi l'alfabeto Braille tibetano da lei stessa creato e cercare di crearvi strutture di sostegno per non vedenti, prima con una scuola per bambini a Lhasa e poi con una fattoria per adulti vicino a Shigatse, dove sorge il monastero di Tashilhunpo, sede del Panchen Lama, perenne avversario del (e secondo i suoi seguaci addirittura superiore di grado al) Dalai Lama.
Un'impresa particolarmente delicata, quella affrontata da Sabriye Ternbeken, perché nella logica dei buddisti tibetani il non vedente pagherebbe con la sua condizione le conseguenze di un karma negativo, dovuto ai peccati della vita precedente. E di non vedenti ce ne sono tanti, a causa dell'avitaminosi, dell'alimentazione scadente, della luce sfolgorante e della grassa fuliggine sprigionata dallo sterco di yak usato come combustibile a causa della penuria se non addirittura assenza di legname. Così i ciechi, anche quando circondati da relativo affetto nell'ambiente famigliare, devono però essere protetti dal mondo esterno, che nella sua presunta non-violenza aggiunge molto alla punizione del karma. Se non sono tenuti prigionieri in casa, capita di vederli trascinarsi furtivamente nei mercati popolari alla ricerca di un po' di elemosina, e fanno veramente stringere il cuore.
La prima parte di questa sua appassionante vicenda (il complicato arrivo in Tibet e l'altrettanto complicata creazione della scuola di Lhasa, con relative depredazioni ma anche con straordinari gesti di liberalità) Sabryie l'aveva raccontata alcuni anni fa in La mia strada porta in Tibet. In Vedere con il cuore, invece, uscito in questi giorni, racconta l'evolversi dell'impresa in una vicenda davvero ai limiti del possibile: l'ascesa dei suoi ragazzini ciechi al Laghpa Ri, un 7000 metri di fianco all'Everest. Ascesa (credo non si debba parlare di vera e propria scalata) voluta e organizzata da una cineasta americana in collaborazione con il primo cieco arrivato in vetta all'Everest (un giovane americano, ma ogni 15 giorni circa si legge di una "prima" particolarissima sulla Vetta del Mondo, dello scalatore doppiamente amputato, di quello di età sempre più veneranda, di quello in elicottero, eccetera). Il fine dell'azzardata impresa dei ragazzini ciechi era un film, che è infatti stato distribuito in questi giorni nel mondo.
La realizzazione del film ha richiesto un intervento in diretta non soltanto dei responsabili della scuola (Sabriye, il suo compagno Paul e gli insegnanti locali) ma soprattutto dei giovani allievi, a cui è stato chiesto di raccontare davanti alla videocamera la loro storia. Storie toccanti, che nel libro sono riportate direttamente dalle registrazioni in voce. Addirittura straziante il racconto del più "difficile" dei ragazzini, che sembrava vivere in una sua privatissima monade di disperazione senza voler comunicare con nessuno. Davanti alla video camera invece si lascia andare e parla, raccontando una terribile vicenda personale di abbandono, addirittura di scambio, da parte del padre (cinese).
Raccolte le testimonianze necessarie, la spedizione si avvia verso la sua scalata, per un'impresa senza dubbio eccezionale ma non tale, tutto considerato, da non suscitare parecchi dubbi: i record "estremi" servono senz'altro a scatenare la ridda promozionale mediatica, ma in genere contribuiscono molto poco ad aiutare sul serio chi soffre di condizioni difficili. Per fortuna, però, nel corso del bel libro si arriva presto (e con sollievo) a capire che dai medesimi dubbi, e fortissimi, è attanagliata Sabriye: sa che ai suoi protetti quell'impresa, tra l'altro estranea allo spirito dei tibetani, non porterà praticamente niente, se non al più (fatto tuttavia da non trascurare) un supplemento di quei finanziamenti di cui la sua iniziativa è sempre famelica. Il film è stato realizzato, e i finanziamenti si spera siano arrivati, quindi è soltanto con sollievo che nel finale si legge della saggia rinuncia, una volta arrivati sui 6000 metri, tra ghiacci quasi da favola, a completare l'ascesa per non mettere a vero repentaglio le vite dei giovanissimi. Lungi dal diminuire l'interesse del libro, questa onesta rinuncia gli conferisce al contrario autentica emozione, derubricando la vicenda da un ambiguo "troppo umano" a una profonda, toccante e incontestabile umanità.
Sabriye Tenberken, “Vedere con il cuore”, Corbaccio