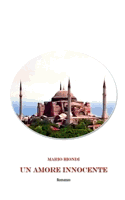Scrive di: Hugh Nissenson
1. Intervista: “L'albero della vita” (1987)
2. Recensione: “Le mie radici" (1993)
1. Intervista: “L'albero della vita” (1987)
2. Recensione: “Le mie radici" (1993)
© Mario Biondi
Divieto di riproduzione integrale
e obbligo di citazione (per cortesia...)
Hugh Nissenson sprizza entusiasmo e felicità. Americano, 54 anni, fino a qualche mese fa era un poco conosciuto autore destinato al ristretto pubblico dei palati raffinati di casa sua. Poi con il quinto libro, L'albero della vita, ha ottenuto un consenso unanime di critica e pubblico e diverse traduzioni all'estero: questo mese in Italia, dove il libro è stato pubblicato da Rizzoli (pagine 233, L. 20.000), per l'autunno in Francia e Danimarca. Trasuda alla lettera gratitudine per Esther Menascé dell'Università Statale di Milano, che definisce «il critico più attento e perspicuo della mia opera, da sempre», e per il cui interessamento è ora a Milano. Ci parli un po' di lei, signor Nissenson.
«Sono nato e vivo a New York. Sono ebreo di origine polacca. Sono sposato da ventiquattro anni - credo proprio di poter dire "felicemente" - e ho due figlie di sedici e dieci anni. Ho fatto molti mestieri. Ho tra l'altro tenuto - e terrò probabilmente ancora l'anno prossimo - corsi di "writing", di "scrittura" presso l'Università di Yale.»
Ce ne parli un po'. Chi sono i suoi allievi? Pensa che qualcuno di loro diventerà scrittore? Nel giro di pochissimo tempo in Italia sono stati pubblicati molti (forse troppi) esordienti americani. Tutti hanno seguito corsi di «scrittura» e tutti presentano un'impressionante standardizzazione di tematiche: i ricordi di famiglia e adolescenza, la mamma morta di cancro, la cocaina, lo spleen esistenziale. «Che devo dire? In tutte le epoche gli scrittori veramente grandi sono sempre stati in numero estremamente ridotto. Gli altri non fanno letteratura, ma semplici reportage sul loro mondo. I miei allievi sono giovani, matricole dell'università o studenti del secondo anno. Mio compito è insegnare loro ad apprezzare, a capire la letteratura, insegnare loro a leggere, e poi a formulare bene, con chiarezza, le loro frasi. Se diventeranno scrittori, non so. Tanto meno so se saranno grandi scrittori o semplici reporter. Ma io cerco soprattutto - e con molto impegno - di incoraggiare la loro immaginazione, la loro fantasia. Il vero scrittore è quello che sa immaginare un mondo suo.»
Bene. Adesso parliamo di lei e in particolare di questo suo romanzo, L'albero della vita. Un'opera singolare, finissima, che a prima vista appare il rozzo e semplice diario di un pioniere di 43 anni, Thomas Keene, che tra il 1811 e il 1812 vive in un minuscolo insediamento dell'Ohio, sulla frontiera indiana. Addirittura inizia con l'elenco dei beni posseduti dal suddetto Keene. Quasi una nota della spesa. Poi le cose si complicano, compaiono sapide e colorite notazioni di folclore e vita intima, erudite commistioni di storia e mito. Compaiono citazioni da Giovenale e Marziale, sapienti versetti biblici. E si capisce che Thomas Keene non è esattamente quello che appare, così come non lo è il testo di L'albero della vita. Piano piano le cose si complicano, con grande gusto e passione del lettore. Entra in ballo la mistica swedenborghiana nella figura di John Chapman, divenuto famoso nel folclore americano come Johnny Appleseed, ovvero Giovanni Semedimela, il quale vive ascoltando «voci» che negano l'esistenza della morte e piantando alberi di melo. L'albero, secondo la tradizione biblica, della conoscenza. L'albero, appunto, della vita. Vita e conoscenza che sono la negazione della morte, dell'intolleranza, della violenza tra uomo e uomo in cui sfocia il libro, che si fa apparente resoconto dei tempi della guerra americano-inglese del 1811/12, ma è in realtà un apologo sulla natura umana.
Nei suoi due precedenti libri di racconti - A Pile of Stones (1965) e In the Reign of Peace (1972) - e nel suo precedente romanzo - My Own Ground (1976) -, oltre che in quella sorta di reportage dalla frontiera israeliano-siriana che è Notes on the frontier (1968), lei si è cimentato soprattutto con le tematiche legate con il suo retaggio di ebreo originario dell'Europa orientale, cresciuto in America, frequente visitatore e buon conoscitore di Israele. Come mai questo drastico cambiamento di tematica? «Le ho già detto che per me l'immaginazione è l'elemento fondamentale della scrittura d'arte. E io ho obbedito ai suoi dettami. Che mi hanno imposto di indagare più a fondo da un lato la mia identità di americano, dall'altro la natura profondamente protestante della realtà americana, dall'altro ancora il senso della Bibbia, che è un testo fondamentale per la mia tradizione, ma anche per quella del protestantesimo.»
Infatti in L'albero della vita, come già nel racconto «Grace», viene citata dall'«Epistola ai Romani» (9, 15), un'affermazione di Dio che dice: «Uso misericordia a chi uso misericordia». Che cosa significa? «Il senso di grande mistero che circonda Dio. Pensi che è una citazione ripresa dall'Esodo e dunque un'affermazione che appartiene alla tradizione ebraica come a quella protestante come a quella cattolica. In definitiva la mia attività di scrittore è una continua ricerca del senso di me stesso e dell'universo. Una ricerca di Dio.»
Tutto ciò ricorda altri scrittori ebrei americani e in particolare il Premio Nobel Singer, che il primo volume della propria autobiografia lo ha intitolato proprio «In cerca di Dio». In che rapporto si pone lei con loro, ovvero con lo stesso Singer, con P. Roth, con Malamud e così via? «Sono grandissimi scrittori e hanno tutta la mia ammirazione. Ma io sto facendo una cosa completamente diversa, che mi lusingo di considerare del tutto nuova. Dal mio precedente romanzo, io - autore ebreo - ho deciso di indagare a fondo il mondo del protestantesimo americano. My Own Ground si svolge nel 1912, L'albero della vita cento anni prima. Quando me ne sono accorto, mi sono reso conto che avevo fatto un passo all'indietro, più a fondo, nella mia identità americana, ritmandolo inconsciamente su un secolo. E così il mio prossimo romanzo, che ho già iniziato, si svolgerà nel futuro, sulla suggestione della lettura di La guerra dei mondi di H.G. Wells, fatta quando avevo dodici anni. La storia come condizione del presente e del futuro è l'elemento fondamentale della mia poetica.»
Hugh Nissenson, L'albero della vita, Rizzoli (poi Garzanti)
(Il giornale, 19 marzo 1987)
II.
Che mondo meraviglioso e terribile doveva essere quello del Lower East Side ebraico di Manhattan nella prima parte del secolo. Più che l’inglese vi si parlava un colorito miscuglio di yiddish e lingue slave, vi si iniziavano a costruire immense ricchezze e vi si coltivavano confuse nostalgie di anarchismo, egualitarismo, comunismo. Vi si rimpiangeva la vecchia patria perduta — l’Europa dell’Est —, si temeva di perdere per sempre la lingua — lo yiddish —, ma al tempo stesso si anelava a una patria e a una lingua del tutto nuove. Si moriva di fatica nei tremendi sweatshop descritti in tanti libri populisti, per un salario da fame, senza alcuna garanzia del posto, alcuna protezione sociale. Eppure si nutrivano ardenti speranze. Quelle speranze nel nuovo che, pur nell’atavico fatalismo della sua fede (“ciò che sta scritto là dove nessuna mano può cancellare”), il popolo di madre Rachele non perde mai.
Raccolti attorno al “Vorwertz”, l’“Avanti” ebraico del vulcanico Abraham Cahan, intellettuali e scrittori si abbandonavano ad appassionate polemiche in cui si mescolava con furente passione ogni forma di ismo. Venivano in perigliosa visita i grandi della letteratura yiddish del “vecchio paese”. Si prefigurava l’arrivo dei due fratelli Singer, il poco noto e grande Israel Joshua, il lungamente trascurato e persino vilipeso ma finalmente rivelatosi grandissimo Isaac Bashevis. E giù giù, fino a Saul Bellow, Philip Roth, Chaim Potok, Harold Brodkey, tanto per citare soltanto qualche nome variamente emblematico. Si scriveva, si scriveva, si scriveva. E si recitava, si cantava, si amava spiritualmente e fisicamente, si litigava, si urlava. Si viveva, in due parole.
È il mondo in cui sono ambientati tanti racconti e romanzi di Isaac B. Singer (uno su tutti: Nemici. Una storia d’amore) e in cui Henry Roth fa svolgere il suo complesso Chiamalo sonno, romanzo che si può discutere, ma divenuto di culto. Ed è il mondo in cui il bravo Hugh Nissenson — schivo scrittore di poche opere e al tempo stesso pittore — ambienta il suo Le mie radici. Quali siano tali radici, è chiaro. La vecchia patria östjudisch, le tradizioni, la lingua yiddish. Nel fervido e livido Lower East Side del ’12 si compie l’iniziazione materiale, sentimentale ed erotica del quindicenne Jake Brody, arrivato da qualche anno dall’Ucraina.
La vicenda ruota attorno a lui e a una folla di personaggi. La trepidante figura di un rabbino ultraortodosso, la sua libidinosa figlia che si perde moralmente e fisicamente tra le braccia di un ruffiano, precipitando in un pozzo senza fondo da cui invano un confuso rivoluzionario marxista, anche lui da poco arrivato a New York per sfuggire alle repressioni seguite alla rivoluzione del 1905, cerca di riscattarla. E così via. Personaggi e ambienti raccontati con la bravura di un miniaturista, in una lingua popolaresca, colorita e al tempo stesso secca, completamente diversa da quella colta e raffinata dell’altro romanzo di Nissenson (L’albero della vita, pubblicato qualche anno fa e ora ripresentato in veste economica) e dei suoi non ancora tradotti racconti.
Buon conoscitore delle strutture narrative, Nissenson sa che lo stile non è un fatto asettico, sempre uguale, immobile, ma una cosa viva, sempre mutevole, imposta dal testo che si sta scrivendo e, non di rado, all’interno del medesimo testo, dal particolare personaggio dal cui punto di vista l’autore sta raccontando quello spezzone di vicenda. Unicità di punto di vista, uguale unicità di stile. Molteplicità di punti di vista, uguale molteplicità di stili. Facile dirlo, non altrettanto metterlo in essere sulla pagina. Nissenson ci riesce molto bene, con un esito narrativo di alta qualità.
Hugh Nissenson, Le mie radici, Garzanti (Corriere della sera, 25 ottobre 1993)
«Sono nato e vivo a New York. Sono ebreo di origine polacca. Sono sposato da ventiquattro anni - credo proprio di poter dire "felicemente" - e ho due figlie di sedici e dieci anni. Ho fatto molti mestieri. Ho tra l'altro tenuto - e terrò probabilmente ancora l'anno prossimo - corsi di "writing", di "scrittura" presso l'Università di Yale.»
Ce ne parli un po'. Chi sono i suoi allievi? Pensa che qualcuno di loro diventerà scrittore? Nel giro di pochissimo tempo in Italia sono stati pubblicati molti (forse troppi) esordienti americani. Tutti hanno seguito corsi di «scrittura» e tutti presentano un'impressionante standardizzazione di tematiche: i ricordi di famiglia e adolescenza, la mamma morta di cancro, la cocaina, lo spleen esistenziale. «Che devo dire? In tutte le epoche gli scrittori veramente grandi sono sempre stati in numero estremamente ridotto. Gli altri non fanno letteratura, ma semplici reportage sul loro mondo. I miei allievi sono giovani, matricole dell'università o studenti del secondo anno. Mio compito è insegnare loro ad apprezzare, a capire la letteratura, insegnare loro a leggere, e poi a formulare bene, con chiarezza, le loro frasi. Se diventeranno scrittori, non so. Tanto meno so se saranno grandi scrittori o semplici reporter. Ma io cerco soprattutto - e con molto impegno - di incoraggiare la loro immaginazione, la loro fantasia. Il vero scrittore è quello che sa immaginare un mondo suo.»
Bene. Adesso parliamo di lei e in particolare di questo suo romanzo, L'albero della vita. Un'opera singolare, finissima, che a prima vista appare il rozzo e semplice diario di un pioniere di 43 anni, Thomas Keene, che tra il 1811 e il 1812 vive in un minuscolo insediamento dell'Ohio, sulla frontiera indiana. Addirittura inizia con l'elenco dei beni posseduti dal suddetto Keene. Quasi una nota della spesa. Poi le cose si complicano, compaiono sapide e colorite notazioni di folclore e vita intima, erudite commistioni di storia e mito. Compaiono citazioni da Giovenale e Marziale, sapienti versetti biblici. E si capisce che Thomas Keene non è esattamente quello che appare, così come non lo è il testo di L'albero della vita. Piano piano le cose si complicano, con grande gusto e passione del lettore. Entra in ballo la mistica swedenborghiana nella figura di John Chapman, divenuto famoso nel folclore americano come Johnny Appleseed, ovvero Giovanni Semedimela, il quale vive ascoltando «voci» che negano l'esistenza della morte e piantando alberi di melo. L'albero, secondo la tradizione biblica, della conoscenza. L'albero, appunto, della vita. Vita e conoscenza che sono la negazione della morte, dell'intolleranza, della violenza tra uomo e uomo in cui sfocia il libro, che si fa apparente resoconto dei tempi della guerra americano-inglese del 1811/12, ma è in realtà un apologo sulla natura umana.
Nei suoi due precedenti libri di racconti - A Pile of Stones (1965) e In the Reign of Peace (1972) - e nel suo precedente romanzo - My Own Ground (1976) -, oltre che in quella sorta di reportage dalla frontiera israeliano-siriana che è Notes on the frontier (1968), lei si è cimentato soprattutto con le tematiche legate con il suo retaggio di ebreo originario dell'Europa orientale, cresciuto in America, frequente visitatore e buon conoscitore di Israele. Come mai questo drastico cambiamento di tematica? «Le ho già detto che per me l'immaginazione è l'elemento fondamentale della scrittura d'arte. E io ho obbedito ai suoi dettami. Che mi hanno imposto di indagare più a fondo da un lato la mia identità di americano, dall'altro la natura profondamente protestante della realtà americana, dall'altro ancora il senso della Bibbia, che è un testo fondamentale per la mia tradizione, ma anche per quella del protestantesimo.»
Infatti in L'albero della vita, come già nel racconto «Grace», viene citata dall'«Epistola ai Romani» (9, 15), un'affermazione di Dio che dice: «Uso misericordia a chi uso misericordia». Che cosa significa? «Il senso di grande mistero che circonda Dio. Pensi che è una citazione ripresa dall'Esodo e dunque un'affermazione che appartiene alla tradizione ebraica come a quella protestante come a quella cattolica. In definitiva la mia attività di scrittore è una continua ricerca del senso di me stesso e dell'universo. Una ricerca di Dio.»
Tutto ciò ricorda altri scrittori ebrei americani e in particolare il Premio Nobel Singer, che il primo volume della propria autobiografia lo ha intitolato proprio «In cerca di Dio». In che rapporto si pone lei con loro, ovvero con lo stesso Singer, con P. Roth, con Malamud e così via? «Sono grandissimi scrittori e hanno tutta la mia ammirazione. Ma io sto facendo una cosa completamente diversa, che mi lusingo di considerare del tutto nuova. Dal mio precedente romanzo, io - autore ebreo - ho deciso di indagare a fondo il mondo del protestantesimo americano. My Own Ground si svolge nel 1912, L'albero della vita cento anni prima. Quando me ne sono accorto, mi sono reso conto che avevo fatto un passo all'indietro, più a fondo, nella mia identità americana, ritmandolo inconsciamente su un secolo. E così il mio prossimo romanzo, che ho già iniziato, si svolgerà nel futuro, sulla suggestione della lettura di La guerra dei mondi di H.G. Wells, fatta quando avevo dodici anni. La storia come condizione del presente e del futuro è l'elemento fondamentale della mia poetica.»
Hugh Nissenson, L'albero della vita, Rizzoli (poi Garzanti)
(Il giornale, 19 marzo 1987)
II.
Che mondo meraviglioso e terribile doveva essere quello del Lower East Side ebraico di Manhattan nella prima parte del secolo. Più che l’inglese vi si parlava un colorito miscuglio di yiddish e lingue slave, vi si iniziavano a costruire immense ricchezze e vi si coltivavano confuse nostalgie di anarchismo, egualitarismo, comunismo. Vi si rimpiangeva la vecchia patria perduta — l’Europa dell’Est —, si temeva di perdere per sempre la lingua — lo yiddish —, ma al tempo stesso si anelava a una patria e a una lingua del tutto nuove. Si moriva di fatica nei tremendi sweatshop descritti in tanti libri populisti, per un salario da fame, senza alcuna garanzia del posto, alcuna protezione sociale. Eppure si nutrivano ardenti speranze. Quelle speranze nel nuovo che, pur nell’atavico fatalismo della sua fede (“ciò che sta scritto là dove nessuna mano può cancellare”), il popolo di madre Rachele non perde mai.
Raccolti attorno al “Vorwertz”, l’“Avanti” ebraico del vulcanico Abraham Cahan, intellettuali e scrittori si abbandonavano ad appassionate polemiche in cui si mescolava con furente passione ogni forma di ismo. Venivano in perigliosa visita i grandi della letteratura yiddish del “vecchio paese”. Si prefigurava l’arrivo dei due fratelli Singer, il poco noto e grande Israel Joshua, il lungamente trascurato e persino vilipeso ma finalmente rivelatosi grandissimo Isaac Bashevis. E giù giù, fino a Saul Bellow, Philip Roth, Chaim Potok, Harold Brodkey, tanto per citare soltanto qualche nome variamente emblematico. Si scriveva, si scriveva, si scriveva. E si recitava, si cantava, si amava spiritualmente e fisicamente, si litigava, si urlava. Si viveva, in due parole.
È il mondo in cui sono ambientati tanti racconti e romanzi di Isaac B. Singer (uno su tutti: Nemici. Una storia d’amore) e in cui Henry Roth fa svolgere il suo complesso Chiamalo sonno, romanzo che si può discutere, ma divenuto di culto. Ed è il mondo in cui il bravo Hugh Nissenson — schivo scrittore di poche opere e al tempo stesso pittore — ambienta il suo Le mie radici. Quali siano tali radici, è chiaro. La vecchia patria östjudisch, le tradizioni, la lingua yiddish. Nel fervido e livido Lower East Side del ’12 si compie l’iniziazione materiale, sentimentale ed erotica del quindicenne Jake Brody, arrivato da qualche anno dall’Ucraina.
La vicenda ruota attorno a lui e a una folla di personaggi. La trepidante figura di un rabbino ultraortodosso, la sua libidinosa figlia che si perde moralmente e fisicamente tra le braccia di un ruffiano, precipitando in un pozzo senza fondo da cui invano un confuso rivoluzionario marxista, anche lui da poco arrivato a New York per sfuggire alle repressioni seguite alla rivoluzione del 1905, cerca di riscattarla. E così via. Personaggi e ambienti raccontati con la bravura di un miniaturista, in una lingua popolaresca, colorita e al tempo stesso secca, completamente diversa da quella colta e raffinata dell’altro romanzo di Nissenson (L’albero della vita, pubblicato qualche anno fa e ora ripresentato in veste economica) e dei suoi non ancora tradotti racconti.
Buon conoscitore delle strutture narrative, Nissenson sa che lo stile non è un fatto asettico, sempre uguale, immobile, ma una cosa viva, sempre mutevole, imposta dal testo che si sta scrivendo e, non di rado, all’interno del medesimo testo, dal particolare personaggio dal cui punto di vista l’autore sta raccontando quello spezzone di vicenda. Unicità di punto di vista, uguale unicità di stile. Molteplicità di punti di vista, uguale molteplicità di stili. Facile dirlo, non altrettanto metterlo in essere sulla pagina. Nissenson ci riesce molto bene, con un esito narrativo di alta qualità.
Hugh Nissenson, Le mie radici, Garzanti (Corriere della sera, 25 ottobre 1993)