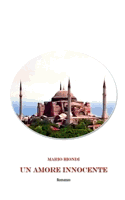Scrive di: Guido Morselli
Un dramma borghese (1978)
Un dramma borghese (1978)
© Mario Biondi
Divieto di riproduzione integrale
e obbligo di citazione (per cortesia...)
Sarà ancora il caso di domandarsi come mai gli editori italiani hanno lasciato morire inedito e suicida uno scrittore come Guido Morselli? Forse no, quello che è stato è stato, alle glorie postume siamo ben abituati nel nostro salottino letterario nazionale, però è una domanda che si fa proprio fatica ad archiviare dopo avere letto Un dramma borghese, che è il sesto libro di Guido Morselli. Sesto in ordine di pubblicazione, ma secondo (almeno a quanto ne so) in ordine di scrittura, essendo dei primi anni Sessanta.
Eppure me lo domando ancora: come hanno fatto a non rendersi conto, allora, che si trattava di un libro importante, scritto da un grande talento? Cosa diavolo girava a quei tempi nelle nostre auguste redazioni letterarie? Non lo so, non sono abbastanza informato, non mi ricordo abbastanza bene, ero troppo giovane. Ipotizzo: Morselli era troppo atipico, troppo sottile, troppo mitteleuropeo e tede-scheggiante per i gusti allora nettamente franco-americani dei nostri produttori di libri e quindi del nostro pubblico. Adesso, in tempi di revival del Danubio e dintorni, si recita il «nostra culpa» e nasce già persino un certo fastidiosissimo morsellismo dei poveretti.
Singolare esempio di scrittore centro-italiano affascinato fuori tempo dal mondo e dalla cultura centro-europei, Morselli ci dà, con questo Dramma borghese, un libro in cui si sente tutto l’odore (diciamo per riassumere) di Musil e Thomas Mann, un odore però mescolato intimamente ed emulsionato con una profonda «fisicità» e «carnalità» tutte italiane. Il mitteleuropeo Morselli non amava la mitteleuropea danubiana psicoanalisi, lo interessava, lo affascinava molto di più il «corpo» nelle sue manifestazioni anche minime, intime, sgradevoli. (Penso ancora alla Dissipatio H.G., che è appunto la scomparsa dei corpi di tutti gli uomini).
Cosi in questo Dramma borghese si racconta l'incontro e la breve convivenza di un padre di mezza età con una figlia adolescente, a lui quasi ignota, orfana della madre e cresciuta in collegio. Il tutto a Lugano o dintorni, in quella Svizzera che cosi spesso fa da sfondo alla narrazione morselliana, quasi una media tra la agognata Mitteleuropa e la Padania della realtà.
Breve convivenza in due stanze contigue dello stesso albergo — dove si sono rifugiati entrambi malazzati o convalescenti — che significa scoperta reciproca della propria esistenza «fisica» nell’aleggiare-incombere del «grande tabù», l’incesto. Con un singolare e dirò anche geniale ribaltamento di ruolo: a desiderare, quasi provocare l’incesto, a proporsi come «seduttore», non è come cronisticamente canonico il padre ma «scandalosamente» la figlia. Al padre tocca resistere. E resiste, più per spleen da convenzione che per convinzione, al prezzo della tragedia finale.
Un’ipotesi e un tentativo di incesto che non è spirito, non è psiche, è — ripeto ancora — «fisicità», scoperta del corpo, del suo esistere e funzionare, del suo attrarre altri corpi o respingerli. Su tutto aleggia il senso della malattia, non malattia del rapporto socialmente vietato, ma malattia vera e propria: termometri, medicine, supposte. Dietro ci sta almeno il sanatorio della Montagna incantata, la peste della Morte a Venezia, forse anche la Cura di Hermann Hesse. Non ci sono i «turbamenti». La ragazza non è sorella del giovane Törless, il padre non è Hans Castorps e nemmeno von Aschenbach. Ci sono i corpi che fanno agire e reagire.
In un’opera di grande qualità letteraria che passa con sapienza dall’importante al lieve, dal severo allo scherzoso, dall’ironico (che grande, sottile capacità di ironia!) al tragico, allo strazio disperato delle ultime pagine. Di un grande romanzo, certamente riuscito proprio neUa sua ambiguità, e purtroppo scoperto troppo tardi.
Guido Morselli, Un dramma borghese, Adelphi
Corriere d'Informazione, 10 giugno 1978
Eppure me lo domando ancora: come hanno fatto a non rendersi conto, allora, che si trattava di un libro importante, scritto da un grande talento? Cosa diavolo girava a quei tempi nelle nostre auguste redazioni letterarie? Non lo so, non sono abbastanza informato, non mi ricordo abbastanza bene, ero troppo giovane. Ipotizzo: Morselli era troppo atipico, troppo sottile, troppo mitteleuropeo e tede-scheggiante per i gusti allora nettamente franco-americani dei nostri produttori di libri e quindi del nostro pubblico. Adesso, in tempi di revival del Danubio e dintorni, si recita il «nostra culpa» e nasce già persino un certo fastidiosissimo morsellismo dei poveretti.
Singolare esempio di scrittore centro-italiano affascinato fuori tempo dal mondo e dalla cultura centro-europei, Morselli ci dà, con questo Dramma borghese, un libro in cui si sente tutto l’odore (diciamo per riassumere) di Musil e Thomas Mann, un odore però mescolato intimamente ed emulsionato con una profonda «fisicità» e «carnalità» tutte italiane. Il mitteleuropeo Morselli non amava la mitteleuropea danubiana psicoanalisi, lo interessava, lo affascinava molto di più il «corpo» nelle sue manifestazioni anche minime, intime, sgradevoli. (Penso ancora alla Dissipatio H.G., che è appunto la scomparsa dei corpi di tutti gli uomini).
Cosi in questo Dramma borghese si racconta l'incontro e la breve convivenza di un padre di mezza età con una figlia adolescente, a lui quasi ignota, orfana della madre e cresciuta in collegio. Il tutto a Lugano o dintorni, in quella Svizzera che cosi spesso fa da sfondo alla narrazione morselliana, quasi una media tra la agognata Mitteleuropa e la Padania della realtà.
Breve convivenza in due stanze contigue dello stesso albergo — dove si sono rifugiati entrambi malazzati o convalescenti — che significa scoperta reciproca della propria esistenza «fisica» nell’aleggiare-incombere del «grande tabù», l’incesto. Con un singolare e dirò anche geniale ribaltamento di ruolo: a desiderare, quasi provocare l’incesto, a proporsi come «seduttore», non è come cronisticamente canonico il padre ma «scandalosamente» la figlia. Al padre tocca resistere. E resiste, più per spleen da convenzione che per convinzione, al prezzo della tragedia finale.
Un’ipotesi e un tentativo di incesto che non è spirito, non è psiche, è — ripeto ancora — «fisicità», scoperta del corpo, del suo esistere e funzionare, del suo attrarre altri corpi o respingerli. Su tutto aleggia il senso della malattia, non malattia del rapporto socialmente vietato, ma malattia vera e propria: termometri, medicine, supposte. Dietro ci sta almeno il sanatorio della Montagna incantata, la peste della Morte a Venezia, forse anche la Cura di Hermann Hesse. Non ci sono i «turbamenti». La ragazza non è sorella del giovane Törless, il padre non è Hans Castorps e nemmeno von Aschenbach. Ci sono i corpi che fanno agire e reagire.
In un’opera di grande qualità letteraria che passa con sapienza dall’importante al lieve, dal severo allo scherzoso, dall’ironico (che grande, sottile capacità di ironia!) al tragico, allo strazio disperato delle ultime pagine. Di un grande romanzo, certamente riuscito proprio neUa sua ambiguità, e purtroppo scoperto troppo tardi.
Guido Morselli, Un dramma borghese, Adelphi
Corriere d'Informazione, 10 giugno 1978