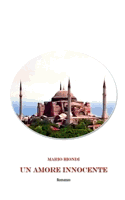Scrive di: Victor De Sabata
Profilo biografico di un grande musicista (1995)
Profilo biografico di un grande musicista (1995)
© Mario Biondi
Divieto di riproduzione integrale
e obbligo di citazione (per cortesia...)
Era una mattina di fine inverno del 1957, fredda, piovosa. Quale rilevante motivo poteva avere portato quel diciassettenne liceale tutto pelle e ossa ad affrontare le rotaie delle sempre vetuste Ferrovie Nord per trasferirsi a Milano da Como, dove lo aveva spinto la guerra e dove poi era rimasto con la famiglia? Visita ai parenti milanesi? A un museo? Alla Pinacoteca di Brera? Chissà. Comunque era lì, nelle sue scarpe perennemente troppo strette, nel suo striminzito montgomery beige, il cappuccio calato sugli occhi a protezione dal clima inclemente.
Quale che fosse il clima, gli piaceva immensamente abbandonare il pensiero a se stesso e vagare per la città dove era nato, che gli sembrava immensa, palpitante di vita e di possibilità di esperienza. Quasi a ogni angolo di strada, nonostante il freddo pungente e la fortissima umidità, aveva motivo di fermarsi per accostare l’occhio alla fessura di una staccionata che schermava un febbrile brulicare di attività. Milano stava sanando le ultime ferite della guerra e dandosi un nuovo assetto, rinasceva, animata da un inarrestabile slancio vitale e vitalizzante. Tanta gente per le strade, un’infinità di cose da scoprire, i tram, le vetrine, i teatri, i cinema, le librerie, le gallerie d’arte, l’università dove si sarebbe laureato e le altre di cui avrebbe timidamente battuto (incantato, in un tempestare di appunti febbricitanti sul taccuino) certe aule letterarie e filosofiche. Francesco Flora, Enzo Paci, Ludovico Geymonat...
Arrivò in prossimità di piazza della Scala. Era probabilmente la prima volta che la vedeva. La trovò quasi inaccessibile, zeppa anche nelle vie circostanti di migliaia di persone dall’espressione solenne, vestite di scuro, assiepate tutto attorno al teatro, da dove uscivano le note di una musica bellissima, che aveva sentito tante volte alla radio ma che mai sarebbe stato in grado di riconoscere. Naturalmente curioso — era nella beata età aperta a tutte le scoperte, pronta a sperimentare tutto — e rapito dall’incanto musicale (gli sembrava un evento straordinario: era la prima esecuzione dal vivo cui assistesse, e del tutto gratuitamente, per di più) si unì alla folla, si fece lentamente largo, arrivò in buona posizione. Proseguire oltre era assolutamente impossibile, quindi si fermò lì , in preda a un’emozione indicibile.
Terminata la musica, verso le dieci, dal teatro uscì un feretro, a cui si accodarono diversi carri coperti di corone e quasi tutti i presenti, formando un corteo interminabile. Il liceale comasco non si spostò; si accostò a uno dei capannelli rimasti a stazionare sulla piazza, tese gli orecchi, ascoltò in silenzio reverente. A poco a poco apprese che l’evento a cui aveva assistito era il funerale del maestro Arturo Toscanini, che il corteo avrebbe fatto un giro per la città, passando sotto la dimora milanese del defunto e spostandosi al Duomo e poi da lì al Cimitero Monumentale. La musica che tanto lo aveva commosso era la Marcia funebre dell’Eroica di Beethoven. Per dirigerla era «tornato» a Milano il maestro de Sabata, che da qualche anno non dirigeva più e di cui moltissimi — non proprio tutti — auspicavano il ritorno sul podio scaligero. Attentissimo, il liceale notò qualche nota stridente, qualche tono polemico, di cui però non poté capire il senso.
Il maestro de Sabata. La memoria del ragazzo fu attraversata da un lampo. La sua non era una casa particolarmente musicale. Avevano la radio. Niente di più. Nemmeno un disco. Soltanto nell’appartamento del nonno — che invece amava la musica classica, sia pure con distratto distacco —, c’erano un vetusto grammofono His Master’s Voice a manovella, ormai fuori uso, portato in Italia più di trent’anni prima al rientro da Londra (dove la famiglia del nonno aveva risieduto per molti decenni), e un imponente radiogrammofono (Phonola?) più recente, con due scomparti laterali pieni di vecchi 78 giri e di un solo cofanetto recente a 33 giri. (Una novità tecnica assoluta: un’intera opera su sole quattro facciate! Che diversità di suono, rispetto ai logori 78!) C’erano molte arie cantate da Caruso, da Beniamino Gigli e da Claudia Muzio. Un Barbiere di Siviglia. E la Tosca a 33 giri.
Alle festicciole del sabato tra ragazzi, a quei tempi, uno dei regali più in uso era solitamente un disco. A 78 giri o a 45. Due canzoni su due facciate. Frankie Laine. Elvis Presley. I Platters. La cultura musicale del ragazzo era tutta lì. Quando comperava un disco (per regalarlo), scendeva in casa del nonno e gli chiedeva di lasciarglielo ascoltare sul suo monumentale apparecchio "moderno". Il nonno scappava, si chiudeva nella stanza più lontana e lo lasciava fare. Il ragazzo li ascoltava senza stancarsene mai. L’idea che da quelle lastre nere, attraverso una puntina di ferro e un altoparlante nascosto dietro alcune strisce di legno e un pezzo di stoffa potessero uscire quegli straordinari suoni, lo incantava. Finito di ascoltare i "suoi" dischi destinati ad altri, ascoltava un po’ anche quelli del nonno che, sentendoli, ricompariva e si sedeva nella sua logora poltrona, perennemente accigliato, senza dire niente. Al ragazzo piacevano moltissimo le arie di Figaro, graffiatissime. Ma soprattutto Tosca. «Lola è fuggita», cantava a squarciagola, autentico pozzo di ignoranza, invece che «L’ora è fuggita». «Vissi d’arte, vissi d’amore.» Covava nell’animo confuse e inconfessabili speranze di un futuro tutto intriso di arte e di amore. Quelle poche parole gli sembravano un concentrato di tutto un senso della vita. Era la Tosca diretta dal maestro de Sabata. Che, come apprese in quell’occasione, non era dunque soltanto un astrazione meccanica, messa in atto dallo sfregare di una puntina su un impasto più o meno di ceralacca, ma una persona in carne e ossa.
Adesso, l’ex ragazzo che negli anni del liceo ascoltava quasi soltanto la musica da ballo americana e cantava a squarciagola «Lola è fuggita...» — coronati i confusi sogni di adolescente e divenuto per sua disgrazia scrittore —, ha le pareti di casa coperte di dischi. Migliaia. Sinfonie, concerti, sonate, cantate. Quasi mille opere liriche, di cui — "maniacalmente" ammalato di passione per la tecnologia — ha a poco a poco creato un catalogo computerizzato che — in nome della libera fruibilità dell’arte — ha messo a disposizione di tutti attraverso le reti telematiche. Mentre lavora, quando studia, quando riflette, quando riposa, l’atmosfera della sua casa è costantemente pervasa da note musicali. Sempre.
E adesso, all’ex ragazzo divenuto "maniaco" della musica viene chiesto di ricordare il maestro de Sabata. Inevitabile che gli torni alla memoria il giorno del funerale di Toscanini. La realtà fu quasi di sicuro diversa, ma i nomi dei due grandissimi maestri preferisce (preferisco) sempre ricordarli accomunati da quell’evento, dall’immensa maestria dell’arte, da una totale ribaltabilità di ruoli. "Apollineo", si dice del primo, e "dionisiaco", del secondo. Ma poi, a proposito dei famosi Requiem di Verdi diretti dall’uno e dell’altro, le cronache e le critiche non usano forse largamente l’aggettivo "fervore elettrizzante" per quelli di Toscanini e le espressioni "lento", "disteso", "equilibrio miracoloso" per quello in disco di de Sabata? Dunque? "Dionisiaco" o "apollineo"? Avremo qualche cosa da obiettare o perlomeno da precisare, a questo proposito, più avanti. Per adesso sfogliamo mentalmente il catalogo musicale elettronico, compilato con tanta cura dall’ex ragazzo, disco dopo disco, acquisto dopo acquisto, scegliamo dagli scaffali e ascoltiamo il troppo poco che, di de Sabata, ci rimane su disco o comunque in registrazione.
«All’idea di quel metallo/ Portentoso onnipossente/ Un vulcano la mia mente/ Già comincia a diventar», canta la voce poderosa ed elegante di Gino Bechi in una delle arie preferite dall’adolescente di Como (a cantarla, allora, su uno dei 78 giri del nonno, era probabilmente Riccardo Stracciari) e, tutto attorno, anche senza vederlo, si avverte vorticare lo scenario dell’Atto II Scena 4a di una celebre edizione scaligera del Barbiere di Siviglia (1952). La registrazione — dal vivo — risente dell’età e non è di sicuro delle più limpide ma, ugualmente, insieme alla voce, l’ascoltatore sente un autentico vulcano di musica. Lo stesso vulcano che si sente eruttare dagli altoparlanti — nel subisso di fruscii e raschi di una registrazione davvero avventurosa quanto preziosa —, mentre la voce squillante e giovanissima di Jussi Biörling canta — in svedese, nel ’36, accompagnato dall’Orchestra della Wiener Staatsoper — che se «quel guerrier» lui fosse... Una vampa di fuoco. Lo stesso fuoco da cui ci si sente avvolgere ascoltando un certo frammento dell’Otello, captato dal vivo l’anno prima sempre a Vienna, con la stessa orchestra e il Coro della Staatsoper che eseguono in tedesco "Feuer der freude", in un fremente palpitare di corde e legni. Che gioia! Che fuoco, nonostante la precarietà del suono captato con mezzi di fortuna in quegli anni lontani! Il fuoco che sapeva sempre infondere nell’esecuzione lui, uno dei più grandi direttori d’orchestra di tutti i tempi: Victor de Sabata.
"Infuocato", "estatico", "demoniaco", "incandescente", sono alcuni tra gli aggettivi che più di frequente si incontrano in volumi, testi, articoli, memorie che parlano di lui. Lo ha detto, qualche anno fa, durante un Festival di Lucerna, al giovanissimo Claudio Contini che lo intervistava intimidito in compagnia del fratello David, anche un anziano violista della London Philharmonic, arrivato alla sua ultima esecuzione. Richiesto di quale fosse il direttore che aveva esercitato su di lui la più forte impressione, rispose subito: «Sir Thomas Beecham». Naturale, il grande gentiluomo della musica, fondatore del complesso nel ’32. Con lui, spiegò, «l’orchestra diventava red hot»: rovente. «Ma soprattutto», aggiunse immediatamente, «Victor de Sabata.» Con lui l’orchestra diventava «white hot»: incandescente. Ma si proceda con ordine.
Victor de Sabata nacque a Trieste il 10 aprile 1892, figlio del friulano Amedeo — ingegno di molteplici interessi artistici (disegnatore, aspirante scultore, musicista) partito per il mondo a cercare fortuna come tanta gente della sua terra di confine — e di Rosita Tedeschi, triestina di origine ebraica. Singolare miscuglio di culture e sensibilità, che si dice abbia fatto sensazione e attirato fulmini dal cividalese. Cultura riflessiva, la prima, aspra come la sua lingua, temprata sulla rocciosità dei monti, sul silenzio delle valli, sul lavoro durissimo della campagna. Turbinosa la seconda: un «incandescente» — appunto — miscuglio di aromi italici e mitteleuropei, mediterranei e orientali: pannonici, greculi, turcheschi, di Sarmazia, di Siria, di Fenicia.
1892. Trieste. Da quale vivificante bora, da quale estenuante e irripetibile austro generatore di estri era sferzata? L’impiegato di banca Italo Svevo pubblicava Una vita. Antonio Smareglia stava componendo o perlomeno ideando Nozze istriane (1895). Umberto Saba, quasi decenne, iniziava l’apprendistato di sottile malinconia che di lì a un decennio avrebbe prodotto Il mio primo libro di poesia. Scipio Slataper aveva quattro anni. A pochi chilometri di distanza, Carlo Michelstaedter ne aveva soltanto uno di più...
È probabilmente proprio da questo miscuglio di malinconia ed energia creativa, di vibratilità e solidità, che discese, nel tempo, l’arte a due facce di Victor de Sabata: incandescente e al tempo stesso precisissima. Con l’aggiunta del senso squisitamente ebraico-orientale della lontananza forzata dalla heimat, dalla terra natale, e, quindi, dell’esigenza innata di essere di casa ovunque, di essere giocoforza spiriti internazionali. Quel senso che così bene il triestino Claudio Magris ha descritto in Lontano da dove. Felice (e malinconico) titolo che riprende poche righe fulminanti di Saint-Exupéry. Disse un ebreo a un altro: «Vai dunque laggiù? Come sarai lontano!» «Lontano da dove?», rispose l’altro. Da quale ubi consistam, da quale heimat? Victor de Sabata fu di casa ovunque, a Milano come a Montecarlo, a Roma come a Vienna, a Montecarlo come a Cincinnati. E si portò dietro un altro retaggio di natura "orientale": la superstizione, il senso arcano delle congiunzioni astrali. Nel ’27, mentre stava preparando la sua prima Norma a Montecarlo, sua madre morì. Non volle mai più dirigere l’opera.
A Milano ci arrivò a otto anni, al seguito di tutta la famiglia, in Via Canova. La riflessività friulana mescolata al senso triestino del mare ne aveva fatto un appassionato di navigli, un aspirante (e mancato) ingegnere navale che si portò dietro per tutta la vita (anche nel mestiere) questa ulteriore lontananza da un dove professionale mitizzato nella prima infanzia. Venne prestissimo iscritto al Conservatorio Giuseppe Verdi, spedito a studiare musica con Giacomo Orefice e Michele Saladino, che già alla fine del corso del 1904 attesterà: «Vittorio de Sabata, allievo del Regio Conservatorio..., è dotato di speciali attitudini musicali, sì da presagire bene per farne un degno artista». Mai presagio poteva essere più felice e lungimirante.
Nello studio del pianoforte rivela immediatamente doti molto fuori dal comune. Al terzo corso decide di affrontare il violino complementare. Nel 1904, a dodici anni, consegue la prima licenza, in teoria e solfeggio. Al saggio si presenta in qualità di compositore, pianista, direttore d’orchestra e violinista. Già è in grado di eseguire in pubblico un suo Andante e Scherzino per pianoforte, che l’anno seguente dirigerà, nella trascrizione per piccola orchestra, durante un saggio per piccoli allievi del Conservatorio. È la prima volta che dirige. L’evento, oltre che in qualche entusiastica noterella di stampa, arriva fino a noi attraverso una bella fotografia d’epoca. Compresi nella loro parte, impalati nel vestito buono, i tredici giovanissimi esecutori (nessuno aveva più di dodici anni) fissano con qualche apprensione l’obiettivo. Al centro, eleganti pantaloni alla zuava, sparato bianco, musicalissimo ciuffo sull’occhio sinistro, spartito bravamente stretto nella destra, il "maestrino".
Nel 1906 è promosso (con premio di 3deg. grado) da "armonia e contrappunto" a "contrappunto e fuga". Qualche giorno più tardi presenta una sua nuova composizione per pianoforte: Allegro - Barcarola - Giga. Sei giorni più tardi ottiene 8,50 in violino complementare e, subito dopo, 9,50 in pianoforte complementare. Ma il suo perfezionismo, la sua ostinazione friulana gli vietano di fermarsi a quei livelli. «Si accorda la licenza», scrivono i commissari d’esame, «ma [de Sabata] domanda di frequentare ancora la scuola.»
Studio, perfezionamento, massimi voti, esecuzioni, piccole (e non tanto piccole) composizioni si susseguono con ferrea determinazione, finché nel giugno del 1909 de Sabata dirige (per la prima volta a capo di una grande orchestra) una sua Ouverture in la maggiore. Nel maggio del 1910 arriva finalmente il diploma, con un voto impressionante: 9,65. Intanto ha composto una Suite per grande orchestra, che dirigerà nel gennaio 1911. Il grande Maestro si è già rivelato in nuce. Allo stesso 1911 risale forse il suo primo incontro con Toscanini, allorché suona il timpano nell’orchestra formata dagli allievi del Conservatorio e diretta dal maestrissimo nel decennale della morte di Verdi. Ben altri decennali del Grande di Busseto, de Sabata avrebbe poi avuto modo di celebrare con il suo lavoro di artista. Il quarto, a Roma, nel ’40, con un Requiem dal cast grandioso: Caniglia, Stignani, Gigli, Pasero. Il successo fu tale che i responsabili della manifestazione si spinsero fino a offrirgli una maggiorazione del compenso pattuito da 15.000 a 25.000 lire. Aristocratico e sdegnoso signore, lui declinò l’offerta. Il quinto, a Milano, nel ’51, con un ennesimo Requiem, in cui cantavano Tebaldi, Rankin, Prandelli, Rossi-Lemeni.
Nel 1917, alla Scala, direttore Panizza, viene creata la sua unica opera: Il macigno. E l’anno seguente, a ventisei anni, de Sabata diventa direttore d’orchestra stabile presso l’Opera di Montecarlo, dove il padre aveva già trovato stabile dimora in qualità di direttore dei cori. All’anno seguente risalgono le sue prime direzioni: Tosca, Falstaff, La rondine e La fanciulla del West. Scelte significative, profetiche. È probabilmente superfluo rammentare quanto questi quattro titoli abbiano significato per la sua carriera a venire. Ma rammentiamolo ugualmente. Contemporaneamente conclude la sua prima composizione importante, il poema sinfonico Juventus, che due anni più tardi inserirà nel primo concerto tenuto all’Accademia di Santa Cecilia insieme a brani strumentali di Flauto magico, Cigno di Tuonela, Psyché di Franck, Voci e ombre del vespero di Pick-Mangiagalli, Don Giovanni di Richard Strauss. Titoli significativi anch’essi di una grande versatilità, oltre che rivelatori dei suoi ascendenti come compositore. Nello stesso anno, a Montecarlo, dirige la prima esecuzione di Sadko per quel teatro e il Trittico pucciniano, con prima esecuzione francese di Gianni Schicchi.
A trent’anni, nel ’22, oltre a padroneggiare magistralmente l’amatissimo Puccini, ha già diretto un’autentica schiera di cantanti, tra cui spiccano i nomi di Beniamino Gigli, Mattia Battistini, Tito Schipa, Vanni Marcoux, Giacomo Lauri-Volpi, Gilda Rizza. L’anno dopo vi aggiungerà la divina Claudia Muzio, per un’Aida di cui si sognerebbe di poter sentire almeno qualche frammento (per non parlare della Tosca del ’24). A questa corolla di voci da mito andrà via via aggiungendo petali sempre ugualmente preziosi, se non persino di più: vengono in mente, frammentariamente, Pampanini, Thill, Björling e Nemeth, Flagstad e Lorenz, Caniglia, Stabile, e giù giù, fino ai Di Stefano e Callas, Siepi e Tebaldi degli ultimissimi anni (quanto presto arrivati, purtroppo!)
Nel ’25 dirige la prima assoluta di L’Enfant et les sortilèges di Maurice Ravel, con entusiastica gratitudine del compositore, che il giorno dopo gli scrive: «Vous m’avez donné une des joies les plus complètes de ma carrière...»; nel ’26 aggiunge alla propria corona di rose Boris e Rosenkavalier (anche in questi casi, proprio nessuno avrà conservato una sia pur minima traccia registrata?); nel ’27 dirige i primi concerti negli Stati Uniti e alla Scala, dove finalmente, nel febbraio del ’30, a trentotto anni, arriva come direttore d’opera dirigendo quello che è già un suo cavallo di battaglia, La fanciulla del West, con Gilda Rizza e Georges Thill, sue ormai vecchie conoscenze del palcoscenico di Montecarlo. Più una Dannazione di Faust sicuramente memorabile, con Merli, Galeffi e Baccaloni. Seguite a breve distanza dal suo primo celebre Tristano (tutto italiano, con Cobelli, Zanelli, Stignani, Rossi-Morelli).
Tristano e Isotta. Un’opera di cui Alberto Savinio ha scritto: «Aristotele pensava certamente a questa partitura così grondante amore quando inventò per la conclusione della tragedia la parola "catarsi". Da quando il violoncello attacca nel cuore del silenzio il sospiroso "la fa, mi" sul quale cade il gemito dei legni, tutto il fiume sonoro che nasce da quella sorgente entra in moto gonfio di speranza e assieme di disperazione e si avvia inesorabilmente alla sua foce, che è l’unione finale dei due amanti nell’amore e nella morte. Ora, a quest’ultima rappresentazione del Tristano io ho visto questo...». Difficile sapere chi ci fosse sul podio di quell’esecuzione (febbraio 1943) al Teatro dell’Opera di Roma, ma poco conta. Non doveva comunque essere de Sabata, sebbene proprio il 21 di quel mese avesse diretto a Santa Cecilia il "Preludio" e la "Morte di Isotta"... Ma quanto appartengono all’"infuocata" ideologia interpretativa desabatiana espressioni forti come "amore", "morte" (e l’unione dei due!), "tragedia", "catarsi". Quanta "purificazione". Non a caso, da quel lontano 1930, il Tristano era diventato uno dei suoi imprescindibili punti di riferimento.
Lo portò a Bayreuth, tra l’altro, nel ’39, primo italiano dopo Toscanini. Il risultato fu "sensazionale", come ha ricordato in un articolo sulla Bayerische Ostmark il critico Paul Bülow: «Quando l’italiano... si è messo al lavoro, sul podio, senza partitura, la prova è diventata davvero un avvenimento sensazionale nel miglior senso della parola. Dirigere a memoria non è ormai una rarità. Ma farlo come de Sabata..., avendo impressi tutti i particolari della partitura, è cosa al limite del leggendario... il pubblico avvertito, munito di partitura, constata l’assoluta esattezza delle correzioni [da lui segnalate agli strumentisti].» E Il General Intendant del Festspielhaus, Heinz Tietjen, gli dichiarò nel camerino: «Siete ormai legato a Bayreuth: non si può comprenderla senza di voi: voi siete dei nostri... Ditemi che cosa volete dirigere». A proposito di un altro Tristano, a Berlino, Sergiu Celibidache (da più parti indicato come uno dei più fedeli proseguitori artistici dell’ideologia musicale di de Sabata, della sua visione fenomenologica della singola esecuzione come evento irripetibile), ha dichiarato in un’intervista: «Ci nascondevamo nel gabinetto e restavamo lì tutta la notte, per poter sentire la prova del mattino dopo: senza luce, guardando la partitura con il fuoco dei fiammiferi. Che enorme impressione, ancora adesso se ci penso mi vengono i brividi».
Lo eseguì, acclamatissimo, il 14 aprile del ’48 alla Scala con un cast d’eccezione (Lorenz, Flagstad, Weber, Schöffler). Ne rimane, purtroppo (salvo errore), soltanto qualche frammento captato via radio, tra cui quello in cui l’immensa Kirsten canta «Mild und leise». Quanto "amore". Quanta "tragedia". E, nella musica, quanta "catarsi", quanta "purificazione". Peccato non averne una registrazione completa, che ci rimane invece dell’esecuzione del 13 dicembre ’51 con un altro cast straordinario: Lorenz, Grob Prandl, Sven Nilsson, Sigurd Björling, Cavelti. Ah, anni (almeno) musicalmente felici di quella che viene ricordata come l’Italietta, ma che forse sarà da riscoprire anche per altri aspetti.
Parlando di una di questi Tristani, Teodoro Celli, nelle primissime pagine del suo prezioso L’arte di Victor de Sabata ha scritto: «Quando uscii dal teatro... sotto il peso d’una delle più intense emozioni che la musica mi abbia mai procurato, capii confusamente d’aver "scoperto" Wagner... Ma capii anche... quanto, di quella rivelazione, io dovessi attribuire alle meravigliose qualità d’interprete di quel maestro...»
Nel frattempo, mentre preparava il suo primo Tristano alla Scala, il de Sabata compositore ha terminato di comporre il balletto Le mille e una notte. E la sua carriera di direttore prosegue. Nel ’31 avviene la famosa, clamorosa rottura con la Scala. Provocata, secondo Teodoro Celli, dal fatto che l’orchestra avrebbe preteso di suonare un certo passaggio come lo dirigeva il "maestro" Toscanini. Replicò gelidamente: «Quando dirigo, il maestro sono io». Posò la bacchetta sul leggio e se ne andò. Scrive invece il violinista Enrico Minetti nel suo Visita a de Sabata, pubblicato in almeno due fonti: «Il Maestro aveva portato a termine la preparazione della Manon di Massenet ed eravamo arrivati alla prova generale... proprio nell’introduzione dell’opera, causa un malinteso gesto del Maestro, metà dell’orchestra sbandò! Se vogliamo essere sinceri, l’errore non era nostro, infatti quando il gesto non è chiaro e metà massa sbaglia, il torto è della bacchetta. De Sabata, irritatissimo... proferì parole ingiuriose e ingiuste al nostro indirizzo e allora Gino Nastrucci, che nel 1931 era ancora violino di spalla, battendo l’archetto sul leggio protestò energicamente per le immeritate offese all’orchestra. Il Maestro, pallidissimo, disse una sola parola: "Preferisco!" e lasciò cadere la bacchetta. Poi scese dal podio e attraversò il "golfo mistico" per uscire... lasciò il teatro e la Manon passò a Panizza».
Due diverse rotture nello stesso anno? Sembrerebbe eccessivo. Due diverse versioni del medesimo evento, è più probabile. Che, pur nella loro diversità, lascerebbero trapelare come i rapporti tra i due grandi Maestri non fossero poi così idilliaci. Certamente non lo erano tra le due opposte e armate schiere dei loro seguaci e sostenitori. Paese inguaribilmente innamorato della ricerca di interminabili e bizantineggianti soluzioni di mediazione, proprio in quanto irrinunciabilmente capace di godere con sfrenata passione di veri o presunti dualismi — e quindi avido di crearne di sempre nuovi con sfrenata ansia —, l’Italia non poteva di sicuro rinunciare a tale sua intrinseca passionalità in un ambito dove la passione è regina: l’esecuzione musicale. Pertile o Lauri Volpi? Callas o Tebaldi? Del Monaco o Corelli? Abbado o Muti? E così via. Oltre che, naturalmente, Toscanini o de Sabata?
In più di un salotto di informatissime sofonisbe musicali si mormora ancora oggi che un giorno di oltre cinquant’anni or sono, ricevuti Walter Legge ed Elisabeth Schwarzkopf nella sua casa milanese di Via Durini, Toscanini avesse chiesto loro quale felice zefiro li avesse portati lì. Informato che si stava procedendo alla registrazione della Messa da Requiem di Verdi diretta da de Sabata — e su questo punto il mormorio si fa ancora più cauteloso e al tempo stesso concitato —, il maestrissimo sarebbe esploso in una serie di epiteti poco onorevoli per il collega ma, a onor del vero, anche per lui stesso. Non bastano, deve avere pensato — mettiamoci per un attimo nei suoi fragili panni di artista supremo, esposto a mille fremiti umorali —, le mie esecuzioni? Che cosa fate? Copiate? Di Stefano e Siepi non hanno già cantato con me non più tardi di tre anni fa?
Sarà un episodio vero o apocrifo? Chi lo racconta riferisce di averlo raccolto di persona dalle (evidentemente prodighe) labbra di Walter Legge. Lo si riferisce qui per amore di cronaca. Personalmente preferisco pensare ad altro. Guardare una emozionante foto dei due grandi Maestri colti insieme nella penombra della platea della Scala. Toscanini sta dicendo qualcosa, forse spiegando, con espressione intenta, e de Sabata ascolta, il viso atteggiato ad aristocratico rispetto, in nulla sottomesso. Le dita delle mani, incrociate sullo schienale della poltrona, mi piace pensare che stiano segnando il tempo del dire dell’interlocutore, onde penetrarlo a fondo, interpretarlo in tutte le sue pur minime sfumature, in tutte le sue implicazioni inespresse, come uno dei tanti brani musicali a cui dedicava la sua precisissima, "maniacale", cura esegetica.
Preferisco risalire con la memoria al fortunato (in un certo senso) evento di qualche anno più tardi: la fortuita presenza del liceale di Como al funerale di Toscanini "officiato" musicalmente da de Sabata. Quando era rimontato sul traballante treno della Nord, quel giorno di febbraio del 1957, il giovane aveva la mente piena di musica. Di musica non soltanto riprodotta tecnicamente ma "viva". Aveva avuto il suo primo incontro con uno dei massimi templi musicali: la Scala. Ne sarebbero seguiti chissà quanti, con tanto loggione e poi — in tempi meno magri — con molte onerosissime annate di abbonamento in platea, ma quell’anno e quel particolare episodio gli rimasero impressi nella memoria. Al punto che, oltre trent’anni più tardi, trovatosi a ideare un romanzo che parzialmente si svolgeva in quel 1957 e a creare un sfortunato personaggio milanese letteralmente arso da una bruciante passione musicale, pensò subito di inserirvelo. La precisa (quasi "maniacale", e l’aggettivo non viene impiegato a caso) collocazione storica di ambienti e personaggi era una delle caratteristiche salienti del suo lavoro di scrittore. Lo inserì dunque nella scaletta. Ma, arrivato al dunque, al momento di mettere su carta quello specifico sviluppo della vicenda, scoprì che le date non coincidevano. Doveva essere il 1957, sì, ma un po’ più in là nel tempo. Per sottili motivi strutturali doveva collocare l’episodio agli inizi di primavera.
Fu costretto a "ripiegare" su un altro memorabile evento musicale dell’epoca, a cui peraltro, segregato nella sua campagna comasca, non aveva potuto assistere e che quindi dovette ricostruire con ricerche bibliotecarie su testi e recensioni dell’epoca. L’indimenticabile Anna Bolena del 14 aprile, diretta da Gavazzeni, con Maria Callas, Nicola Rossi-Lemeni, Giulietta Simionato. Felicissimo ripiegamento, certo, a fare da cornice a uno sviluppo doloroso del suo romanzo (sia consentito di citarne il titolo: Il destino di un uomo). Ma come sarebbe piaciuto, all’ex liceale di Como divenuto scrittore, per introdurre la tragica fine del suo sfortunato eroe, per sottolinearne le cadenze di "amore" e "morte", servirsi dell’episodio "unificante" che portava stampato nella mente. Il funerale "reale" di Arturo Toscanini, celebrato musicalmente dal funerale "artistico" di Victor de Sabata.
Comunque, la realtà è realtà, anche per le cronache e per le riflessioni critiche: è del tutto credibile che i rapporti tra Toscanini e de Sabata non fossero per niente idilliaci. E quanti soffiavano sul fuoco. Ah, «perfidi sicari...». Allora, per noi, quaranta e passa anni più tardi: Toscanini o de Sabata? Apollineo" o "dionisiaco"? Dionisiaco, de Sabata lo era senza dubbio nel carattere, come abbiamo visto, nel temperamento. Come avrebbe potuto essere altrimenti, per un mezzo "orientale", sempre "lontano da dove"? Capace di amarissime malinconie e di furie terribili: «Ma se mi toccano dov’è il mio debole...». «Un sognatore e un turbolento», ha scritto di lui Fernando Previtali. «Come interprete si può dire che ha certamente creato un nuovo tipo di interpretazione, ricca di grandi contrasti, di sonorità smaglianti, di pianissimi impareggiabili, ottenuti anche con il suo gesto, espressivo in modo inequivocabile.»
Amara Scala! «Questa terribile Scala che lascia il segno a tutti», avrebbe esclamato addirittura Enrico Caruso, citato in un articolo di Teodoro Celli su Oggi. Quindi, secondo logica, al momento debito anche de Sabata avrebbe incontrato le sue difficoltà con il tempio musicale milanese. Ovvero, meglio, con certi suoi appassionati e cavillosi frequentatori e commentatori. Persone a cui sembrava (e sembra tuttora) obbligatorio giocare sul dualismo, rinfocolare sempre il confronto/scontro tra "dionisiaco" e "apollineo", tra de Sabata e Toscanini. Fino a rischiare che il primo lasciasse la Scala una seconda volta per stabilirsi oltre oceano. Teodoro Celli li ammoniva con vigore, questi Pelnellovo dell’ascolto, nel medesimo articolo: «Sono, costoro, i nostalgici. Ricordano i tempi di Toscanini e rimpiangono. Anche rimpiangere è un gusto come un altro: un po’ amaro ma evidentemente molto gradito a certi palati... Ebbene, noi preferiamo il gusto della speranza a quello sciocco del rimpianto... E siccome siamo convinti che, con la permanenza di de Sabata alla Scala per un lungo periodo, si possano concepire per il nostro teatro bellissime speranze..., vogliamo dire al maestro il nostro "grazie" per il suo proposito di rimanere nonostante tutto... Nonostante una pattuglia di sconsigliati stia facendo di tutto per indurlo ad andarsene, irritato, per sempre. Forse l’ideale di costoro sarebbe proprio questo: che anche de Sabata si stabilisse definitivamente al di là dell’oceano. Pensate che bazza per quei cari nostalgici: doppio motivo per rimpiangere: "Ah, quando c’era Toscanini! Ah, quando c’era de Sabata"». Nihil sub sole novi, come recitava l’Ecclesiaste già diversi millenni or sono (I, 9). Anche ai nostri giorni, certo loggionismo (e plateismo) degli stenterelli si bea di spargere lacrime postume di coccodrillo sulla scomparsa dai cartelloni della Scala di altri nomi, riparati in lidi meno procellosi proprio in quanto vittime dell’acredine dei medesimi stenterelli, di un atteggiamento che molto spesso non si può definire spirito critico ma è pura e semplice scarsa educazione. I nomi degli artisti restii a tornare a esibirsi alla Scala li sanno tutti.
Comunque, tornando ai dati della vicenda umana di Victor de Sabata, la rottura del 1931 durò poco: tornato alla Scala in novembre per preparare Fedora, venne accolto con entusiasmo, e il rapporto con il teatro, destinato a durare più di un ventennio — fino al 1953 e, in diversa forma, fino alla fine della vita del Maestro —, riprese. In quella Fedora cantavano Pertile e Stabile. Fu seguita da un ennesimo Tristano (anche questo tutto italiano), dall’Amore dei tre re di Montemezzi e da una Turandot con Maria Caniglia, da un Crepuscolo, da un Andrea Chénier con Gigli e Cigna. Prima di arrivare al fatidico 1953 si potrebbe andare avanti per pagine e pagine, tutte intrise dell’arte e della sapienza musicale di Victor de Sabata.
Più precisamente: la fatidica notte tra il 26 e il 27 settembre 1953. Già all’inizio dell’anno, in navigazione fra Le Havre e New York, si erano manifestate le prime avvisaglie di disturbi cardiaci. Ma la tournée americana si era conclusa felicemente, con concerti in California, in Canada e a Philadelphia. Erano seguite altre trasferte musicali, a Londra (con la già citata Philharmonic di Sir Thomas "Red Hot" Beecham), a Salisburgo. Altre direzioni alla Scala. La registrazione, in agosto, della più bella Tosca di tutti i tempi (con Giuseppe di Stefano a cantare per le pareti del carcere e per Maria Callas il «Lola è fuggita» del liceale di Como). Impresa grandiosa ma, evidentemente, troppo affaticante. Il 25 agosto, a Milano, de Sabata viene colto da una seconda crisi e deve rinunciare a un concerto al Festival di Lucerna. Un mese più tardi la crisi esplode, traumatica, irreversibile. La lesione al miocardio è gravissima, i medici non escludono che possano seguire ulteriori complicazioni; il maestro giunge all’amara decisione di non dirigere più. Tornerà sul podio soltanto nel 1954 per registrare il celebre Requiem di Verdi e nel 1957 per la sua ultima direzione: quella al funerale di Toscanini. Poi, per oltre dieci anni, il silenzio artistico, la malinconia dell’esilio a Santa Margherita, prima all’Hotel Lido, poi al Metropol, poi all’Eden e infine al Regina Elena.
In occasione del Requiem di studio disse di essere tornato a Milano «per dimostrare che sono vivo», ma per la prima volta non diresse in piedi: sul podio gli era stato preparato un sedile. Ne parlo con la figlia Eliana nella bella dimora di famiglia di Gavarno Vescovado, nel bergamasco, antica, traboccante di cimeli e cose belle, immersa nel verde e nel silenzio. Al piano di sopra, in un immenso granaio trasformato in studio, tra pareti tappezzate di partiture, testi e testimonianze musicali, il genero di de Sabata, Aldo Ceccato, sta laboriosamente studiando una partitura particolarmente complessa di Bartok, di cui è stato invitato a dirigere a Budapest le celebrazioni musicali del cinquantenario della morte. L’amore che legava padre e figlia non cessa di fluire dagli occhi nerissimi e brucianti di Eliana. Ricorda la dichiarazione del padre, ma ricorda anche che, finita la registrazione, salendo ancora una volta sul podio per le ultime incombenze, inciampò e rischiò di cadere. Il fiato dei i presenti rimase sospeso. Temettero tutti che l’infarto si fosse manifestato una seconda volta. Per fortuna non era così, il maestro si rialzò. Ma dal suo atteggiamento, dal suo sguardo, la figlia capì che era accaduto qualcosa di irreparabile. Lui, dominatore della partitura, dell’orchestra, dei cantanti e del pubblico, aveva rischiato di cadere, di mettere a repentaglio non tanto la propria salute quanto la propria dignità. E se davvero fosse successo che l’infarto lo colpisse durante un’esecuzione? Se fosse morto in pubblico, sotto lo sguardo di centinaia di persone, impossibilitato a tenere in qualsiasi modo sotto controllo la propria persona? Lo spirito scientifico gli imponeva di pensare a ciò che succede al corpo che cede in simili condizioni, alle scene assolutamente prive di dignità che si verificano. Lo pensò di sicuro, ipotizza oggi Eliana de Sabata Ceccato. No, meglio smettere, lasciare il ricordo della propria persona inflessibilmente eretta e "danzante" sul podio. Meglio far calare il sipario.
Pure, a dirigere il Requiem era tornato perché glielo imponeva un contratto appena stipulato con la Voce del padrone guidata da Walter Legge con pugno alato ma ferreo. Un contratto a cui la sua adamantina dirittura di friulano e mitteleuropea gli vietava di venire meno. Avrebbe, dopo Tosca, dovuto registrare quelle che sarebbero diventate la grande serie di opere realizzate dalla collaborazione della grande casa discografica con l’ente scaligero. Preferì rinunciare, anche se Legge insistette fino all’ultimo per proseguire nella collaborazione, fino al punto da chiedergli — in una lettera conservata dalla figlia — di pensare alla possibilità di comporre un nuovo finale per Turandot. Quali documenti di incalcolabile interesse potremmo avere, adesso, noi, arrivati tardi a conoscere e ammirare la sua arte! Invece no, decise che di questa sua arte doveva rimanere il ricordo di quando era nel pieno delle forze, non soggetto al rischio di mettere pubblicamente a repentaglio la dignità.
Di che cosa erano fatte, l’arte e la sapienza musicale di Victor de Sabata? Di vulcanico spirito dionisiaco, sicuramente. Di "mimica" interpretativa. De Sabata, ricorda chi ha avuto la fortuna di vederlo dirigere, "danzava" sul podio. Der Teufel am Pult, lo chiamavano scherzosamente gli strumentisti di lingua tedesca: "Il diavolo sul podio. Dirigeva con le mani — certo —, usando canonicamente la destra e la sinistra nei prescritti movimenti, ma anche con tutto il corpo, con la testa, con gli occhi. «Che sembravano volermi magnetizzare», ha ricordato Renata Tebaldi. Con una straordinaria presenza, dunque, ed energia fisica, frutto di passione musicale ma probabilmente, anche, di un surplus di carica energetica indotto da una sfortunata menomazione fisica. De Sabata era claudicante, come conseguenza della poliomielite contratta in tenera età. Chiunque abbia una qualsiasi menomazione, si sa, tende istintivamente a iper reagire per compensarla, e non è forse sbagliato pensare che l’iper mimica di de Sabata sul podio avesse in parte radici in questa iper reazione fisica istintiva alla menomazione. Ma anche radici ben più razionali e colte. Non era forse, il de Sabata compositore, nell’opinione comune, un wagneriano attraverso la mediazione straussiana? È quindi forse opportuno fare riferimento al concetto di "mimica" come delineato da Wagner nei suoi testi teorici. In scena e attorno alla scena, aveva scritto il grande tedesco, devono esserlo tutti, musicisti compresi. E più di tutti il maestro direttore, che per esprimersi ha a disposizione unicamente il gesto. Istinto e ragione, dunque, in un felicissimo impasto realizzativo.
Arte e sapienza, però, fatte anche di una mente squisitamente matematica, da quell’ingegnere navale mancato che de Sabata era, una mente che lo rendeva attentissimo anche alle questioni tecniche degli allestimenti teatrali, come ha ricordato Nicola Benois, suo collaboratore in tante imprese scaligere. «Aveva una passione, diciamo così, scientifico-meccanica», ha scritto il suo commosso erede Gianandrea Gavazzeni. E infatti appuntava lo stesso de Sabata nel 1930: «Un’orchestra concepita modernamente dovrebbe avere anche degli strumenti che costituissero una via di mezzo fra archi e fiati (legni). Oltre ai saxofoni, dunque, dovrebbe avere dei violini, viole e celli (1 , o 2 di ogni categoria) con una "campana" metallica o di legno uso saxofoni. Vedere se possibile farne costruire. Credo esistano già».
Ma aggiunge Gavazzeni: «Era un uomo estremamente complesso... una personalità di molti segreti interni, che nessuno riusciva a penetrare». Segreti di natura unicamente "dionisiaca"? Chissà. Qual è esattamente il discrimine tra "dionisiaco" e "apollineo"? Sarà mai possibile calcolare dove finisce il fuoco dell’istinto e dove comincia l’ordine della ragione? E come si mescolano nell’atto creativo? Di certo, è dal loro fortunato miscuglio che deriva il fascino della vera opera d’arte, nell’esecuzione come nella creazione: l’inquietudine dell’avventura in spazi inesplorati, nel disvelamento del nuovo. E questo è stata, fondamentalmente, la sapiente arte di Victor de Sabata, una sensazionale capacità di analisi sempre più profonda del testo musicale, un continuo, inquieto ma ragionatissimo procedere verso luoghi sempre più inesplorati della musica che era chiamato a dirigere e in molti casi a fare rinascere, verso nuove, emozionanti scoperte per se stesso, per gli esecutori che seguivano il suo comando musicale, per chi lo ascoltava.
D’altra parte, non era forse attraverso un dionisiaco turbinare di fumi, di emanazioni e sensazioni sconosciute, forse anche di sostanze dionisiacamente inebrianti, che nei templi di Apollo — a Delfi, a Didima, nei tanti altri meno imponenti e meno celebri —, pizie, pitonesse e sacerdoti rivelavano ai trepidi supplici l’apollineo volere del dio dell’ordine e della salute, della poesia, del canto e della cetra (secondo Omero), maestro delle arti e condottiero delle Muse — insomma di tutto ciò che è Bene e Bello —, interprete e disvelatore del volere del sommo Zeus? «Conosci te stesso», avevano fatto scrivere i Sette Saggi sul frontone del tempio di Delfi. Scopri, anzitutto, quello che hai dentro di te e fallo emergere, usalo come strumento di svelamento e spiegazione del mistero che ti assilla. Dopo di che potrai mettere a frutto la ragione così depurata e volgere il mistero a profitto tuo e altrui, creando il nuovo. Apollo più Dioniso, dunque. Dioniso più Apollo. Non sono in definitiva, Apollo e Dioniso, entrambi figli di Zeus — il primo generato nel ventre di Latona e il secondo di Semele —, frutti del suo sommo ma ondivago e ambivalente volere e dunque destinati a unirsi per disvelarlo come unicum? Così, almeno, ama pensare, e non soltanto per il lavoro di de Sabata, chi sta scrivendo qui.
«Victor de Sabata o del demoniaco, dicevano», ha scritto Giorgio Strehler, ricordando la comune triestinità e la passione per la navigazione. «Io direi: della grazia... o della completezza di una natura tutta musicale fino all’ultimo atomo e quindi capace di avvicinarci ai mondi più diversi e lontani.» Della grazia... o della completezza... Il lavoro di de Sabata, infatti, oltre che di fuoco istintuale, era intimamente fatto di "ragionamento". Di conoscenze tecniche vastissime, che gli consentivano di spiegare agli strumentisti esattamente il gesto tecnico necessario per ottenere un risultato. Riferiscono le cronache dei contemporanei che sapeva spiegarlo a pianisti e violinisti (strumenti in cui, come abbiamo visto, eccelleva fin dalla prima infanzia). Lo spiegò a un trombone, durante le prove di un L’enfant et les sortilèges, come ha ricordato Gianandrea Gavazzeni: voleva che lo strumento eseguisse una certa nota "in quarta posizione" e dimostrò come si doveva fare per ottenerla. Lo spiegò persino alle arpiste, durante una prova di Valchiria.
A Teodoro Celli spiegò come si deve imboccare il corno inglese per avere un certo effetto. E non aveva forse suonato addirittura il timpano, sotto la direzione nientemeno che del grande Maestro di cui era inconsapevolmente destinato a diventare l’antagonista, Toscanini? A Renata Tebaldi, colpita nella prima gioventù da un male che le rendeva a volte poco agevole muoversi sul palcoscenico, si dice che avesse anche cercato di insegnare come superare questo handicap: dallo stesso male (o da uno simile) era stato colpito anche lui, aveva imparato con inesorabile ostinazione friulana tutte le arti per attenuarne al massimo le conseguenze e vincerle. Aveva precisa coscienza, si sostiene, che il suono si propaga nell’aria secondo una certa formula matematica, e quindi che, stando sul podio, doveva sapere con assoluta precisione che cosa arrivava agli ascoltatori collocati nei diversi punti del teatro, e dirigere di conseguenza, esigendo questo o quello dai diversi settori dell’orchestra e dalle voci.
Un lavoro fatto, inoltre, di una memoria prodigiosa, quasi "maniacale" (come mi piace, questo brutto aggettivo, quando è riferito alla tecnica di lavoro di un servitore delle Muse), che gli consentiva non soltanto di memorizzare le partiture nota per nota (in una sola notte, a Londra, quelle di un difficile pezzo di Elgar), ma anche di correggere gli errori di stampa che si possono inevitabilmente riscontrare in qualsiasi edizione, anche la più accurata (e che persino l’autore può rischiare di non vedere!). Li correggeva e li faceva correggere sulle partiture dei suoi professori d’orchestra. Una memoria che gli consentiva, a decenni di distanza, di ricordare un errore commesso da un giovanissimo collega ai tempi dell’Orchestra del Conservatorio, come ha ricordato Michelangelo Abbado in una sua preziosa e divertita memoria.
«Accanto», scrive, riferendo un episodio dei suoi anni impuberi, «avevo un violinista più vecchio di me. Giunto al famoso passaggio» — di una Sinfonia di Haydn, se l’era coscienziosamente fatto spiegare dal maestro, Enrico Polo — «mi buttai sulla parte superiore. Altrettanto fece il mio vicino, che senza smettere di suonare mi ingiunse di fare la parte di sotto. "No, tocca a me la parte superiore, me l’ha detto il mio maestro". Così suonammo all’unisono l’intero passaggio e per quella mattina la parte inferiore dei secondi violini risultò più debole della superiore. Alla prova successiva il mio compagno di leggio venne chiamato a rinforzare i primi violini. Il giovane che prese il suo posto mi spiegò che Polo, abituato a fare da spalla, si era riferito ai primi violini.» Mentre i secondi dovevano comportarsi in maniera specularmente opposta. Insomma: «Il mio ex compagno di leggio aveva ragione!»
E chi era questo compagno di leggio? Continua Michelangelo Abbado: «Quattro o cinque anni or sono mio figlio Claudio andò a Santa Margherita Ligure... a visitare il grande direttore d’orchestra... Al momento del commiato [de Sabata] disse sorridendo a Claudio: "Mi saluti suo padre, che voleva fare la parte superiore, quando eravamo vicini nell’orchestra del Conservatorio"... Rimasi di stucco... Rividi accanto a me un giovane sui vent’anni, alto e smilzo, e la sua smorfia di commiserazione per la mia testardaggine. Chi avrebbe immaginato che era de Sabata? Lui invece aveva voluto sapere il nome di quel ragazzino ostinato, e con la sua prodigiosa memoria ricordava ancora l’episodio a distanza di oltre mezzo secolo.»
Tale era la memoria di Victor de Sabata. Di fronte a una così meticolosa ( e, ripetiamo pure, "maniacale") attenzione "tecnica" nei confronti dell’esecuzione e dei suoi risultati, è lecito continuare a parlare di "dionisiaco" in contrapposizione ad "apollineo"? Chi era il dio dell’Ordine e della Technè? L’arte è eminentemente struttura. L’anelito a raggiungere un certo risultato impone inesorabilmente al creatore e all’esecutore l’impiego di un certo linguaggio e soltanto di quello, di certe tecniche e non di altre. L’opera d’arte è un unicum irripetibile, per quanto interpretabile. Non a caso de Sabata usava dire ai suoi collaboratori,: «Signori, lasciatemi plasmare la musica», come ha ricordato Mario Dorizzotti, percussionista dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia. Plasmarla secondo quanto gli dettava la sua cultura, musicale e complessiva, una cultura che, come ha ricordato Carlo Maria Giulini, «spaziava in campi molto vasti: egli cercava rapporti fra fatti matematici, scientifici e addirittura astrali con il mondo dei suoni». Rapporti astrali, sicuramente dettati e imposti dalla componente "orientale" — "superstiziosa" — della sua personalità.
Come "orientale" — e, questa sì, senza dubbio "dionisiaca" — era la sua passionalità umana, la capacità di ridere, di inventare fulminanti battute di spirito. «Ti pettini che sembri Gino Marinuzzi», disse una volta alla figlia Eliana, comparsagli davanti all’improvviso con un taglio modernissimo. E in un’altra occasione, sempre in argomento "capelli", in risposta alla famiglia che lo incitava scherzosamente a provvedere in qualche modo alla sua calvizie, dopo avere replicato diverse volte con sdegno che mai e poi mai si sarebbe abbassato a indossare una parrucca, sbottò: «Be’, potrei farmi fare un tatuaggio trompe-l’oeil su tutto il cranio!»
Ma altrettanto "orientale" — e ben più amaramente "dionisiaca" — era la sua capacità di soffrire la malinconia. «Quali saranno state le sue serate a Santa Margherita?» si è chiesto uno dei suoi eredi artistici, Gianandrea Gavazzeni, in una commossa memoria. Santa Margherita, già, l’esilio forzato, dopo l’infarto del 1953, durante le prove della Wally di apertura della Scala. Una carriera troncata un istante prima dell’apice. Aveva sessantuno anni. Quanto avrebbe potuto darci, ancora? Fu «colpito in volo», come ha detto con espressione ispirata un altro dei suoi eredi, Carlo Maria Giulini, chiamato in tutta fretta a sostituirlo. A sostituirlo per Medea venne invece chiamato un altro "dionisiaco" per eccellenza, Leonard Bernstein, il «carissimo Lenny» di tante lettere. Preparò l’opera in sei giorni, facendo tesoro — ha ricordato lo stesso Bernstein — della preziosa e affettuosa assistenza del Maestro malato. Ne venne un’edizione memorabile (con Callas, Barbieri, Modesti), che per fortuna la registrazione dal vivo ci ha tramandato. Così come memorabile fu l’esecuzione della Sonnambula del ’55 (con Callas, Valletti, Modesti), anch’essa per fortuna ascoltabile in disco dal vivo. Per Bohème, Bernstein venne addirittura assistito dalle quinte. Esecuzioni memorabili, certo, ma che cosa avrebbero potuto essere se guidate dalla bacchetta fulminante, dal gesto "danzante" ma "inequivocabile" di de Sabata, dalla sua memoria infallibile, dalla sua coazione alla massima precisione tecnica? Quali "fortissimi" avremmo avuto. Quali "pianissimi"?
Il "se", in questi casi, non ha purtroppo senso. Non lo sapremo mai. Il Maestro viveva il suo esilio di Santa Margherita. E di quale intensità potesse essere la sua malinconia, la nostalgia del gusto, del fuoco, dei colori, degli umori, degli afrori del teatro, il suo invincibile e irreversibile tedium vitae, possiamo trarre un’idea dalle espressioni di una ben nota lettera inviata al figlio Elio in data 18 luglio 1961, in cui invocava il suo aiuto per comperare un’automobile con cambio automatico, che gli consentisse una maggiore mobilità, lo aiutasse a togliersi almeno un poco dall’impasse vitale in cui era precipitato. Espressioni apparentemente banali, ma quanto rivelatorie: «...non è un po’ pietoso, il mio stato? Tutti sono motorizzati, tutti hanno due gambe, tutti possono spostarsi a piacimento. Io, che mi sono guadagnato la vita per me e per voi in piedi, sudando per più di 40 anni, col cuore che mi scoppiava davanti a milioni di persone, devo camminare stentatamente...». Si sentiva "scoppiare il cuore" — e infatti così sarebbe avvenuto, uno sfortunato giorno di massacrante lavoro —, mentre i critici impietosi ritenevano che "si esibisse" a galeotto beneficio della platea più borghesemente epatabile, per poi chiudersi in un silenzio altezzoso e impenetrabile da sdegnoso primo della classe.
Quanta amarezza traspare dall’apparente scherzosità della seguente "intervista" fatta da de Sabata a se stesso durante l’esilio: «Non do interviste, ma non sono un cattivaccio con i giornalisti. Li rispetto, anzi, rispetto il loro lavoro, la loro vita quotidiana affannosa, spesso competitiva, spesso incompresa, e ho una grande voglia che si distrugga una leggenda... Posso chiedervi un gesto di cordialità? Una testimonianza di calore umano? Cercate di cancellare la leggenda che io rifugga con alterigia, che io non mi degni di lasciarmi intervistare...». E conclude: «Ogni intervista mi ha lasciato sempre amaro». Chissà se, dall’Olimpo della Musica, dagli appartamenti di Euterpe, dove sicuramente è stato accolto, può leggere o sentire (e vedere!) e immalinconirsi di certe interviste di oggi a tanti suoi colleghi servitori delle più disparate Muse.
Ma un’idea ben più dolorosa del suo perenne, invincibile spleen possiamo trarre da una serie di lettere privatissime, inedite ma fortunatamente recuperate da Marco Contini, da lui scritte a Umberto Giordano, cui era legato da un profondo legame di amicizia e aperta confidenza. Non appartengono a quel periodo, sono molto precedenti, risalgono agli anni Trenta e soprattutto Quaranta. In quei giorni il Maestro aveva accanto a sé un nuovo affetto, segretissimo — indicato prima soltanto con un tenero nomignolo e poi scopertamente con il nome (in questa sede non pare opportuno ricordarlo: si sta parlando della vita artistica di un uomo, non di quella privata) —, eppure del tutto insufficiente a placare l’amarezza del "mestiere di vivere" che da quelle lettere promana, facendone un grimaldello prezioso per cercare di penetrare i «molti segreti interni» di quel carattere «turbolento» e malinconico. Anzitutto, per tanti piccolissimi accenni (compaiono in quasi ogni lettera), alle pastoie imposte a questo carattere dalla fisicità.
La "fisicità". Abbiamo visto quanto fosse importante per determinare il "gesto" particolarissimo del maestro, la sua "danza sul podio", gli elementi di magnetismo che sapeva trasmettere all’orchestra, ai cantanti e al pubblico. Ma fu importante anche in negativo. Si rammenti che de Sabata fu «colpito in volo» due volte. La seconda con l’infarto del 1953, che portò all’esilio di Santa Margherita. La prima quando aveva, bambino, contratto la poliomielite. Scriveva il 23 ottobre 1947, appunto a Umberto Giordano, da Roma: «Io non sto ancora bene. Ho dovuto buttare all’aria mezza Europa causa questa nevralgia alla gamba che mi ha costretto a rompere una quantità di impegni. Ne sono spaventato. Una banale indisposizione che, oggi, provoca tali guai per me (e non solo per me) è cosa mortificante e che mi mette in uno stato di ribellione non certo propizio per i miei nervi. Questo rimanga fra noi.»
E già gli aveva scritto il 18 gennaio 1944: «Giorni di depressione, per me, dalla tua cara ultima; quei giorni che anche tu mi dici di provare, a volte dove si ha perfino riguardo di far udire la propria voce e la propria melanconia anche alle persone che ci sono più care... E, melanconicamente, si giunge al solito risultato: lasciar operare le circostanze... Io non sto tanto bene... un malessere generale che mi deprime molto... Tutto incerto, tutto difficile...». E un 31 dicembre di un anno imprecisato: «Mai nervi d’uomo (e quali nervi sono i nostri!) sono stati messi a prova più impegnativa!... Qui, per noi, giorni balordi e grigi...».
Ma soprattutto, il 7 novembre 1948, da Pittsburgh: «Mi ricordo sempre la descrizione tua di uno dei tuoi incontri con Verdi! "Le mie gambe!" A parte ogni irriverente accostamento, le mie, dopo quella nevralgia dell’anno scorso, sono continuamente messe, proprio per il mio bel mestiere, alle prove più incredibili! Ci sarebbe da ridere, per questo mio destino grottesco, se non ci fosse da piangere. E avanti!» Già: "the show must go on", costi quel che costi. De Sabata non poteva sapere — oppure, da "orientale" attento al senso arcano degli eventi, presagiva? — quale prova ben più fatale gli riservasse il destino "grottesco".
Ma quanto bastavano le contrarietà di natura fisica ad avvelenargli la vita. Diceva ancora la stessa lettera: «Ti scrivo dal mio letto, in una di quelle notti che l’insonnia ti rende roventi e i pensieri sono torturati da mille domande senza risposta e da ribellioni di cui l’anima si vergogna! Anch’io, credimi, sto lottando contro mille diavoli! Le forze che mi abbandonano, difficoltà di ogni genere, dolorosa apatia che toglie ad ogni mio sacrificio, ad ogni mio sforzo ogni interesse ed ogni compenso nell’averlo compiuto!... E gli anni passano, e che cosa ho veramente concluso, gli applausi?» Come gli pesava, evidentemente, il cruccio del suo lavoro di compositore, messo in second’ordine e poi praticamente abbandonato, per motivi di cui si può soltanto tentare di abbozzare una spiegazione, forzatamente psicologistica, lasciando ad altri, di superiore cultura musicale, di valutarne esiti e limiti.
De Sabata fu accusato di passatismo. Era vero? È un’accusa che colpisce spesso chi, nella sua attività creativa, si rifiuta di prescindere da un rigoroso bagaglio di preparazione tecnica. È un imperativo di natura anzitutto morale. Prima di "fare" bisogna "saper fare". Allo stesso titolo, oggi, capita che venga tacciato di passatismo chi sia fermamente convinto che, per scrivere, è un dovere imprescindibile la conoscenza se non altro di consecutio, condizionali, congiuntivi e punteggiatura. Pazienza. De Sabata si ribellava con forza al giudizio, citando le diverse creazioni o esecuzioni montecarline, la prima esecuzione della Sinfonia di Pizzetti, l’amicizia e il sostegno dato a giovani colleghi (Ghedini, Clausetti). Si pensi al suo repertorio di direttore. I grandi classici, certo. Beethoven, Brahms, Schumann; Rossini e Verdi (ma quale fu la sua "restaurazione" del Macbeth: per fortuna abbiamo la registrazione live a ricordarcene tutta la modernità; la qualità del suono è scarsa, ma che cosa importa? Il fuoco dell’esecuzione in teatro, Maria Callas al vertice della voce, i comprimari guidati con mano sapientissima ne fanno tuttora una delle edizioni di referenza).
Ma anche tanto Berlioz e Wagner (i suoi Tristani!). E Richard Strauss (ma, certo, a quei tempi si sosteneva da più parti che anche Strauss era un passatista ampolloso e pompiere). E un Puccini svelato nelle sue misconosciute raffinatezze (La rondine — da lui affrontata prestissimo e segnalata tra le partiture più preziose del compositore lucchese —, Il tabarro, tanto inviso a Toscanini). E Ravel, e Debussy, e Strawinski, e Kodàly, e giù e giù... Eppure, sebbene brillantemente diplomato in "composizione", oltre ai piccoli lavori di apprendistato, compose soltanto un’opera (Il macigno, 1917); tre poemi sinfonici (Juventus, 1919, La notte di Platon, 1924 e Gethsemani, 1925); un balletto (Mille e una notte, 1931) e le musiche di scena per una duplice esecuzione per la Biennale veneziana del Mercante di Venezia (1934-35). Poi il silenzio, anche negli anni dell’esilio dal podio. Come mai? In questa sede si può abbozzare soltanto una spiegazione, ripeto, di natura psicologistica. L’artista-artigiano (l’esecutore, il traduttore) che dedica con scrupolosa cura gran parte del suo tempo creativo alla riproduzione dell’arte di altri, rischia di affondare nell’esegesi del linguaggio di questi creatori e delle loro problematiche strutturali al punto da trascurare e perdere di vista i propri, e con essi il proprio slancio vitale, condannandosi al timore reverenziale, al silenzio creativo, alla depressione, alla malinconia.
Fu in preda a queste e altre malinconie di natura fisica ed esistenziale che il maestro visse gli ultimi quattordici anni della sua vita in forzato esilio, pur tra grandi progetti e arditi slanci di speranza. Aveva promesso a Franco Abbiati che sarebbe tornato alla Scala per un altro Tristano, per il quale sperava di avere la Nilsson. Voleva dirigere la Carmen, ma non riuscì nell’impresa. Che cosa ci avrebbe dato, con il suo magnetismo infuocato? A chi scrive qui viene in mente, per comparazione, lo splendido retaggio lasciatoci da un altro grande signore della musica, già più volte citato in precedenza a confronto con il Nostro: Sir Thomas Beecham. Se con lui l’orchestra diventava "infuocata" e con de Sabata "incandescente", che Carmen avremmo avuto, ad arricchire la purtroppo esile eredità di registrazioni del Nostro? E che cosa potremmo capire in più, da una registrazione cinematografica, del suo famoso "gesto", della sua "danza" sul podio, noi che non abbiamo potuto vederlo dirigere? Non ce ne sono, passiamo soltanto immaginarlo. Abbiamo soltanto molte fotografie, che, per quanto sembrino vibrare di movimento ed emozione, sono purtroppo immobili.
A noi, ammiratori postumi, rimane soltanto da immaginare che cosa avremmo potuto avere da un suo Parsifal, opera di cui, salvo errore, diresse soltanto "L’incantesimo del Venerdì Santo" e qualche altro brano in concerto. E di quali documenti straordinari disporremmo se la pur povera tecnica del tempo fosse riuscita a captare uno dei suoi Cavaliere della rosa. O un Boris. E se avessimo un suo Ring, o anche soltanto una testimonianza registrata delle parti da lui dirette (Valchiria — quella dell’aprile 1949 alla Scala, per esempio, con Lorenz, List, Franz, Reining, Flagstad, Roengen...) — e Crepuscolo)... E ancora un po’ di Rossini (Cenerentola, Gazza ladra), oltre allo sfolgorante Barbiere... O un’edizione completa della Bohème e dello Chénier del ’49, di cui ci rimane soltanto qualche frammento... E si perdoni il riferimento quasi esclusivo all’opera: ciascuno ha la sua "passion predominante". Ma quale emozione, quante scoperte si fanno ascoltando le Sinfonie di Beethoven dirette da de Sabata, o la Quarta di Brahms, o i pochi pezzi di Ravel e Debussy che ci sono rimasti...
Si pensi, inoltre, che cosa ci avrebbe potuto regalare un proseguimento del rapporto così felicemente iniziato con il connubio artistico Maria Callas - Giuseppe Di Stefano, oltre alla tuttora insuperata Tosca del `53: «.... the most thrilling recorded performace of any opera I have heard. Che maestria, sensibilità, passione...», gli scriveva al proposito ancora nel 1961 Leonard Bernstein. A che cosa avrebbe potuto darci, con lui — in un elettrizzante connubio di tragiche sensibilità "greculo-orientali" —, la grande Maria, oltre al livido, angoscioso ma vibrante Macbeth captato dal vivo all’apertura della stagione scaligera 1952-53.
Dal vivo, dal vivo, dal vivo. Per fortuna esistono almeno queste registrazioni, e la pertinacia collezionistica di chi le ha raccolte e conservate. Le testimonianze desabatiane da studio sono infatti molto poco. Una sinfonia di Beethoven. Due brani dei Nocturnes di Debussy. La Tosca. Il Requiem. Un po’ di brani orchestrali. Nient’altro, salvo errore. Un bagaglio ben misero, se rapportato a un trentennio di attività direttoriale. Anche qui, come mai? Il peso del continuo correre di teatro in teatro, si può ipotizzare. La fenomenologica convinzione dell’unicità e irripetibilità dell’evento musicale: «Il direttore ha nella sua bacchetta la sua misura», ha dichiarato in un’intervista a Leonida Repaci, «la sua idea dell’opera, di quegli elementi che si chiamano melos; ma... egli non può ripeterle meccanicamente... perché stasera non è quello di ieri sera ed è diverso il suo cuore come sono diversi gli spiriti e i cuori di tutti i componenti del complesso orchestrale... Egli deve, ogni sera, trovare quella tal cosa che sta tra le righe della partitura...»
E, soprattutto, uno sdegnoso senso di autocritica, di scarsa sicurezza — data la "mania" perfezionista — circa i risultati tecnici ottenibili dovendo tenere conto di tanti fattori limitativi. Soprattutto, e certamente non ultime, delle limitazioni "commerciali", "editoriali" e "di immagine" che vengono inevitabilmente imposte dalle case editrici musicali. Quante critiche ricevette de Sabata — più o meno velate, più o meno maliziose — per avere usato, nel famoso Requiem discografico, la voce di Elisabeth Schwarzkopf. Una voce così leggera, di educazione tedesca... Non lo aveva per caso fatto perché nel frattempo Elisabeth era diventata la signora Legge, la moglie del deus ex machina della EMI, casa editrice del disco? Sì, certo, una scelta che si può discutere, ma i critici superficiali dimenticavano — «La calunnia è un venticello...» — che de Sabata aveva già impiegato la Schwarzkopf nel ’51, in un’esecuzione pubblica del Requiem a Venezia, nell’ambito delle celebrazioni del cinquantenario verdiano. Ma sono abbozzi di spiegazione vaghi quanto insufficienti. Forse, se non fosse intervenuto il tragico "colpo in volo" del 1953... Chi può sapere? Certo avremmo di più. I grandissimi anni Cinquanta della Scala (anche discograficamente parlando) erano lì lì per fiorire, da lui preparati, da lui seguiti con amorosa cura nella veste effettiva di Sovrintendente Artistico (e poi in quella puramente onorifica — e gratuita — di Alto Consulente Artistico). Ma de Sabata era chiuso nel suo amaro esilio professionale ed esistenziale di Santa Margherita.
La notte tra il 10 e l’11 dicembre 1967 il suo cuore cedette di schianto un’altra volta e per sempre. La sua vicenda umana si concluse così, all’età di settantacinque anni. Pure, oltre alle testimonianze musicali, di lui rimase qualcos’altro. Qualcosa della sua persona, del suo corpo, proprio di quella "fisicità" — vedi caso — che tanto lo aveva condizionato e assillato, di quegli occhi che tanto avevano "magnetizzato" Renata Tebaldi. In punto di morte — spinto da che cosa, se non dal suo spirito "scientifico"? — aveva disposto che le sue cornee venissero donate. Per il loro tramite, una donna di Ovada, progressivamente condannata alla cecità, poté tornare a vedere bene. Quello stesso spirito scientifico aveva fatto sperare fino all’ultimo a Victor de Sabata di potersi giovare dell’imminente era dei trapianti di cuore. Ci credeva con assoluta fiducia. Non fece in tempo per pochi giorni. Il 3 di quello stesso mese il sudafricano Christiaan Barnard aveva proceduto al primo trapianto. Il momento tanto atteso sembrava arrivato. Invece, soltanto una settimana più tardi, le cose precipitarono nel senso opposto.
I funerali di de Sabata vennero celebrati in una forma identica a quelli di Toscanini. Un esame odierno dei giornali dell’epoca rivela che gli organi di informazione non diedero all’evento il rilievo che sarebbe stato lecito aspettarsi, ma i milanesi sì, e infatti si assieparono davanti alla Scala per l’ultimo saluto. L’orchestra del teatro eseguì la stessa "Marcia funebre". A dirigerla era stato designato Gianandrea Gavazzeni che, tuttavia, con gesto di grande e signorile umiltà, rinunciò. «Ero direttore artistico in questa sede [la Scala]», ha scritto. «Decidemmo che l’orchestra scaligera eseguisse senza direttore ciò che de Sabata aveva diretto per Toscanini. C’era un incontro, nel procedere dei due morti verso il Mistero, che non andava rotto da nessun’altra intrusione. Custodisco due "bacchette". Sono legate a due epoche per le quali la Scala è stata gloriosa... La "bacchetta" di Toscanini, donatami dalle figlie Wally e Wanda. La "bacchetta" di de Sabata, dono dei figli Elio e Eliana. Sono certo che nessun direttore d’orchestra cosciente dei propri limiti ardirebbe mai impugnarle.»
"Dionisiaco" e "apollineo", pertanto, finalmente riuniti nel loro ineffabile unicum d’arte. Per dare l’addio al grande maestro, l’orchestra della Scala suonò dunque da sola, guidata dalla fossa dal violino di spalla Franco Fantini. Nell’animo dei presenti, stipati nella piazza, il profondo senso di avere perduto qualcosa di irripetibile e irrecuperabile. Sul podio, vuoto, un mazzo di rose rosse.
Testo pubblicato con altri in: "Victor de Sabata", volume di grande formato, completamente illustrato e con 2 CD in cofanetto di interpretazioni rare del Maestro. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a Marco Contini, Via Botticelli, 22, 20133 Milano.
Quale che fosse il clima, gli piaceva immensamente abbandonare il pensiero a se stesso e vagare per la città dove era nato, che gli sembrava immensa, palpitante di vita e di possibilità di esperienza. Quasi a ogni angolo di strada, nonostante il freddo pungente e la fortissima umidità, aveva motivo di fermarsi per accostare l’occhio alla fessura di una staccionata che schermava un febbrile brulicare di attività. Milano stava sanando le ultime ferite della guerra e dandosi un nuovo assetto, rinasceva, animata da un inarrestabile slancio vitale e vitalizzante. Tanta gente per le strade, un’infinità di cose da scoprire, i tram, le vetrine, i teatri, i cinema, le librerie, le gallerie d’arte, l’università dove si sarebbe laureato e le altre di cui avrebbe timidamente battuto (incantato, in un tempestare di appunti febbricitanti sul taccuino) certe aule letterarie e filosofiche. Francesco Flora, Enzo Paci, Ludovico Geymonat...
Arrivò in prossimità di piazza della Scala. Era probabilmente la prima volta che la vedeva. La trovò quasi inaccessibile, zeppa anche nelle vie circostanti di migliaia di persone dall’espressione solenne, vestite di scuro, assiepate tutto attorno al teatro, da dove uscivano le note di una musica bellissima, che aveva sentito tante volte alla radio ma che mai sarebbe stato in grado di riconoscere. Naturalmente curioso — era nella beata età aperta a tutte le scoperte, pronta a sperimentare tutto — e rapito dall’incanto musicale (gli sembrava un evento straordinario: era la prima esecuzione dal vivo cui assistesse, e del tutto gratuitamente, per di più) si unì alla folla, si fece lentamente largo, arrivò in buona posizione. Proseguire oltre era assolutamente impossibile, quindi si fermò lì , in preda a un’emozione indicibile.
Terminata la musica, verso le dieci, dal teatro uscì un feretro, a cui si accodarono diversi carri coperti di corone e quasi tutti i presenti, formando un corteo interminabile. Il liceale comasco non si spostò; si accostò a uno dei capannelli rimasti a stazionare sulla piazza, tese gli orecchi, ascoltò in silenzio reverente. A poco a poco apprese che l’evento a cui aveva assistito era il funerale del maestro Arturo Toscanini, che il corteo avrebbe fatto un giro per la città, passando sotto la dimora milanese del defunto e spostandosi al Duomo e poi da lì al Cimitero Monumentale. La musica che tanto lo aveva commosso era la Marcia funebre dell’Eroica di Beethoven. Per dirigerla era «tornato» a Milano il maestro de Sabata, che da qualche anno non dirigeva più e di cui moltissimi — non proprio tutti — auspicavano il ritorno sul podio scaligero. Attentissimo, il liceale notò qualche nota stridente, qualche tono polemico, di cui però non poté capire il senso.
Il maestro de Sabata. La memoria del ragazzo fu attraversata da un lampo. La sua non era una casa particolarmente musicale. Avevano la radio. Niente di più. Nemmeno un disco. Soltanto nell’appartamento del nonno — che invece amava la musica classica, sia pure con distratto distacco —, c’erano un vetusto grammofono His Master’s Voice a manovella, ormai fuori uso, portato in Italia più di trent’anni prima al rientro da Londra (dove la famiglia del nonno aveva risieduto per molti decenni), e un imponente radiogrammofono (Phonola?) più recente, con due scomparti laterali pieni di vecchi 78 giri e di un solo cofanetto recente a 33 giri. (Una novità tecnica assoluta: un’intera opera su sole quattro facciate! Che diversità di suono, rispetto ai logori 78!) C’erano molte arie cantate da Caruso, da Beniamino Gigli e da Claudia Muzio. Un Barbiere di Siviglia. E la Tosca a 33 giri.
Alle festicciole del sabato tra ragazzi, a quei tempi, uno dei regali più in uso era solitamente un disco. A 78 giri o a 45. Due canzoni su due facciate. Frankie Laine. Elvis Presley. I Platters. La cultura musicale del ragazzo era tutta lì. Quando comperava un disco (per regalarlo), scendeva in casa del nonno e gli chiedeva di lasciarglielo ascoltare sul suo monumentale apparecchio "moderno". Il nonno scappava, si chiudeva nella stanza più lontana e lo lasciava fare. Il ragazzo li ascoltava senza stancarsene mai. L’idea che da quelle lastre nere, attraverso una puntina di ferro e un altoparlante nascosto dietro alcune strisce di legno e un pezzo di stoffa potessero uscire quegli straordinari suoni, lo incantava. Finito di ascoltare i "suoi" dischi destinati ad altri, ascoltava un po’ anche quelli del nonno che, sentendoli, ricompariva e si sedeva nella sua logora poltrona, perennemente accigliato, senza dire niente. Al ragazzo piacevano moltissimo le arie di Figaro, graffiatissime. Ma soprattutto Tosca. «Lola è fuggita», cantava a squarciagola, autentico pozzo di ignoranza, invece che «L’ora è fuggita». «Vissi d’arte, vissi d’amore.» Covava nell’animo confuse e inconfessabili speranze di un futuro tutto intriso di arte e di amore. Quelle poche parole gli sembravano un concentrato di tutto un senso della vita. Era la Tosca diretta dal maestro de Sabata. Che, come apprese in quell’occasione, non era dunque soltanto un astrazione meccanica, messa in atto dallo sfregare di una puntina su un impasto più o meno di ceralacca, ma una persona in carne e ossa.
Adesso, l’ex ragazzo che negli anni del liceo ascoltava quasi soltanto la musica da ballo americana e cantava a squarciagola «Lola è fuggita...» — coronati i confusi sogni di adolescente e divenuto per sua disgrazia scrittore —, ha le pareti di casa coperte di dischi. Migliaia. Sinfonie, concerti, sonate, cantate. Quasi mille opere liriche, di cui — "maniacalmente" ammalato di passione per la tecnologia — ha a poco a poco creato un catalogo computerizzato che — in nome della libera fruibilità dell’arte — ha messo a disposizione di tutti attraverso le reti telematiche. Mentre lavora, quando studia, quando riflette, quando riposa, l’atmosfera della sua casa è costantemente pervasa da note musicali. Sempre.
E adesso, all’ex ragazzo divenuto "maniaco" della musica viene chiesto di ricordare il maestro de Sabata. Inevitabile che gli torni alla memoria il giorno del funerale di Toscanini. La realtà fu quasi di sicuro diversa, ma i nomi dei due grandissimi maestri preferisce (preferisco) sempre ricordarli accomunati da quell’evento, dall’immensa maestria dell’arte, da una totale ribaltabilità di ruoli. "Apollineo", si dice del primo, e "dionisiaco", del secondo. Ma poi, a proposito dei famosi Requiem di Verdi diretti dall’uno e dell’altro, le cronache e le critiche non usano forse largamente l’aggettivo "fervore elettrizzante" per quelli di Toscanini e le espressioni "lento", "disteso", "equilibrio miracoloso" per quello in disco di de Sabata? Dunque? "Dionisiaco" o "apollineo"? Avremo qualche cosa da obiettare o perlomeno da precisare, a questo proposito, più avanti. Per adesso sfogliamo mentalmente il catalogo musicale elettronico, compilato con tanta cura dall’ex ragazzo, disco dopo disco, acquisto dopo acquisto, scegliamo dagli scaffali e ascoltiamo il troppo poco che, di de Sabata, ci rimane su disco o comunque in registrazione.
«All’idea di quel metallo/ Portentoso onnipossente/ Un vulcano la mia mente/ Già comincia a diventar», canta la voce poderosa ed elegante di Gino Bechi in una delle arie preferite dall’adolescente di Como (a cantarla, allora, su uno dei 78 giri del nonno, era probabilmente Riccardo Stracciari) e, tutto attorno, anche senza vederlo, si avverte vorticare lo scenario dell’Atto II Scena 4a di una celebre edizione scaligera del Barbiere di Siviglia (1952). La registrazione — dal vivo — risente dell’età e non è di sicuro delle più limpide ma, ugualmente, insieme alla voce, l’ascoltatore sente un autentico vulcano di musica. Lo stesso vulcano che si sente eruttare dagli altoparlanti — nel subisso di fruscii e raschi di una registrazione davvero avventurosa quanto preziosa —, mentre la voce squillante e giovanissima di Jussi Biörling canta — in svedese, nel ’36, accompagnato dall’Orchestra della Wiener Staatsoper — che se «quel guerrier» lui fosse... Una vampa di fuoco. Lo stesso fuoco da cui ci si sente avvolgere ascoltando un certo frammento dell’Otello, captato dal vivo l’anno prima sempre a Vienna, con la stessa orchestra e il Coro della Staatsoper che eseguono in tedesco "Feuer der freude", in un fremente palpitare di corde e legni. Che gioia! Che fuoco, nonostante la precarietà del suono captato con mezzi di fortuna in quegli anni lontani! Il fuoco che sapeva sempre infondere nell’esecuzione lui, uno dei più grandi direttori d’orchestra di tutti i tempi: Victor de Sabata.
"Infuocato", "estatico", "demoniaco", "incandescente", sono alcuni tra gli aggettivi che più di frequente si incontrano in volumi, testi, articoli, memorie che parlano di lui. Lo ha detto, qualche anno fa, durante un Festival di Lucerna, al giovanissimo Claudio Contini che lo intervistava intimidito in compagnia del fratello David, anche un anziano violista della London Philharmonic, arrivato alla sua ultima esecuzione. Richiesto di quale fosse il direttore che aveva esercitato su di lui la più forte impressione, rispose subito: «Sir Thomas Beecham». Naturale, il grande gentiluomo della musica, fondatore del complesso nel ’32. Con lui, spiegò, «l’orchestra diventava red hot»: rovente. «Ma soprattutto», aggiunse immediatamente, «Victor de Sabata.» Con lui l’orchestra diventava «white hot»: incandescente. Ma si proceda con ordine.
Victor de Sabata nacque a Trieste il 10 aprile 1892, figlio del friulano Amedeo — ingegno di molteplici interessi artistici (disegnatore, aspirante scultore, musicista) partito per il mondo a cercare fortuna come tanta gente della sua terra di confine — e di Rosita Tedeschi, triestina di origine ebraica. Singolare miscuglio di culture e sensibilità, che si dice abbia fatto sensazione e attirato fulmini dal cividalese. Cultura riflessiva, la prima, aspra come la sua lingua, temprata sulla rocciosità dei monti, sul silenzio delle valli, sul lavoro durissimo della campagna. Turbinosa la seconda: un «incandescente» — appunto — miscuglio di aromi italici e mitteleuropei, mediterranei e orientali: pannonici, greculi, turcheschi, di Sarmazia, di Siria, di Fenicia.
1892. Trieste. Da quale vivificante bora, da quale estenuante e irripetibile austro generatore di estri era sferzata? L’impiegato di banca Italo Svevo pubblicava Una vita. Antonio Smareglia stava componendo o perlomeno ideando Nozze istriane (1895). Umberto Saba, quasi decenne, iniziava l’apprendistato di sottile malinconia che di lì a un decennio avrebbe prodotto Il mio primo libro di poesia. Scipio Slataper aveva quattro anni. A pochi chilometri di distanza, Carlo Michelstaedter ne aveva soltanto uno di più...
È probabilmente proprio da questo miscuglio di malinconia ed energia creativa, di vibratilità e solidità, che discese, nel tempo, l’arte a due facce di Victor de Sabata: incandescente e al tempo stesso precisissima. Con l’aggiunta del senso squisitamente ebraico-orientale della lontananza forzata dalla heimat, dalla terra natale, e, quindi, dell’esigenza innata di essere di casa ovunque, di essere giocoforza spiriti internazionali. Quel senso che così bene il triestino Claudio Magris ha descritto in Lontano da dove. Felice (e malinconico) titolo che riprende poche righe fulminanti di Saint-Exupéry. Disse un ebreo a un altro: «Vai dunque laggiù? Come sarai lontano!» «Lontano da dove?», rispose l’altro. Da quale ubi consistam, da quale heimat? Victor de Sabata fu di casa ovunque, a Milano come a Montecarlo, a Roma come a Vienna, a Montecarlo come a Cincinnati. E si portò dietro un altro retaggio di natura "orientale": la superstizione, il senso arcano delle congiunzioni astrali. Nel ’27, mentre stava preparando la sua prima Norma a Montecarlo, sua madre morì. Non volle mai più dirigere l’opera.
A Milano ci arrivò a otto anni, al seguito di tutta la famiglia, in Via Canova. La riflessività friulana mescolata al senso triestino del mare ne aveva fatto un appassionato di navigli, un aspirante (e mancato) ingegnere navale che si portò dietro per tutta la vita (anche nel mestiere) questa ulteriore lontananza da un dove professionale mitizzato nella prima infanzia. Venne prestissimo iscritto al Conservatorio Giuseppe Verdi, spedito a studiare musica con Giacomo Orefice e Michele Saladino, che già alla fine del corso del 1904 attesterà: «Vittorio de Sabata, allievo del Regio Conservatorio..., è dotato di speciali attitudini musicali, sì da presagire bene per farne un degno artista». Mai presagio poteva essere più felice e lungimirante.
Nello studio del pianoforte rivela immediatamente doti molto fuori dal comune. Al terzo corso decide di affrontare il violino complementare. Nel 1904, a dodici anni, consegue la prima licenza, in teoria e solfeggio. Al saggio si presenta in qualità di compositore, pianista, direttore d’orchestra e violinista. Già è in grado di eseguire in pubblico un suo Andante e Scherzino per pianoforte, che l’anno seguente dirigerà, nella trascrizione per piccola orchestra, durante un saggio per piccoli allievi del Conservatorio. È la prima volta che dirige. L’evento, oltre che in qualche entusiastica noterella di stampa, arriva fino a noi attraverso una bella fotografia d’epoca. Compresi nella loro parte, impalati nel vestito buono, i tredici giovanissimi esecutori (nessuno aveva più di dodici anni) fissano con qualche apprensione l’obiettivo. Al centro, eleganti pantaloni alla zuava, sparato bianco, musicalissimo ciuffo sull’occhio sinistro, spartito bravamente stretto nella destra, il "maestrino".
Nel 1906 è promosso (con premio di 3deg. grado) da "armonia e contrappunto" a "contrappunto e fuga". Qualche giorno più tardi presenta una sua nuova composizione per pianoforte: Allegro - Barcarola - Giga. Sei giorni più tardi ottiene 8,50 in violino complementare e, subito dopo, 9,50 in pianoforte complementare. Ma il suo perfezionismo, la sua ostinazione friulana gli vietano di fermarsi a quei livelli. «Si accorda la licenza», scrivono i commissari d’esame, «ma [de Sabata] domanda di frequentare ancora la scuola.»
Studio, perfezionamento, massimi voti, esecuzioni, piccole (e non tanto piccole) composizioni si susseguono con ferrea determinazione, finché nel giugno del 1909 de Sabata dirige (per la prima volta a capo di una grande orchestra) una sua Ouverture in la maggiore. Nel maggio del 1910 arriva finalmente il diploma, con un voto impressionante: 9,65. Intanto ha composto una Suite per grande orchestra, che dirigerà nel gennaio 1911. Il grande Maestro si è già rivelato in nuce. Allo stesso 1911 risale forse il suo primo incontro con Toscanini, allorché suona il timpano nell’orchestra formata dagli allievi del Conservatorio e diretta dal maestrissimo nel decennale della morte di Verdi. Ben altri decennali del Grande di Busseto, de Sabata avrebbe poi avuto modo di celebrare con il suo lavoro di artista. Il quarto, a Roma, nel ’40, con un Requiem dal cast grandioso: Caniglia, Stignani, Gigli, Pasero. Il successo fu tale che i responsabili della manifestazione si spinsero fino a offrirgli una maggiorazione del compenso pattuito da 15.000 a 25.000 lire. Aristocratico e sdegnoso signore, lui declinò l’offerta. Il quinto, a Milano, nel ’51, con un ennesimo Requiem, in cui cantavano Tebaldi, Rankin, Prandelli, Rossi-Lemeni.
Nel 1917, alla Scala, direttore Panizza, viene creata la sua unica opera: Il macigno. E l’anno seguente, a ventisei anni, de Sabata diventa direttore d’orchestra stabile presso l’Opera di Montecarlo, dove il padre aveva già trovato stabile dimora in qualità di direttore dei cori. All’anno seguente risalgono le sue prime direzioni: Tosca, Falstaff, La rondine e La fanciulla del West. Scelte significative, profetiche. È probabilmente superfluo rammentare quanto questi quattro titoli abbiano significato per la sua carriera a venire. Ma rammentiamolo ugualmente. Contemporaneamente conclude la sua prima composizione importante, il poema sinfonico Juventus, che due anni più tardi inserirà nel primo concerto tenuto all’Accademia di Santa Cecilia insieme a brani strumentali di Flauto magico, Cigno di Tuonela, Psyché di Franck, Voci e ombre del vespero di Pick-Mangiagalli, Don Giovanni di Richard Strauss. Titoli significativi anch’essi di una grande versatilità, oltre che rivelatori dei suoi ascendenti come compositore. Nello stesso anno, a Montecarlo, dirige la prima esecuzione di Sadko per quel teatro e il Trittico pucciniano, con prima esecuzione francese di Gianni Schicchi.
A trent’anni, nel ’22, oltre a padroneggiare magistralmente l’amatissimo Puccini, ha già diretto un’autentica schiera di cantanti, tra cui spiccano i nomi di Beniamino Gigli, Mattia Battistini, Tito Schipa, Vanni Marcoux, Giacomo Lauri-Volpi, Gilda Rizza. L’anno dopo vi aggiungerà la divina Claudia Muzio, per un’Aida di cui si sognerebbe di poter sentire almeno qualche frammento (per non parlare della Tosca del ’24). A questa corolla di voci da mito andrà via via aggiungendo petali sempre ugualmente preziosi, se non persino di più: vengono in mente, frammentariamente, Pampanini, Thill, Björling e Nemeth, Flagstad e Lorenz, Caniglia, Stabile, e giù giù, fino ai Di Stefano e Callas, Siepi e Tebaldi degli ultimissimi anni (quanto presto arrivati, purtroppo!)
Nel ’25 dirige la prima assoluta di L’Enfant et les sortilèges di Maurice Ravel, con entusiastica gratitudine del compositore, che il giorno dopo gli scrive: «Vous m’avez donné une des joies les plus complètes de ma carrière...»; nel ’26 aggiunge alla propria corona di rose Boris e Rosenkavalier (anche in questi casi, proprio nessuno avrà conservato una sia pur minima traccia registrata?); nel ’27 dirige i primi concerti negli Stati Uniti e alla Scala, dove finalmente, nel febbraio del ’30, a trentotto anni, arriva come direttore d’opera dirigendo quello che è già un suo cavallo di battaglia, La fanciulla del West, con Gilda Rizza e Georges Thill, sue ormai vecchie conoscenze del palcoscenico di Montecarlo. Più una Dannazione di Faust sicuramente memorabile, con Merli, Galeffi e Baccaloni. Seguite a breve distanza dal suo primo celebre Tristano (tutto italiano, con Cobelli, Zanelli, Stignani, Rossi-Morelli).
Tristano e Isotta. Un’opera di cui Alberto Savinio ha scritto: «Aristotele pensava certamente a questa partitura così grondante amore quando inventò per la conclusione della tragedia la parola "catarsi". Da quando il violoncello attacca nel cuore del silenzio il sospiroso "la fa, mi" sul quale cade il gemito dei legni, tutto il fiume sonoro che nasce da quella sorgente entra in moto gonfio di speranza e assieme di disperazione e si avvia inesorabilmente alla sua foce, che è l’unione finale dei due amanti nell’amore e nella morte. Ora, a quest’ultima rappresentazione del Tristano io ho visto questo...». Difficile sapere chi ci fosse sul podio di quell’esecuzione (febbraio 1943) al Teatro dell’Opera di Roma, ma poco conta. Non doveva comunque essere de Sabata, sebbene proprio il 21 di quel mese avesse diretto a Santa Cecilia il "Preludio" e la "Morte di Isotta"... Ma quanto appartengono all’"infuocata" ideologia interpretativa desabatiana espressioni forti come "amore", "morte" (e l’unione dei due!), "tragedia", "catarsi". Quanta "purificazione". Non a caso, da quel lontano 1930, il Tristano era diventato uno dei suoi imprescindibili punti di riferimento.
Lo portò a Bayreuth, tra l’altro, nel ’39, primo italiano dopo Toscanini. Il risultato fu "sensazionale", come ha ricordato in un articolo sulla Bayerische Ostmark il critico Paul Bülow: «Quando l’italiano... si è messo al lavoro, sul podio, senza partitura, la prova è diventata davvero un avvenimento sensazionale nel miglior senso della parola. Dirigere a memoria non è ormai una rarità. Ma farlo come de Sabata..., avendo impressi tutti i particolari della partitura, è cosa al limite del leggendario... il pubblico avvertito, munito di partitura, constata l’assoluta esattezza delle correzioni [da lui segnalate agli strumentisti].» E Il General Intendant del Festspielhaus, Heinz Tietjen, gli dichiarò nel camerino: «Siete ormai legato a Bayreuth: non si può comprenderla senza di voi: voi siete dei nostri... Ditemi che cosa volete dirigere». A proposito di un altro Tristano, a Berlino, Sergiu Celibidache (da più parti indicato come uno dei più fedeli proseguitori artistici dell’ideologia musicale di de Sabata, della sua visione fenomenologica della singola esecuzione come evento irripetibile), ha dichiarato in un’intervista: «Ci nascondevamo nel gabinetto e restavamo lì tutta la notte, per poter sentire la prova del mattino dopo: senza luce, guardando la partitura con il fuoco dei fiammiferi. Che enorme impressione, ancora adesso se ci penso mi vengono i brividi».
Lo eseguì, acclamatissimo, il 14 aprile del ’48 alla Scala con un cast d’eccezione (Lorenz, Flagstad, Weber, Schöffler). Ne rimane, purtroppo (salvo errore), soltanto qualche frammento captato via radio, tra cui quello in cui l’immensa Kirsten canta «Mild und leise». Quanto "amore". Quanta "tragedia". E, nella musica, quanta "catarsi", quanta "purificazione". Peccato non averne una registrazione completa, che ci rimane invece dell’esecuzione del 13 dicembre ’51 con un altro cast straordinario: Lorenz, Grob Prandl, Sven Nilsson, Sigurd Björling, Cavelti. Ah, anni (almeno) musicalmente felici di quella che viene ricordata come l’Italietta, ma che forse sarà da riscoprire anche per altri aspetti.
Parlando di una di questi Tristani, Teodoro Celli, nelle primissime pagine del suo prezioso L’arte di Victor de Sabata ha scritto: «Quando uscii dal teatro... sotto il peso d’una delle più intense emozioni che la musica mi abbia mai procurato, capii confusamente d’aver "scoperto" Wagner... Ma capii anche... quanto, di quella rivelazione, io dovessi attribuire alle meravigliose qualità d’interprete di quel maestro...»
Nel frattempo, mentre preparava il suo primo Tristano alla Scala, il de Sabata compositore ha terminato di comporre il balletto Le mille e una notte. E la sua carriera di direttore prosegue. Nel ’31 avviene la famosa, clamorosa rottura con la Scala. Provocata, secondo Teodoro Celli, dal fatto che l’orchestra avrebbe preteso di suonare un certo passaggio come lo dirigeva il "maestro" Toscanini. Replicò gelidamente: «Quando dirigo, il maestro sono io». Posò la bacchetta sul leggio e se ne andò. Scrive invece il violinista Enrico Minetti nel suo Visita a de Sabata, pubblicato in almeno due fonti: «Il Maestro aveva portato a termine la preparazione della Manon di Massenet ed eravamo arrivati alla prova generale... proprio nell’introduzione dell’opera, causa un malinteso gesto del Maestro, metà dell’orchestra sbandò! Se vogliamo essere sinceri, l’errore non era nostro, infatti quando il gesto non è chiaro e metà massa sbaglia, il torto è della bacchetta. De Sabata, irritatissimo... proferì parole ingiuriose e ingiuste al nostro indirizzo e allora Gino Nastrucci, che nel 1931 era ancora violino di spalla, battendo l’archetto sul leggio protestò energicamente per le immeritate offese all’orchestra. Il Maestro, pallidissimo, disse una sola parola: "Preferisco!" e lasciò cadere la bacchetta. Poi scese dal podio e attraversò il "golfo mistico" per uscire... lasciò il teatro e la Manon passò a Panizza».
Due diverse rotture nello stesso anno? Sembrerebbe eccessivo. Due diverse versioni del medesimo evento, è più probabile. Che, pur nella loro diversità, lascerebbero trapelare come i rapporti tra i due grandi Maestri non fossero poi così idilliaci. Certamente non lo erano tra le due opposte e armate schiere dei loro seguaci e sostenitori. Paese inguaribilmente innamorato della ricerca di interminabili e bizantineggianti soluzioni di mediazione, proprio in quanto irrinunciabilmente capace di godere con sfrenata passione di veri o presunti dualismi — e quindi avido di crearne di sempre nuovi con sfrenata ansia —, l’Italia non poteva di sicuro rinunciare a tale sua intrinseca passionalità in un ambito dove la passione è regina: l’esecuzione musicale. Pertile o Lauri Volpi? Callas o Tebaldi? Del Monaco o Corelli? Abbado o Muti? E così via. Oltre che, naturalmente, Toscanini o de Sabata?
In più di un salotto di informatissime sofonisbe musicali si mormora ancora oggi che un giorno di oltre cinquant’anni or sono, ricevuti Walter Legge ed Elisabeth Schwarzkopf nella sua casa milanese di Via Durini, Toscanini avesse chiesto loro quale felice zefiro li avesse portati lì. Informato che si stava procedendo alla registrazione della Messa da Requiem di Verdi diretta da de Sabata — e su questo punto il mormorio si fa ancora più cauteloso e al tempo stesso concitato —, il maestrissimo sarebbe esploso in una serie di epiteti poco onorevoli per il collega ma, a onor del vero, anche per lui stesso. Non bastano, deve avere pensato — mettiamoci per un attimo nei suoi fragili panni di artista supremo, esposto a mille fremiti umorali —, le mie esecuzioni? Che cosa fate? Copiate? Di Stefano e Siepi non hanno già cantato con me non più tardi di tre anni fa?
Sarà un episodio vero o apocrifo? Chi lo racconta riferisce di averlo raccolto di persona dalle (evidentemente prodighe) labbra di Walter Legge. Lo si riferisce qui per amore di cronaca. Personalmente preferisco pensare ad altro. Guardare una emozionante foto dei due grandi Maestri colti insieme nella penombra della platea della Scala. Toscanini sta dicendo qualcosa, forse spiegando, con espressione intenta, e de Sabata ascolta, il viso atteggiato ad aristocratico rispetto, in nulla sottomesso. Le dita delle mani, incrociate sullo schienale della poltrona, mi piace pensare che stiano segnando il tempo del dire dell’interlocutore, onde penetrarlo a fondo, interpretarlo in tutte le sue pur minime sfumature, in tutte le sue implicazioni inespresse, come uno dei tanti brani musicali a cui dedicava la sua precisissima, "maniacale", cura esegetica.
Preferisco risalire con la memoria al fortunato (in un certo senso) evento di qualche anno più tardi: la fortuita presenza del liceale di Como al funerale di Toscanini "officiato" musicalmente da de Sabata. Quando era rimontato sul traballante treno della Nord, quel giorno di febbraio del 1957, il giovane aveva la mente piena di musica. Di musica non soltanto riprodotta tecnicamente ma "viva". Aveva avuto il suo primo incontro con uno dei massimi templi musicali: la Scala. Ne sarebbero seguiti chissà quanti, con tanto loggione e poi — in tempi meno magri — con molte onerosissime annate di abbonamento in platea, ma quell’anno e quel particolare episodio gli rimasero impressi nella memoria. Al punto che, oltre trent’anni più tardi, trovatosi a ideare un romanzo che parzialmente si svolgeva in quel 1957 e a creare un sfortunato personaggio milanese letteralmente arso da una bruciante passione musicale, pensò subito di inserirvelo. La precisa (quasi "maniacale", e l’aggettivo non viene impiegato a caso) collocazione storica di ambienti e personaggi era una delle caratteristiche salienti del suo lavoro di scrittore. Lo inserì dunque nella scaletta. Ma, arrivato al dunque, al momento di mettere su carta quello specifico sviluppo della vicenda, scoprì che le date non coincidevano. Doveva essere il 1957, sì, ma un po’ più in là nel tempo. Per sottili motivi strutturali doveva collocare l’episodio agli inizi di primavera.
Fu costretto a "ripiegare" su un altro memorabile evento musicale dell’epoca, a cui peraltro, segregato nella sua campagna comasca, non aveva potuto assistere e che quindi dovette ricostruire con ricerche bibliotecarie su testi e recensioni dell’epoca. L’indimenticabile Anna Bolena del 14 aprile, diretta da Gavazzeni, con Maria Callas, Nicola Rossi-Lemeni, Giulietta Simionato. Felicissimo ripiegamento, certo, a fare da cornice a uno sviluppo doloroso del suo romanzo (sia consentito di citarne il titolo: Il destino di un uomo). Ma come sarebbe piaciuto, all’ex liceale di Como divenuto scrittore, per introdurre la tragica fine del suo sfortunato eroe, per sottolinearne le cadenze di "amore" e "morte", servirsi dell’episodio "unificante" che portava stampato nella mente. Il funerale "reale" di Arturo Toscanini, celebrato musicalmente dal funerale "artistico" di Victor de Sabata.
Comunque, la realtà è realtà, anche per le cronache e per le riflessioni critiche: è del tutto credibile che i rapporti tra Toscanini e de Sabata non fossero per niente idilliaci. E quanti soffiavano sul fuoco. Ah, «perfidi sicari...». Allora, per noi, quaranta e passa anni più tardi: Toscanini o de Sabata? Apollineo" o "dionisiaco"? Dionisiaco, de Sabata lo era senza dubbio nel carattere, come abbiamo visto, nel temperamento. Come avrebbe potuto essere altrimenti, per un mezzo "orientale", sempre "lontano da dove"? Capace di amarissime malinconie e di furie terribili: «Ma se mi toccano dov’è il mio debole...». «Un sognatore e un turbolento», ha scritto di lui Fernando Previtali. «Come interprete si può dire che ha certamente creato un nuovo tipo di interpretazione, ricca di grandi contrasti, di sonorità smaglianti, di pianissimi impareggiabili, ottenuti anche con il suo gesto, espressivo in modo inequivocabile.»
Amara Scala! «Questa terribile Scala che lascia il segno a tutti», avrebbe esclamato addirittura Enrico Caruso, citato in un articolo di Teodoro Celli su Oggi. Quindi, secondo logica, al momento debito anche de Sabata avrebbe incontrato le sue difficoltà con il tempio musicale milanese. Ovvero, meglio, con certi suoi appassionati e cavillosi frequentatori e commentatori. Persone a cui sembrava (e sembra tuttora) obbligatorio giocare sul dualismo, rinfocolare sempre il confronto/scontro tra "dionisiaco" e "apollineo", tra de Sabata e Toscanini. Fino a rischiare che il primo lasciasse la Scala una seconda volta per stabilirsi oltre oceano. Teodoro Celli li ammoniva con vigore, questi Pelnellovo dell’ascolto, nel medesimo articolo: «Sono, costoro, i nostalgici. Ricordano i tempi di Toscanini e rimpiangono. Anche rimpiangere è un gusto come un altro: un po’ amaro ma evidentemente molto gradito a certi palati... Ebbene, noi preferiamo il gusto della speranza a quello sciocco del rimpianto... E siccome siamo convinti che, con la permanenza di de Sabata alla Scala per un lungo periodo, si possano concepire per il nostro teatro bellissime speranze..., vogliamo dire al maestro il nostro "grazie" per il suo proposito di rimanere nonostante tutto... Nonostante una pattuglia di sconsigliati stia facendo di tutto per indurlo ad andarsene, irritato, per sempre. Forse l’ideale di costoro sarebbe proprio questo: che anche de Sabata si stabilisse definitivamente al di là dell’oceano. Pensate che bazza per quei cari nostalgici: doppio motivo per rimpiangere: "Ah, quando c’era Toscanini! Ah, quando c’era de Sabata"». Nihil sub sole novi, come recitava l’Ecclesiaste già diversi millenni or sono (I, 9). Anche ai nostri giorni, certo loggionismo (e plateismo) degli stenterelli si bea di spargere lacrime postume di coccodrillo sulla scomparsa dai cartelloni della Scala di altri nomi, riparati in lidi meno procellosi proprio in quanto vittime dell’acredine dei medesimi stenterelli, di un atteggiamento che molto spesso non si può definire spirito critico ma è pura e semplice scarsa educazione. I nomi degli artisti restii a tornare a esibirsi alla Scala li sanno tutti.
Comunque, tornando ai dati della vicenda umana di Victor de Sabata, la rottura del 1931 durò poco: tornato alla Scala in novembre per preparare Fedora, venne accolto con entusiasmo, e il rapporto con il teatro, destinato a durare più di un ventennio — fino al 1953 e, in diversa forma, fino alla fine della vita del Maestro —, riprese. In quella Fedora cantavano Pertile e Stabile. Fu seguita da un ennesimo Tristano (anche questo tutto italiano), dall’Amore dei tre re di Montemezzi e da una Turandot con Maria Caniglia, da un Crepuscolo, da un Andrea Chénier con Gigli e Cigna. Prima di arrivare al fatidico 1953 si potrebbe andare avanti per pagine e pagine, tutte intrise dell’arte e della sapienza musicale di Victor de Sabata.
Più precisamente: la fatidica notte tra il 26 e il 27 settembre 1953. Già all’inizio dell’anno, in navigazione fra Le Havre e New York, si erano manifestate le prime avvisaglie di disturbi cardiaci. Ma la tournée americana si era conclusa felicemente, con concerti in California, in Canada e a Philadelphia. Erano seguite altre trasferte musicali, a Londra (con la già citata Philharmonic di Sir Thomas "Red Hot" Beecham), a Salisburgo. Altre direzioni alla Scala. La registrazione, in agosto, della più bella Tosca di tutti i tempi (con Giuseppe di Stefano a cantare per le pareti del carcere e per Maria Callas il «Lola è fuggita» del liceale di Como). Impresa grandiosa ma, evidentemente, troppo affaticante. Il 25 agosto, a Milano, de Sabata viene colto da una seconda crisi e deve rinunciare a un concerto al Festival di Lucerna. Un mese più tardi la crisi esplode, traumatica, irreversibile. La lesione al miocardio è gravissima, i medici non escludono che possano seguire ulteriori complicazioni; il maestro giunge all’amara decisione di non dirigere più. Tornerà sul podio soltanto nel 1954 per registrare il celebre Requiem di Verdi e nel 1957 per la sua ultima direzione: quella al funerale di Toscanini. Poi, per oltre dieci anni, il silenzio artistico, la malinconia dell’esilio a Santa Margherita, prima all’Hotel Lido, poi al Metropol, poi all’Eden e infine al Regina Elena.
In occasione del Requiem di studio disse di essere tornato a Milano «per dimostrare che sono vivo», ma per la prima volta non diresse in piedi: sul podio gli era stato preparato un sedile. Ne parlo con la figlia Eliana nella bella dimora di famiglia di Gavarno Vescovado, nel bergamasco, antica, traboccante di cimeli e cose belle, immersa nel verde e nel silenzio. Al piano di sopra, in un immenso granaio trasformato in studio, tra pareti tappezzate di partiture, testi e testimonianze musicali, il genero di de Sabata, Aldo Ceccato, sta laboriosamente studiando una partitura particolarmente complessa di Bartok, di cui è stato invitato a dirigere a Budapest le celebrazioni musicali del cinquantenario della morte. L’amore che legava padre e figlia non cessa di fluire dagli occhi nerissimi e brucianti di Eliana. Ricorda la dichiarazione del padre, ma ricorda anche che, finita la registrazione, salendo ancora una volta sul podio per le ultime incombenze, inciampò e rischiò di cadere. Il fiato dei i presenti rimase sospeso. Temettero tutti che l’infarto si fosse manifestato una seconda volta. Per fortuna non era così, il maestro si rialzò. Ma dal suo atteggiamento, dal suo sguardo, la figlia capì che era accaduto qualcosa di irreparabile. Lui, dominatore della partitura, dell’orchestra, dei cantanti e del pubblico, aveva rischiato di cadere, di mettere a repentaglio non tanto la propria salute quanto la propria dignità. E se davvero fosse successo che l’infarto lo colpisse durante un’esecuzione? Se fosse morto in pubblico, sotto lo sguardo di centinaia di persone, impossibilitato a tenere in qualsiasi modo sotto controllo la propria persona? Lo spirito scientifico gli imponeva di pensare a ciò che succede al corpo che cede in simili condizioni, alle scene assolutamente prive di dignità che si verificano. Lo pensò di sicuro, ipotizza oggi Eliana de Sabata Ceccato. No, meglio smettere, lasciare il ricordo della propria persona inflessibilmente eretta e "danzante" sul podio. Meglio far calare il sipario.
Pure, a dirigere il Requiem era tornato perché glielo imponeva un contratto appena stipulato con la Voce del padrone guidata da Walter Legge con pugno alato ma ferreo. Un contratto a cui la sua adamantina dirittura di friulano e mitteleuropea gli vietava di venire meno. Avrebbe, dopo Tosca, dovuto registrare quelle che sarebbero diventate la grande serie di opere realizzate dalla collaborazione della grande casa discografica con l’ente scaligero. Preferì rinunciare, anche se Legge insistette fino all’ultimo per proseguire nella collaborazione, fino al punto da chiedergli — in una lettera conservata dalla figlia — di pensare alla possibilità di comporre un nuovo finale per Turandot. Quali documenti di incalcolabile interesse potremmo avere, adesso, noi, arrivati tardi a conoscere e ammirare la sua arte! Invece no, decise che di questa sua arte doveva rimanere il ricordo di quando era nel pieno delle forze, non soggetto al rischio di mettere pubblicamente a repentaglio la dignità.
Di che cosa erano fatte, l’arte e la sapienza musicale di Victor de Sabata? Di vulcanico spirito dionisiaco, sicuramente. Di "mimica" interpretativa. De Sabata, ricorda chi ha avuto la fortuna di vederlo dirigere, "danzava" sul podio. Der Teufel am Pult, lo chiamavano scherzosamente gli strumentisti di lingua tedesca: "Il diavolo sul podio. Dirigeva con le mani — certo —, usando canonicamente la destra e la sinistra nei prescritti movimenti, ma anche con tutto il corpo, con la testa, con gli occhi. «Che sembravano volermi magnetizzare», ha ricordato Renata Tebaldi. Con una straordinaria presenza, dunque, ed energia fisica, frutto di passione musicale ma probabilmente, anche, di un surplus di carica energetica indotto da una sfortunata menomazione fisica. De Sabata era claudicante, come conseguenza della poliomielite contratta in tenera età. Chiunque abbia una qualsiasi menomazione, si sa, tende istintivamente a iper reagire per compensarla, e non è forse sbagliato pensare che l’iper mimica di de Sabata sul podio avesse in parte radici in questa iper reazione fisica istintiva alla menomazione. Ma anche radici ben più razionali e colte. Non era forse, il de Sabata compositore, nell’opinione comune, un wagneriano attraverso la mediazione straussiana? È quindi forse opportuno fare riferimento al concetto di "mimica" come delineato da Wagner nei suoi testi teorici. In scena e attorno alla scena, aveva scritto il grande tedesco, devono esserlo tutti, musicisti compresi. E più di tutti il maestro direttore, che per esprimersi ha a disposizione unicamente il gesto. Istinto e ragione, dunque, in un felicissimo impasto realizzativo.
Arte e sapienza, però, fatte anche di una mente squisitamente matematica, da quell’ingegnere navale mancato che de Sabata era, una mente che lo rendeva attentissimo anche alle questioni tecniche degli allestimenti teatrali, come ha ricordato Nicola Benois, suo collaboratore in tante imprese scaligere. «Aveva una passione, diciamo così, scientifico-meccanica», ha scritto il suo commosso erede Gianandrea Gavazzeni. E infatti appuntava lo stesso de Sabata nel 1930: «Un’orchestra concepita modernamente dovrebbe avere anche degli strumenti che costituissero una via di mezzo fra archi e fiati (legni). Oltre ai saxofoni, dunque, dovrebbe avere dei violini, viole e celli (1 , o 2 di ogni categoria) con una "campana" metallica o di legno uso saxofoni. Vedere se possibile farne costruire. Credo esistano già».
Ma aggiunge Gavazzeni: «Era un uomo estremamente complesso... una personalità di molti segreti interni, che nessuno riusciva a penetrare». Segreti di natura unicamente "dionisiaca"? Chissà. Qual è esattamente il discrimine tra "dionisiaco" e "apollineo"? Sarà mai possibile calcolare dove finisce il fuoco dell’istinto e dove comincia l’ordine della ragione? E come si mescolano nell’atto creativo? Di certo, è dal loro fortunato miscuglio che deriva il fascino della vera opera d’arte, nell’esecuzione come nella creazione: l’inquietudine dell’avventura in spazi inesplorati, nel disvelamento del nuovo. E questo è stata, fondamentalmente, la sapiente arte di Victor de Sabata, una sensazionale capacità di analisi sempre più profonda del testo musicale, un continuo, inquieto ma ragionatissimo procedere verso luoghi sempre più inesplorati della musica che era chiamato a dirigere e in molti casi a fare rinascere, verso nuove, emozionanti scoperte per se stesso, per gli esecutori che seguivano il suo comando musicale, per chi lo ascoltava.
D’altra parte, non era forse attraverso un dionisiaco turbinare di fumi, di emanazioni e sensazioni sconosciute, forse anche di sostanze dionisiacamente inebrianti, che nei templi di Apollo — a Delfi, a Didima, nei tanti altri meno imponenti e meno celebri —, pizie, pitonesse e sacerdoti rivelavano ai trepidi supplici l’apollineo volere del dio dell’ordine e della salute, della poesia, del canto e della cetra (secondo Omero), maestro delle arti e condottiero delle Muse — insomma di tutto ciò che è Bene e Bello —, interprete e disvelatore del volere del sommo Zeus? «Conosci te stesso», avevano fatto scrivere i Sette Saggi sul frontone del tempio di Delfi. Scopri, anzitutto, quello che hai dentro di te e fallo emergere, usalo come strumento di svelamento e spiegazione del mistero che ti assilla. Dopo di che potrai mettere a frutto la ragione così depurata e volgere il mistero a profitto tuo e altrui, creando il nuovo. Apollo più Dioniso, dunque. Dioniso più Apollo. Non sono in definitiva, Apollo e Dioniso, entrambi figli di Zeus — il primo generato nel ventre di Latona e il secondo di Semele —, frutti del suo sommo ma ondivago e ambivalente volere e dunque destinati a unirsi per disvelarlo come unicum? Così, almeno, ama pensare, e non soltanto per il lavoro di de Sabata, chi sta scrivendo qui.
«Victor de Sabata o del demoniaco, dicevano», ha scritto Giorgio Strehler, ricordando la comune triestinità e la passione per la navigazione. «Io direi: della grazia... o della completezza di una natura tutta musicale fino all’ultimo atomo e quindi capace di avvicinarci ai mondi più diversi e lontani.» Della grazia... o della completezza... Il lavoro di de Sabata, infatti, oltre che di fuoco istintuale, era intimamente fatto di "ragionamento". Di conoscenze tecniche vastissime, che gli consentivano di spiegare agli strumentisti esattamente il gesto tecnico necessario per ottenere un risultato. Riferiscono le cronache dei contemporanei che sapeva spiegarlo a pianisti e violinisti (strumenti in cui, come abbiamo visto, eccelleva fin dalla prima infanzia). Lo spiegò a un trombone, durante le prove di un L’enfant et les sortilèges, come ha ricordato Gianandrea Gavazzeni: voleva che lo strumento eseguisse una certa nota "in quarta posizione" e dimostrò come si doveva fare per ottenerla. Lo spiegò persino alle arpiste, durante una prova di Valchiria.
A Teodoro Celli spiegò come si deve imboccare il corno inglese per avere un certo effetto. E non aveva forse suonato addirittura il timpano, sotto la direzione nientemeno che del grande Maestro di cui era inconsapevolmente destinato a diventare l’antagonista, Toscanini? A Renata Tebaldi, colpita nella prima gioventù da un male che le rendeva a volte poco agevole muoversi sul palcoscenico, si dice che avesse anche cercato di insegnare come superare questo handicap: dallo stesso male (o da uno simile) era stato colpito anche lui, aveva imparato con inesorabile ostinazione friulana tutte le arti per attenuarne al massimo le conseguenze e vincerle. Aveva precisa coscienza, si sostiene, che il suono si propaga nell’aria secondo una certa formula matematica, e quindi che, stando sul podio, doveva sapere con assoluta precisione che cosa arrivava agli ascoltatori collocati nei diversi punti del teatro, e dirigere di conseguenza, esigendo questo o quello dai diversi settori dell’orchestra e dalle voci.
Un lavoro fatto, inoltre, di una memoria prodigiosa, quasi "maniacale" (come mi piace, questo brutto aggettivo, quando è riferito alla tecnica di lavoro di un servitore delle Muse), che gli consentiva non soltanto di memorizzare le partiture nota per nota (in una sola notte, a Londra, quelle di un difficile pezzo di Elgar), ma anche di correggere gli errori di stampa che si possono inevitabilmente riscontrare in qualsiasi edizione, anche la più accurata (e che persino l’autore può rischiare di non vedere!). Li correggeva e li faceva correggere sulle partiture dei suoi professori d’orchestra. Una memoria che gli consentiva, a decenni di distanza, di ricordare un errore commesso da un giovanissimo collega ai tempi dell’Orchestra del Conservatorio, come ha ricordato Michelangelo Abbado in una sua preziosa e divertita memoria.
«Accanto», scrive, riferendo un episodio dei suoi anni impuberi, «avevo un violinista più vecchio di me. Giunto al famoso passaggio» — di una Sinfonia di Haydn, se l’era coscienziosamente fatto spiegare dal maestro, Enrico Polo — «mi buttai sulla parte superiore. Altrettanto fece il mio vicino, che senza smettere di suonare mi ingiunse di fare la parte di sotto. "No, tocca a me la parte superiore, me l’ha detto il mio maestro". Così suonammo all’unisono l’intero passaggio e per quella mattina la parte inferiore dei secondi violini risultò più debole della superiore. Alla prova successiva il mio compagno di leggio venne chiamato a rinforzare i primi violini. Il giovane che prese il suo posto mi spiegò che Polo, abituato a fare da spalla, si era riferito ai primi violini.» Mentre i secondi dovevano comportarsi in maniera specularmente opposta. Insomma: «Il mio ex compagno di leggio aveva ragione!»
E chi era questo compagno di leggio? Continua Michelangelo Abbado: «Quattro o cinque anni or sono mio figlio Claudio andò a Santa Margherita Ligure... a visitare il grande direttore d’orchestra... Al momento del commiato [de Sabata] disse sorridendo a Claudio: "Mi saluti suo padre, che voleva fare la parte superiore, quando eravamo vicini nell’orchestra del Conservatorio"... Rimasi di stucco... Rividi accanto a me un giovane sui vent’anni, alto e smilzo, e la sua smorfia di commiserazione per la mia testardaggine. Chi avrebbe immaginato che era de Sabata? Lui invece aveva voluto sapere il nome di quel ragazzino ostinato, e con la sua prodigiosa memoria ricordava ancora l’episodio a distanza di oltre mezzo secolo.»
Tale era la memoria di Victor de Sabata. Di fronte a una così meticolosa ( e, ripetiamo pure, "maniacale") attenzione "tecnica" nei confronti dell’esecuzione e dei suoi risultati, è lecito continuare a parlare di "dionisiaco" in contrapposizione ad "apollineo"? Chi era il dio dell’Ordine e della Technè? L’arte è eminentemente struttura. L’anelito a raggiungere un certo risultato impone inesorabilmente al creatore e all’esecutore l’impiego di un certo linguaggio e soltanto di quello, di certe tecniche e non di altre. L’opera d’arte è un unicum irripetibile, per quanto interpretabile. Non a caso de Sabata usava dire ai suoi collaboratori,: «Signori, lasciatemi plasmare la musica», come ha ricordato Mario Dorizzotti, percussionista dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia. Plasmarla secondo quanto gli dettava la sua cultura, musicale e complessiva, una cultura che, come ha ricordato Carlo Maria Giulini, «spaziava in campi molto vasti: egli cercava rapporti fra fatti matematici, scientifici e addirittura astrali con il mondo dei suoni». Rapporti astrali, sicuramente dettati e imposti dalla componente "orientale" — "superstiziosa" — della sua personalità.
Come "orientale" — e, questa sì, senza dubbio "dionisiaca" — era la sua passionalità umana, la capacità di ridere, di inventare fulminanti battute di spirito. «Ti pettini che sembri Gino Marinuzzi», disse una volta alla figlia Eliana, comparsagli davanti all’improvviso con un taglio modernissimo. E in un’altra occasione, sempre in argomento "capelli", in risposta alla famiglia che lo incitava scherzosamente a provvedere in qualche modo alla sua calvizie, dopo avere replicato diverse volte con sdegno che mai e poi mai si sarebbe abbassato a indossare una parrucca, sbottò: «Be’, potrei farmi fare un tatuaggio trompe-l’oeil su tutto il cranio!»
Ma altrettanto "orientale" — e ben più amaramente "dionisiaca" — era la sua capacità di soffrire la malinconia. «Quali saranno state le sue serate a Santa Margherita?» si è chiesto uno dei suoi eredi artistici, Gianandrea Gavazzeni, in una commossa memoria. Santa Margherita, già, l’esilio forzato, dopo l’infarto del 1953, durante le prove della Wally di apertura della Scala. Una carriera troncata un istante prima dell’apice. Aveva sessantuno anni. Quanto avrebbe potuto darci, ancora? Fu «colpito in volo», come ha detto con espressione ispirata un altro dei suoi eredi, Carlo Maria Giulini, chiamato in tutta fretta a sostituirlo. A sostituirlo per Medea venne invece chiamato un altro "dionisiaco" per eccellenza, Leonard Bernstein, il «carissimo Lenny» di tante lettere. Preparò l’opera in sei giorni, facendo tesoro — ha ricordato lo stesso Bernstein — della preziosa e affettuosa assistenza del Maestro malato. Ne venne un’edizione memorabile (con Callas, Barbieri, Modesti), che per fortuna la registrazione dal vivo ci ha tramandato. Così come memorabile fu l’esecuzione della Sonnambula del ’55 (con Callas, Valletti, Modesti), anch’essa per fortuna ascoltabile in disco dal vivo. Per Bohème, Bernstein venne addirittura assistito dalle quinte. Esecuzioni memorabili, certo, ma che cosa avrebbero potuto essere se guidate dalla bacchetta fulminante, dal gesto "danzante" ma "inequivocabile" di de Sabata, dalla sua memoria infallibile, dalla sua coazione alla massima precisione tecnica? Quali "fortissimi" avremmo avuto. Quali "pianissimi"?
Il "se", in questi casi, non ha purtroppo senso. Non lo sapremo mai. Il Maestro viveva il suo esilio di Santa Margherita. E di quale intensità potesse essere la sua malinconia, la nostalgia del gusto, del fuoco, dei colori, degli umori, degli afrori del teatro, il suo invincibile e irreversibile tedium vitae, possiamo trarre un’idea dalle espressioni di una ben nota lettera inviata al figlio Elio in data 18 luglio 1961, in cui invocava il suo aiuto per comperare un’automobile con cambio automatico, che gli consentisse una maggiore mobilità, lo aiutasse a togliersi almeno un poco dall’impasse vitale in cui era precipitato. Espressioni apparentemente banali, ma quanto rivelatorie: «...non è un po’ pietoso, il mio stato? Tutti sono motorizzati, tutti hanno due gambe, tutti possono spostarsi a piacimento. Io, che mi sono guadagnato la vita per me e per voi in piedi, sudando per più di 40 anni, col cuore che mi scoppiava davanti a milioni di persone, devo camminare stentatamente...». Si sentiva "scoppiare il cuore" — e infatti così sarebbe avvenuto, uno sfortunato giorno di massacrante lavoro —, mentre i critici impietosi ritenevano che "si esibisse" a galeotto beneficio della platea più borghesemente epatabile, per poi chiudersi in un silenzio altezzoso e impenetrabile da sdegnoso primo della classe.
Quanta amarezza traspare dall’apparente scherzosità della seguente "intervista" fatta da de Sabata a se stesso durante l’esilio: «Non do interviste, ma non sono un cattivaccio con i giornalisti. Li rispetto, anzi, rispetto il loro lavoro, la loro vita quotidiana affannosa, spesso competitiva, spesso incompresa, e ho una grande voglia che si distrugga una leggenda... Posso chiedervi un gesto di cordialità? Una testimonianza di calore umano? Cercate di cancellare la leggenda che io rifugga con alterigia, che io non mi degni di lasciarmi intervistare...». E conclude: «Ogni intervista mi ha lasciato sempre amaro». Chissà se, dall’Olimpo della Musica, dagli appartamenti di Euterpe, dove sicuramente è stato accolto, può leggere o sentire (e vedere!) e immalinconirsi di certe interviste di oggi a tanti suoi colleghi servitori delle più disparate Muse.
Ma un’idea ben più dolorosa del suo perenne, invincibile spleen possiamo trarre da una serie di lettere privatissime, inedite ma fortunatamente recuperate da Marco Contini, da lui scritte a Umberto Giordano, cui era legato da un profondo legame di amicizia e aperta confidenza. Non appartengono a quel periodo, sono molto precedenti, risalgono agli anni Trenta e soprattutto Quaranta. In quei giorni il Maestro aveva accanto a sé un nuovo affetto, segretissimo — indicato prima soltanto con un tenero nomignolo e poi scopertamente con il nome (in questa sede non pare opportuno ricordarlo: si sta parlando della vita artistica di un uomo, non di quella privata) —, eppure del tutto insufficiente a placare l’amarezza del "mestiere di vivere" che da quelle lettere promana, facendone un grimaldello prezioso per cercare di penetrare i «molti segreti interni» di quel carattere «turbolento» e malinconico. Anzitutto, per tanti piccolissimi accenni (compaiono in quasi ogni lettera), alle pastoie imposte a questo carattere dalla fisicità.
La "fisicità". Abbiamo visto quanto fosse importante per determinare il "gesto" particolarissimo del maestro, la sua "danza sul podio", gli elementi di magnetismo che sapeva trasmettere all’orchestra, ai cantanti e al pubblico. Ma fu importante anche in negativo. Si rammenti che de Sabata fu «colpito in volo» due volte. La seconda con l’infarto del 1953, che portò all’esilio di Santa Margherita. La prima quando aveva, bambino, contratto la poliomielite. Scriveva il 23 ottobre 1947, appunto a Umberto Giordano, da Roma: «Io non sto ancora bene. Ho dovuto buttare all’aria mezza Europa causa questa nevralgia alla gamba che mi ha costretto a rompere una quantità di impegni. Ne sono spaventato. Una banale indisposizione che, oggi, provoca tali guai per me (e non solo per me) è cosa mortificante e che mi mette in uno stato di ribellione non certo propizio per i miei nervi. Questo rimanga fra noi.»
E già gli aveva scritto il 18 gennaio 1944: «Giorni di depressione, per me, dalla tua cara ultima; quei giorni che anche tu mi dici di provare, a volte dove si ha perfino riguardo di far udire la propria voce e la propria melanconia anche alle persone che ci sono più care... E, melanconicamente, si giunge al solito risultato: lasciar operare le circostanze... Io non sto tanto bene... un malessere generale che mi deprime molto... Tutto incerto, tutto difficile...». E un 31 dicembre di un anno imprecisato: «Mai nervi d’uomo (e quali nervi sono i nostri!) sono stati messi a prova più impegnativa!... Qui, per noi, giorni balordi e grigi...».
Ma soprattutto, il 7 novembre 1948, da Pittsburgh: «Mi ricordo sempre la descrizione tua di uno dei tuoi incontri con Verdi! "Le mie gambe!" A parte ogni irriverente accostamento, le mie, dopo quella nevralgia dell’anno scorso, sono continuamente messe, proprio per il mio bel mestiere, alle prove più incredibili! Ci sarebbe da ridere, per questo mio destino grottesco, se non ci fosse da piangere. E avanti!» Già: "the show must go on", costi quel che costi. De Sabata non poteva sapere — oppure, da "orientale" attento al senso arcano degli eventi, presagiva? — quale prova ben più fatale gli riservasse il destino "grottesco".
Ma quanto bastavano le contrarietà di natura fisica ad avvelenargli la vita. Diceva ancora la stessa lettera: «Ti scrivo dal mio letto, in una di quelle notti che l’insonnia ti rende roventi e i pensieri sono torturati da mille domande senza risposta e da ribellioni di cui l’anima si vergogna! Anch’io, credimi, sto lottando contro mille diavoli! Le forze che mi abbandonano, difficoltà di ogni genere, dolorosa apatia che toglie ad ogni mio sacrificio, ad ogni mio sforzo ogni interesse ed ogni compenso nell’averlo compiuto!... E gli anni passano, e che cosa ho veramente concluso, gli applausi?» Come gli pesava, evidentemente, il cruccio del suo lavoro di compositore, messo in second’ordine e poi praticamente abbandonato, per motivi di cui si può soltanto tentare di abbozzare una spiegazione, forzatamente psicologistica, lasciando ad altri, di superiore cultura musicale, di valutarne esiti e limiti.
De Sabata fu accusato di passatismo. Era vero? È un’accusa che colpisce spesso chi, nella sua attività creativa, si rifiuta di prescindere da un rigoroso bagaglio di preparazione tecnica. È un imperativo di natura anzitutto morale. Prima di "fare" bisogna "saper fare". Allo stesso titolo, oggi, capita che venga tacciato di passatismo chi sia fermamente convinto che, per scrivere, è un dovere imprescindibile la conoscenza se non altro di consecutio, condizionali, congiuntivi e punteggiatura. Pazienza. De Sabata si ribellava con forza al giudizio, citando le diverse creazioni o esecuzioni montecarline, la prima esecuzione della Sinfonia di Pizzetti, l’amicizia e il sostegno dato a giovani colleghi (Ghedini, Clausetti). Si pensi al suo repertorio di direttore. I grandi classici, certo. Beethoven, Brahms, Schumann; Rossini e Verdi (ma quale fu la sua "restaurazione" del Macbeth: per fortuna abbiamo la registrazione live a ricordarcene tutta la modernità; la qualità del suono è scarsa, ma che cosa importa? Il fuoco dell’esecuzione in teatro, Maria Callas al vertice della voce, i comprimari guidati con mano sapientissima ne fanno tuttora una delle edizioni di referenza).
Ma anche tanto Berlioz e Wagner (i suoi Tristani!). E Richard Strauss (ma, certo, a quei tempi si sosteneva da più parti che anche Strauss era un passatista ampolloso e pompiere). E un Puccini svelato nelle sue misconosciute raffinatezze (La rondine — da lui affrontata prestissimo e segnalata tra le partiture più preziose del compositore lucchese —, Il tabarro, tanto inviso a Toscanini). E Ravel, e Debussy, e Strawinski, e Kodàly, e giù e giù... Eppure, sebbene brillantemente diplomato in "composizione", oltre ai piccoli lavori di apprendistato, compose soltanto un’opera (Il macigno, 1917); tre poemi sinfonici (Juventus, 1919, La notte di Platon, 1924 e Gethsemani, 1925); un balletto (Mille e una notte, 1931) e le musiche di scena per una duplice esecuzione per la Biennale veneziana del Mercante di Venezia (1934-35). Poi il silenzio, anche negli anni dell’esilio dal podio. Come mai? In questa sede si può abbozzare soltanto una spiegazione, ripeto, di natura psicologistica. L’artista-artigiano (l’esecutore, il traduttore) che dedica con scrupolosa cura gran parte del suo tempo creativo alla riproduzione dell’arte di altri, rischia di affondare nell’esegesi del linguaggio di questi creatori e delle loro problematiche strutturali al punto da trascurare e perdere di vista i propri, e con essi il proprio slancio vitale, condannandosi al timore reverenziale, al silenzio creativo, alla depressione, alla malinconia.
Fu in preda a queste e altre malinconie di natura fisica ed esistenziale che il maestro visse gli ultimi quattordici anni della sua vita in forzato esilio, pur tra grandi progetti e arditi slanci di speranza. Aveva promesso a Franco Abbiati che sarebbe tornato alla Scala per un altro Tristano, per il quale sperava di avere la Nilsson. Voleva dirigere la Carmen, ma non riuscì nell’impresa. Che cosa ci avrebbe dato, con il suo magnetismo infuocato? A chi scrive qui viene in mente, per comparazione, lo splendido retaggio lasciatoci da un altro grande signore della musica, già più volte citato in precedenza a confronto con il Nostro: Sir Thomas Beecham. Se con lui l’orchestra diventava "infuocata" e con de Sabata "incandescente", che Carmen avremmo avuto, ad arricchire la purtroppo esile eredità di registrazioni del Nostro? E che cosa potremmo capire in più, da una registrazione cinematografica, del suo famoso "gesto", della sua "danza" sul podio, noi che non abbiamo potuto vederlo dirigere? Non ce ne sono, passiamo soltanto immaginarlo. Abbiamo soltanto molte fotografie, che, per quanto sembrino vibrare di movimento ed emozione, sono purtroppo immobili.
A noi, ammiratori postumi, rimane soltanto da immaginare che cosa avremmo potuto avere da un suo Parsifal, opera di cui, salvo errore, diresse soltanto "L’incantesimo del Venerdì Santo" e qualche altro brano in concerto. E di quali documenti straordinari disporremmo se la pur povera tecnica del tempo fosse riuscita a captare uno dei suoi Cavaliere della rosa. O un Boris. E se avessimo un suo Ring, o anche soltanto una testimonianza registrata delle parti da lui dirette (Valchiria — quella dell’aprile 1949 alla Scala, per esempio, con Lorenz, List, Franz, Reining, Flagstad, Roengen...) — e Crepuscolo)... E ancora un po’ di Rossini (Cenerentola, Gazza ladra), oltre allo sfolgorante Barbiere... O un’edizione completa della Bohème e dello Chénier del ’49, di cui ci rimane soltanto qualche frammento... E si perdoni il riferimento quasi esclusivo all’opera: ciascuno ha la sua "passion predominante". Ma quale emozione, quante scoperte si fanno ascoltando le Sinfonie di Beethoven dirette da de Sabata, o la Quarta di Brahms, o i pochi pezzi di Ravel e Debussy che ci sono rimasti...
Si pensi, inoltre, che cosa ci avrebbe potuto regalare un proseguimento del rapporto così felicemente iniziato con il connubio artistico Maria Callas - Giuseppe Di Stefano, oltre alla tuttora insuperata Tosca del `53: «.... the most thrilling recorded performace of any opera I have heard. Che maestria, sensibilità, passione...», gli scriveva al proposito ancora nel 1961 Leonard Bernstein. A che cosa avrebbe potuto darci, con lui — in un elettrizzante connubio di tragiche sensibilità "greculo-orientali" —, la grande Maria, oltre al livido, angoscioso ma vibrante Macbeth captato dal vivo all’apertura della stagione scaligera 1952-53.
Dal vivo, dal vivo, dal vivo. Per fortuna esistono almeno queste registrazioni, e la pertinacia collezionistica di chi le ha raccolte e conservate. Le testimonianze desabatiane da studio sono infatti molto poco. Una sinfonia di Beethoven. Due brani dei Nocturnes di Debussy. La Tosca. Il Requiem. Un po’ di brani orchestrali. Nient’altro, salvo errore. Un bagaglio ben misero, se rapportato a un trentennio di attività direttoriale. Anche qui, come mai? Il peso del continuo correre di teatro in teatro, si può ipotizzare. La fenomenologica convinzione dell’unicità e irripetibilità dell’evento musicale: «Il direttore ha nella sua bacchetta la sua misura», ha dichiarato in un’intervista a Leonida Repaci, «la sua idea dell’opera, di quegli elementi che si chiamano melos; ma... egli non può ripeterle meccanicamente... perché stasera non è quello di ieri sera ed è diverso il suo cuore come sono diversi gli spiriti e i cuori di tutti i componenti del complesso orchestrale... Egli deve, ogni sera, trovare quella tal cosa che sta tra le righe della partitura...»
E, soprattutto, uno sdegnoso senso di autocritica, di scarsa sicurezza — data la "mania" perfezionista — circa i risultati tecnici ottenibili dovendo tenere conto di tanti fattori limitativi. Soprattutto, e certamente non ultime, delle limitazioni "commerciali", "editoriali" e "di immagine" che vengono inevitabilmente imposte dalle case editrici musicali. Quante critiche ricevette de Sabata — più o meno velate, più o meno maliziose — per avere usato, nel famoso Requiem discografico, la voce di Elisabeth Schwarzkopf. Una voce così leggera, di educazione tedesca... Non lo aveva per caso fatto perché nel frattempo Elisabeth era diventata la signora Legge, la moglie del deus ex machina della EMI, casa editrice del disco? Sì, certo, una scelta che si può discutere, ma i critici superficiali dimenticavano — «La calunnia è un venticello...» — che de Sabata aveva già impiegato la Schwarzkopf nel ’51, in un’esecuzione pubblica del Requiem a Venezia, nell’ambito delle celebrazioni del cinquantenario verdiano. Ma sono abbozzi di spiegazione vaghi quanto insufficienti. Forse, se non fosse intervenuto il tragico "colpo in volo" del 1953... Chi può sapere? Certo avremmo di più. I grandissimi anni Cinquanta della Scala (anche discograficamente parlando) erano lì lì per fiorire, da lui preparati, da lui seguiti con amorosa cura nella veste effettiva di Sovrintendente Artistico (e poi in quella puramente onorifica — e gratuita — di Alto Consulente Artistico). Ma de Sabata era chiuso nel suo amaro esilio professionale ed esistenziale di Santa Margherita.
La notte tra il 10 e l’11 dicembre 1967 il suo cuore cedette di schianto un’altra volta e per sempre. La sua vicenda umana si concluse così, all’età di settantacinque anni. Pure, oltre alle testimonianze musicali, di lui rimase qualcos’altro. Qualcosa della sua persona, del suo corpo, proprio di quella "fisicità" — vedi caso — che tanto lo aveva condizionato e assillato, di quegli occhi che tanto avevano "magnetizzato" Renata Tebaldi. In punto di morte — spinto da che cosa, se non dal suo spirito "scientifico"? — aveva disposto che le sue cornee venissero donate. Per il loro tramite, una donna di Ovada, progressivamente condannata alla cecità, poté tornare a vedere bene. Quello stesso spirito scientifico aveva fatto sperare fino all’ultimo a Victor de Sabata di potersi giovare dell’imminente era dei trapianti di cuore. Ci credeva con assoluta fiducia. Non fece in tempo per pochi giorni. Il 3 di quello stesso mese il sudafricano Christiaan Barnard aveva proceduto al primo trapianto. Il momento tanto atteso sembrava arrivato. Invece, soltanto una settimana più tardi, le cose precipitarono nel senso opposto.
I funerali di de Sabata vennero celebrati in una forma identica a quelli di Toscanini. Un esame odierno dei giornali dell’epoca rivela che gli organi di informazione non diedero all’evento il rilievo che sarebbe stato lecito aspettarsi, ma i milanesi sì, e infatti si assieparono davanti alla Scala per l’ultimo saluto. L’orchestra del teatro eseguì la stessa "Marcia funebre". A dirigerla era stato designato Gianandrea Gavazzeni che, tuttavia, con gesto di grande e signorile umiltà, rinunciò. «Ero direttore artistico in questa sede [la Scala]», ha scritto. «Decidemmo che l’orchestra scaligera eseguisse senza direttore ciò che de Sabata aveva diretto per Toscanini. C’era un incontro, nel procedere dei due morti verso il Mistero, che non andava rotto da nessun’altra intrusione. Custodisco due "bacchette". Sono legate a due epoche per le quali la Scala è stata gloriosa... La "bacchetta" di Toscanini, donatami dalle figlie Wally e Wanda. La "bacchetta" di de Sabata, dono dei figli Elio e Eliana. Sono certo che nessun direttore d’orchestra cosciente dei propri limiti ardirebbe mai impugnarle.»
"Dionisiaco" e "apollineo", pertanto, finalmente riuniti nel loro ineffabile unicum d’arte. Per dare l’addio al grande maestro, l’orchestra della Scala suonò dunque da sola, guidata dalla fossa dal violino di spalla Franco Fantini. Nell’animo dei presenti, stipati nella piazza, il profondo senso di avere perduto qualcosa di irripetibile e irrecuperabile. Sul podio, vuoto, un mazzo di rose rosse.
Testo pubblicato con altri in: "Victor de Sabata", volume di grande formato, completamente illustrato e con 2 CD in cofanetto di interpretazioni rare del Maestro. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a Marco Contini, Via Botticelli, 22, 20133 Milano.