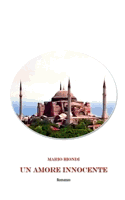Scrive di: Cormac McCarthy
1. Uno dei più bravi? Qualche riflessione
2. Sognando la vita e meditando la morte. Nuove riflessioni
(febbraio - marzo 2024)
1. Uno dei più bravi? Qualche riflessione
2. Sognando la vita e meditando la morte. Nuove riflessioni
(febbraio - marzo 2024)
© Mario Biondi
Divieto di riproduzione integrale
e obbligo di citazione (per cortesia...)
Premessa. Io non amo la violenza con i suoi corollari di sangue, ne sono disturbato se non atterrito: ne ho vissuto quanto bastava tra 1943 e 1945. Ero piccolissimo, e a maggior ragione quelle immagini e atmosfere mi sono rimaste indelebili nella memoria. Questo per quanto concerne la Realtà; in ambito di Finzione penso quindi sia un artificio rischioso se non addirittura deplorevole usarla senza ragionevoli limiti al fine di creare sconcerto e schiamazzo attorno a un’opera (sia pure d’arte ma) destinata comunque a essere fruita in maniera commerciale. È sufficiente che detta efferata violenza esista nel nostro mondo per compiacersene al fine di sconcertare il borghese (e vendergli qualcosa)? Se già esiste nella/come realtà, a che cosa serve un doppione fittizio? A raddoppiare la tendenza all’emulazione?
Concetti che ho già espresso una trentina di anni fa recensendo certa narrativa nordamericana e certe grevi scene da essa raccontate con sbrodolante gusto, a base per esempio di infelici ragazzini di colore, attirati alla prostituzione con il miraggio di poche monete e poi ammazzati con un trapano elettrico piantato nel cervello. Così, per vedere l’effetto che fa (sul lettore pagante). Nel mondo non esiste soltanto la violenza, esistono anche i matti che si esaltano nell’imitazione di gesta altrui, e con tanto maggiore entusiasmo quanto più esse sono infami. Non credo proprio che lo scrittore debba servirsi di strumenti così facilmente plateali, dispone di materiali ben più sottili: è mia convinzione personale e sento il dovere di esprimerla, oltre che ovviamente di praticarla.
Quindi, venendo al dunque, Cormac McCarthy è davvero uno degli americani più bravi, come sostenuto da Harold Bloom e tanti altri? Non so. Tutto considerato mi fido di più di un altro Bloom: il signor Leopold. Tanto per venire subito a James Joyce, nome che viene (troppo) spesso citato a proposito di McCarthy. C’entrano qualcosa, i due? Non mi pare proprio, se si eccettua il furore gesuitico con cui affrontano entrambi lancia in resta il Male. L’altra faccia di Dio, il Maligno. Ineluttabilmente destinato per altro a dominare. Cattolici irlandesi tutti e due…
Anche se il Male di McCarthy a me sembra discendere di più dalla “Darkness visible” del protestante John Milton. Basterebbe il titolo Outer Dark. La Grande Fornace dell’Inferno che non produce Luce bensì “Oscurità visibile” (Paradise Lost, 1, 61-62): Belzebù, Satana. Passando magari per L’oscuro visibile (mia traduzione voluta anche se forse filologicamente non precisissima) di William Golding, altro autore arso nell’intimo dalle fiamme del Male — ovvero Dolore — nel Mondo. Tutti grandissimi nomi. A cui il pur notevole McCormac si può apparentare ma non credo proprio equiparare.
È certamente una “Fornace”, tale da produrre un’atroce “Oscurità visibile”, il deserto tra Texas meridionale e Messico settentrionale, ovvero l’ambiente dove imperversa il Male (Satana) di McCarthy, dalle gesta del nefando Giudice Holden di Blood Meridian alle sventure di John Grady Cole e Llewelyn Moss (All the Pretty Horses e No Country for Old Men). Lo è, come lo erano le fiamme della Milano bombardata che vedevo fisicamente levarsi verso il cielo, accompagnate da orribili frastuoni, anche a una quarantina di chilometri di distanza, dalla casa comasca del nonno, dove ci eravamo rifugiati in preda a fame e terrore. Finita quella “Fornace”, durata parecchi disgraziati anni, la nostra casa milanese non esisteva più. E anche un bel pezzo della nostra vita.
Ne ho avuto abbastanza, grazie. Leggere di bambini accoppati con il trapano elettrico o sbattendogli la testa contro una roccia mi fa soltanto orrore. Non posso. Butto via il libro. Ma ci sono lettori a cui racconti simili piacciono. Per la qualità della lingua, dicono, ma io avrei più di qualche dubbio, visto che la loro lettura in genere avviene tramite una traduzione. Con il logico corollario che a essere da loro apprezzate sono caso mai le capacità linguistiche del traduttore nella sua lingua, non quelle dell’autore nell’originale. Questione vecchia e, a quanto pare, molto difficile da spiegare.
Che McCarthy sia bravo non c’è dubbio. Lo è eccome. Ma davvero, a parte il citato furore para-gesuitico, si può accostare a Joyce sotto il profilo dell’acrobazia linguistica? No. Ben al di là dell’uso del particolare anglo-irlandese di Dublino, quelli di Joyce sono capolavori di onomaturgia (creazione di parole), partendo dal latino — con qualche tentativo non altrettanto brillante di servirsi del greco, più altre lingue più o meno morte o remote — per approdare a uno stralunato, non-esistente non-inglese, completamente inventato, fantastico. Nulla di tutto ciò in McCarthy, che, pur nella sua bravura, non fa altro che scrivere (magnificamente) in un inglese particolare, la koiné in uso nel West nordamericano. Un altro inglese, insomma, uno dei tanti. Così come, per dire, Peter Carey scrive in quello dell’Australia, Abdulrazak Gurnah in quello di Zanzibar, V. S. Naipaul in quello dell’emigrazione caraibica dall’India, Robertson Davies in quello del Canada eccetera. Non vi è nessuna onomaturgia, o pochissima: basta cercare con Google un termine che si può pensare inventato da McCarthy e se ne trova la spiegazione ufficiale in questo o quel dizionario, e non sempre di uno dei molteplici slang ma semplicemente della lingua popolarmente in uso negli Stati Uniti: Webster, Random House, Collins.
Lingua contorta e stravolta ma più volte sentita e letta, dall’elevatissimo Faulkner al solido, terragno McMurtry (senza dimenticare di risalire all’icastico Fenimore Cooper). D’accordo, le terre di confine tra Texas e Messico sono evidentemente fatte così e così è bene raccontarle, in quella particolare lingua, chiunque sia a farlo. Ma sarebbe forse operazione non futile stabilire con concordata precisione chi per primo ha scritto che cosa tra McCarthy e McMurtry (pensa persino all’assonanza dei cognomi, uno del 1933 e l’altro del 1936): sia Lonesome Dove sia Blood Meridian sono del 1985. Quale dei due viene esattamente prima, quale dopo?
A prescindere dalla debita scala di valori (chi di essi è più bravo), in termini di lingua quanto di atmosfere discendono entrambi da Faulkner, ma soprattutto McCarthy. I due fratelli incestuosi di Outer Dark, per esempio, sembrano ripercorrere pari pari piste e vicende di Light in August (senza star lì a risalire fino a Siegmund e Sieglinde eccetera).
Quanto a Suttree, invece, difficile astenersi dal pensare, oltre che ai demenziali personaggi di Faulkner in The Reivers, al “Vicolo delle sardine” come intitolerei io Cannery Row prendendo atto che “Vicolo del Conservificio” rischia di essere un titolo agghiacciante. Ma di quello si tratta, del Vicolo dove si trova l’impianto (Cannery = Conservificio) dentro cui si procede a inscatolare pesce, come è pesce quello che pesca e vende lo svagato Suttree (anche se non precisamente sardine), seppure in un ambiente trasferito a livide luci di violenza che sono ignote al grande Steinbeck. Più Steinbeck che Faulkner, insomma, ma entrambi.
Non sono un frequentatore di cineforum e dintorni, eppure ho scoperto di possedere più di mille film su supporto elettronico. Una collezione che ho messo insieme a fini quasi esclusivamente professionali: onde ascoltare la lingua originale parlata dai personaggi leggendola al contempo nei sottotitoli altrettanto originali, per essere sicuro di averla capita parola per parola, e con l'accento giusto, onde applicare il meglio possibile tale conoscenza ai complicati libri che ero chiamato a tradurre. E insieme a questa scoperta ne ho fatto un’altra: che sono state proprio le riduzioni cinematografiche a tenermi lontano dai libri di Cormac McCarthy. La scarsa qualità di All the Pretty Horses, gli orgiastici uragani di violenza in cui vortica No Country for Old Men.
Così ho cominciato le mie letture da Suttree, di cui non avevo visto nessun film, subito seguito da Blood Meridian, idem. Del primo ho già detto, il secondo mi ha lì per lì inorridito e affascinato. Come fa uno scrittore, mi sono chiesto, a inventare personaggi ipersulfurei come il Giudice Holden e il sanguinario cacciatore di scalpi John Joel Glanton, oltre ad ambienti in tutto degni della famosa “Oscurità Visibile” di Milton e Co? Bisogna essere un genio della narrazione, ho pensato. Finché ho scoperto che il romanzo si basa in buona parte sulle memorie scritte ed edite di un contemporaneo dei fatti, tale Samuel Chamberlain, che ha sostenuto di aver fatto fisicamente parte per un paio di anni della sanguinaria Banda Glanton. Grande scrittura di riciclo, allora? Gnosticismo di recupero? Sono rimasto molto perplesso.
Anche di Outer Dark ho già detto: troppo Faulkner, quasi un calco, e per di più parecchio evanescente. Sono quindi finalmente passato ai due romanzi dei film di cui sopra. Una volta letto dopo il pugno nello stomaco cinematografico infertomi dai fratelli Cohen, No Country for Old Men ha per me purtroppo perso ogni tensione, rischiando persino di diventare noioso. Un catalogo di sparatorie, non di rado persino di complicata attribuzione. Chi ha sparato a chi? Lo psico-assassino seriale Anton Chighur è in definitiva una replica (vent’anni esatti dopo) dello psicopatico massacratore John Glanton, e la malinconia del “vecchio” sceriffo Bell borbotta luoghi piuttosto comuni una volta messa a confronto con quella molto più articolata e partecipabile del ragazzo John Grady Cole di All the Pretty Horses. Il migliore, a mio parere, dei romanzi di McCarthy che ho letto. Che belle le pagine in cui racconta il suo amaro affetto per i vecchi messicani che l’hanno fatto crescere in solitudine. E che splendore di dignità i racconti della vecchia nobildonna messicana. Lì davvero McCarthy è grande.
Però sembra subito pentirsi e farsi travolgere di nuovo dall’ansia di immergere il suo testo in fiumi di sangue. Un’ansia che (mi pare) gli impedisce di ricordare che il ragazzo Cole ha soltanto quasi diciassette anni, oltre a essere in quel momento sopravvissuto a stento a un autentico massacro fisico personale. Come fa a cavarsela da solo — dovendo al contempo tenere a bada tre cavalli —, con il “capitano” e con i suoi accoliti, tutti armati fino ai denti, riuscendo addirittura a rapire il primo? E tutto l’itinerario a rotta di collo verso il Rio Grande e il Texas? Come fa a superarlo indenne? E come fa, sempre ad anni diciassette, a risultare così convincente con il giudice texano cui consegna il cavallo dello sfortunato (tredicenne!) Blevins? A parte la poco credibile considerazione in cui già lo teneva l’hidalgo messicano, uomo di gran mondo, latifondista addirittura in qualche modo discendente dallo sfortunato presidente Madero o perlomeno dal suo entourage di classe dirigente nobiliare spagnola. Un sedicenne? Perché mai? Va be’, lo sappiamo: perché gli infuocati territori del West sono un “paese non per vecchi” (dove domina il Male).
Bellissime comunque le pagine finali in cui il diciassettenne, novello Shane, si allontana in solitudine verso il chissà dove come Il cavaliere della valle solitaria Alan Ladd, senza però che nessun simbolo dell’innocenza perduta, in lacrime, lo chiami disperatamente indietro: Shane! Come back, Shane! Settant’anni fa… qualcuno se ne ricorda? E quaranta circa dopo un altro Cavaliere, quello pallido, ovvero il Predicatore Clint Eastwood. Sempre Apocalisse, Gnosi e dintorni, anche se queste due volte nella luce del Bene. Luogo complicato, il West degli Stati Uniti, da affrontare sapendo citare a memoria i testi sacri, cattolici e protestanti, canonici e gnostici…
Conclusione. Autore senz’altro notevolissimo, Cormac McCarthy, capace di maneggiare da vero maestro la lingua, ma la sua, non quella dei bravi traduttori, e in ogni caso di multiforme difficoltà, da assumere con estrema cautela in assenza di prescrizione medica…
II.
Sì, nuove riflessioni, indispensabili. Cormac McCarthy è uno scrittore singolare, di lettura (e digeribilità) tutt’altro che facile, ma al tempo stesso difficile da abbandonare: induce sempre, quasi costringe, a ulteriori letture. Quindi è davvero, se forse non proprio grande, un autore almeno importante. Finché, eventualmente, non gli prendono i cinque minuti e fa di tutto per diventare indigesto. Che bisogno avrà avuto, per esempio, di far succhiar fuori gli occhi a un misero messicano — letteralmente succhiar fuori, aspirando con le labbra, e con accuratissima descrizione — in The Crossing? Un romanzo che per altro si legge con grande gusto fino (ma anche dopo) il meticoloso, puntiglioso racconto degli occhi succhiati fuori e lasciati lì penduli dalle orbite, come corollario alla già allegra vicenda del fratellino quattordicenne sparato, che è il vero personaggio su cui ruota la trama del romanzo e poi anche del successivo Cities of the Plain.
Qualche pagina prima, però, ci sono le straordinarie scene della cenciosa compagnia girovaga di opera che rappresenta I pagliacci nelle comuni del Messico rurale anni Quaranta. Con quella prima donna che sembra un mirabile calco della Callas (morta) vista da Fellini in E la nave va. Semplicemente meravigliosa. Quanto Fellini trasuda dai testi di McCarthy. Sempre, però, con una sulfurea tendenza a convertirsi in Ingmar Bergman. Volutamente o inconsapevolmente? Non saprei dire. Splendide, comunque, le sopra citate scene, che denotano un’intima conoscenza da parte dell’autore della cultura messicana, molto al di là della padronanza della lingua spagnola che costella tutti i suoi testi “di confine”. Temo che quasi nessuno ricordi più il contributo dato dal Messico ispanico, con il Teatro della sua capitale, alla cultura dell’opera lirica. Insieme per altro a quasi tutto il Sudamerica, e queste scene di The Crossing, oltre che al Fellini del 1983, rimandano direttamente al furore operistico sudamericano del film Fitzcarraldo, che è del 1982. Digressione conclusa, proseguo.
“È del poeta il fin la meraviglia - (parlo de l’eccellente e non del goffo): - chi non sa far stupir, vada alla striglia!” cantava Giambattista Marino, versi che (oltre ai poeti) ogni narratore dovrebbe avere fissi nella mente, come fissi nella mente mostra di averli Cormac McCarthy, autore non certamente “goffo” ma anzi strepitoso quanto a uso della lingua, quel famoso americano “della frontiera” cui ho già accennato, letterariamente proposto da Fenimore Cooper un secolo e mezzo prima di lui: “Venti milioni di persone possono non soltanto fare un mondo, ma anche una lingua, se occorre”. Una lingua, nella fattispecie, composta essenzialmente dallo sgrammaticato inglese dei primi coloni britannici (they - theys, invece di there is, caint invece di can’t, semplicemente ’d invece di had o would, sumbuck invece di son of bitch, hoss invece di horse eccetera) in cui si innestano il tedesco e l’olandese dei secondi venuti più il francese masticato dai pellerossa del Nord e in seguito lo spagnolo storpiato da quelli del Sud.
Una lingua che evidentemente “occorreva”, visto che è poi stata usata da ben più di venti milioni di persone, tra cui anche molti scrittori, seppure con esiti non sempre ugualmente elevati, da Steinbeck e soprattutto Faulkner in giù. Eccelsi, gli esiti, nel caso di McCarthy, e qui arrivato non posso fare a meno di rendere omaggio ai suoi traduttori: quale che ne sia il risultato, il solo impegno a cercar di rendere quell’americano in un’altra lingua è commendevole in sé. Già leggerlo in originale impone di avere a disposizione (e saper usare) un formidabile apparato di esegesi: dizionari, repertori, manuali, motori di ricerca eccetera.
Dopo Not a Country for Old Men (per me più che deludente), avevo deciso di non leggere più niente di suo, ma poi non ho potuto farlo: rimuginando su All the Pretty Horses — il libro, non il film, molto mediocre —, quasi senza accorgermene mi son trovato a continuare. Avendo ormai definitivamente deciso che, a parte probabilmente la pecunia — mai eccessiva per uno scrittore e in genere appena sufficiente —, il cinema non ha davvero reso un buon servizio a McCarthy e al contrario lo ha svilito. La seconda e la terza parte della “Trilogia”, che per adesso sembra Hollywood non sia stata capace di sconciare, sono una grande lettura quasi come la prima. E, ancora una volta, soprattutto sotto il profilo di prosa e lingua. Che maestro. Le trame invece sono quel che sono, non di rado pasticciate e tirate avanti a strattoni; i personaggi non sono precisamente credibili; e sui finali l’autore avrebbe potuto riflettere più a lungo. Se quello di Horses è di amarissima bellezza, per altro perfettamente inserito nel ricco filone western del “Cavaliere Solitario”, quelli degli altri due non lo sono. Troppo strascicati.
Soprattutto quello di Cities of the Plain. Al cui proposito non riesco a esimermi dal far notare che il titolo italiano è ancora una volta poco corretto. È una citazione dalla Genesi, signori, 19:29: nel testo italiano cattolico (e anche interconfessionale) Sodoma e Gomorra sono le città della “valle”, non della “pianura”: “Così, quando distrusse le città della valle dove Lot aveva abitato…” Sempre che la Bibbia abbia una qualche importanza, ma per il cattolico McCarthy ce l’ha senz’altro, e anzi è essenziale. Tornando comunque a noi, un finale troppo filosofeggiante e pochissimo convincente. Certo, l’autore cerca di mettere in scena la Morte, passando dalle tonalità di Fellini a quelle di Bergman, impresa certamente non agevole e che non gli riesce bene. Un finale, inoltre e soprattutto, che contraddice se non addirittura rinnega quello che sembrava essere l’assunto principale della filosofia di McCarthy, ovvero che il West non sarebbe “un paese per vecchi”. A veder bene lo è eccome: gli unici dei giovinetti della “Trilogia” a sfangarsela sono anche gli unici che riescono a diventare vecchi: sicuramente Billy Parham e forse Lacey Rawlins, che però potrebbe anche essere morto a poco più di vent’anni. Tremenda la fine degli altri, che se ne vanno giovanissimi in varie modalità di strazio. Nell’ordine: Jimmy Blevins, Boyd Parham, John Cole Grady…
Il fatto si è che i giovani raccontati da McCarthy non sono giovani. Agiscono, borbottano, ragionano da vecchi, nascono già vecchi. Dall’assennatissimo quattordicenne di The Orchard Keeper fino ai cinque della “Trilogia” attraverso il “kid” di Blood Meridian. Non leggono quasi niente o niente del tutto — ricordo soltanto Billy Parham che a un certo punto, sdraiato nel suo giaciglio di cowboy, ha tra le mani Destry Rides Again, vedi caso di Max Brand, onestissima gallina della letteratura western — ma trovano di continuo modo di effondersi in contorte discettazioni filosofiche — sul senso della realtà, della vita (come sogno) e della morte — con pensosissimi personaggi di campagna, deserto o chiesa, fino alla presunta Morte al di là del cui sogno va a concludersi Cities.
Con il corollario del millenarismo privo di speranza celato dietro la miltoniana “darkness visible (oscurità, buio visibile)”: «Penso vedesse apparire [quindi farsi visibile, interpreto io] una terribile oscurità», dice verso la fine di Cities la presunta Morte parlando del personaggio di cui essa stessa ha visto in sogno il sogno… E: «Nights dark beyond darkness… (Notti buie al di là del buio…)» vedrà già nelle primissime righe di The Road il padre senza speranza di salvezza…
Concetti che ho già espresso una trentina di anni fa recensendo certa narrativa nordamericana e certe grevi scene da essa raccontate con sbrodolante gusto, a base per esempio di infelici ragazzini di colore, attirati alla prostituzione con il miraggio di poche monete e poi ammazzati con un trapano elettrico piantato nel cervello. Così, per vedere l’effetto che fa (sul lettore pagante). Nel mondo non esiste soltanto la violenza, esistono anche i matti che si esaltano nell’imitazione di gesta altrui, e con tanto maggiore entusiasmo quanto più esse sono infami. Non credo proprio che lo scrittore debba servirsi di strumenti così facilmente plateali, dispone di materiali ben più sottili: è mia convinzione personale e sento il dovere di esprimerla, oltre che ovviamente di praticarla.
Quindi, venendo al dunque, Cormac McCarthy è davvero uno degli americani più bravi, come sostenuto da Harold Bloom e tanti altri? Non so. Tutto considerato mi fido di più di un altro Bloom: il signor Leopold. Tanto per venire subito a James Joyce, nome che viene (troppo) spesso citato a proposito di McCarthy. C’entrano qualcosa, i due? Non mi pare proprio, se si eccettua il furore gesuitico con cui affrontano entrambi lancia in resta il Male. L’altra faccia di Dio, il Maligno. Ineluttabilmente destinato per altro a dominare. Cattolici irlandesi tutti e due…
Anche se il Male di McCarthy a me sembra discendere di più dalla “Darkness visible” del protestante John Milton. Basterebbe il titolo Outer Dark. La Grande Fornace dell’Inferno che non produce Luce bensì “Oscurità visibile” (Paradise Lost, 1, 61-62): Belzebù, Satana. Passando magari per L’oscuro visibile (mia traduzione voluta anche se forse filologicamente non precisissima) di William Golding, altro autore arso nell’intimo dalle fiamme del Male — ovvero Dolore — nel Mondo. Tutti grandissimi nomi. A cui il pur notevole McCormac si può apparentare ma non credo proprio equiparare.
È certamente una “Fornace”, tale da produrre un’atroce “Oscurità visibile”, il deserto tra Texas meridionale e Messico settentrionale, ovvero l’ambiente dove imperversa il Male (Satana) di McCarthy, dalle gesta del nefando Giudice Holden di Blood Meridian alle sventure di John Grady Cole e Llewelyn Moss (All the Pretty Horses e No Country for Old Men). Lo è, come lo erano le fiamme della Milano bombardata che vedevo fisicamente levarsi verso il cielo, accompagnate da orribili frastuoni, anche a una quarantina di chilometri di distanza, dalla casa comasca del nonno, dove ci eravamo rifugiati in preda a fame e terrore. Finita quella “Fornace”, durata parecchi disgraziati anni, la nostra casa milanese non esisteva più. E anche un bel pezzo della nostra vita.
Ne ho avuto abbastanza, grazie. Leggere di bambini accoppati con il trapano elettrico o sbattendogli la testa contro una roccia mi fa soltanto orrore. Non posso. Butto via il libro. Ma ci sono lettori a cui racconti simili piacciono. Per la qualità della lingua, dicono, ma io avrei più di qualche dubbio, visto che la loro lettura in genere avviene tramite una traduzione. Con il logico corollario che a essere da loro apprezzate sono caso mai le capacità linguistiche del traduttore nella sua lingua, non quelle dell’autore nell’originale. Questione vecchia e, a quanto pare, molto difficile da spiegare.
Che McCarthy sia bravo non c’è dubbio. Lo è eccome. Ma davvero, a parte il citato furore para-gesuitico, si può accostare a Joyce sotto il profilo dell’acrobazia linguistica? No. Ben al di là dell’uso del particolare anglo-irlandese di Dublino, quelli di Joyce sono capolavori di onomaturgia (creazione di parole), partendo dal latino — con qualche tentativo non altrettanto brillante di servirsi del greco, più altre lingue più o meno morte o remote — per approdare a uno stralunato, non-esistente non-inglese, completamente inventato, fantastico. Nulla di tutto ciò in McCarthy, che, pur nella sua bravura, non fa altro che scrivere (magnificamente) in un inglese particolare, la koiné in uso nel West nordamericano. Un altro inglese, insomma, uno dei tanti. Così come, per dire, Peter Carey scrive in quello dell’Australia, Abdulrazak Gurnah in quello di Zanzibar, V. S. Naipaul in quello dell’emigrazione caraibica dall’India, Robertson Davies in quello del Canada eccetera. Non vi è nessuna onomaturgia, o pochissima: basta cercare con Google un termine che si può pensare inventato da McCarthy e se ne trova la spiegazione ufficiale in questo o quel dizionario, e non sempre di uno dei molteplici slang ma semplicemente della lingua popolarmente in uso negli Stati Uniti: Webster, Random House, Collins.
Lingua contorta e stravolta ma più volte sentita e letta, dall’elevatissimo Faulkner al solido, terragno McMurtry (senza dimenticare di risalire all’icastico Fenimore Cooper). D’accordo, le terre di confine tra Texas e Messico sono evidentemente fatte così e così è bene raccontarle, in quella particolare lingua, chiunque sia a farlo. Ma sarebbe forse operazione non futile stabilire con concordata precisione chi per primo ha scritto che cosa tra McCarthy e McMurtry (pensa persino all’assonanza dei cognomi, uno del 1933 e l’altro del 1936): sia Lonesome Dove sia Blood Meridian sono del 1985. Quale dei due viene esattamente prima, quale dopo?
A prescindere dalla debita scala di valori (chi di essi è più bravo), in termini di lingua quanto di atmosfere discendono entrambi da Faulkner, ma soprattutto McCarthy. I due fratelli incestuosi di Outer Dark, per esempio, sembrano ripercorrere pari pari piste e vicende di Light in August (senza star lì a risalire fino a Siegmund e Sieglinde eccetera).
Quanto a Suttree, invece, difficile astenersi dal pensare, oltre che ai demenziali personaggi di Faulkner in The Reivers, al “Vicolo delle sardine” come intitolerei io Cannery Row prendendo atto che “Vicolo del Conservificio” rischia di essere un titolo agghiacciante. Ma di quello si tratta, del Vicolo dove si trova l’impianto (Cannery = Conservificio) dentro cui si procede a inscatolare pesce, come è pesce quello che pesca e vende lo svagato Suttree (anche se non precisamente sardine), seppure in un ambiente trasferito a livide luci di violenza che sono ignote al grande Steinbeck. Più Steinbeck che Faulkner, insomma, ma entrambi.
Non sono un frequentatore di cineforum e dintorni, eppure ho scoperto di possedere più di mille film su supporto elettronico. Una collezione che ho messo insieme a fini quasi esclusivamente professionali: onde ascoltare la lingua originale parlata dai personaggi leggendola al contempo nei sottotitoli altrettanto originali, per essere sicuro di averla capita parola per parola, e con l'accento giusto, onde applicare il meglio possibile tale conoscenza ai complicati libri che ero chiamato a tradurre. E insieme a questa scoperta ne ho fatto un’altra: che sono state proprio le riduzioni cinematografiche a tenermi lontano dai libri di Cormac McCarthy. La scarsa qualità di All the Pretty Horses, gli orgiastici uragani di violenza in cui vortica No Country for Old Men.
Così ho cominciato le mie letture da Suttree, di cui non avevo visto nessun film, subito seguito da Blood Meridian, idem. Del primo ho già detto, il secondo mi ha lì per lì inorridito e affascinato. Come fa uno scrittore, mi sono chiesto, a inventare personaggi ipersulfurei come il Giudice Holden e il sanguinario cacciatore di scalpi John Joel Glanton, oltre ad ambienti in tutto degni della famosa “Oscurità Visibile” di Milton e Co? Bisogna essere un genio della narrazione, ho pensato. Finché ho scoperto che il romanzo si basa in buona parte sulle memorie scritte ed edite di un contemporaneo dei fatti, tale Samuel Chamberlain, che ha sostenuto di aver fatto fisicamente parte per un paio di anni della sanguinaria Banda Glanton. Grande scrittura di riciclo, allora? Gnosticismo di recupero? Sono rimasto molto perplesso.
Anche di Outer Dark ho già detto: troppo Faulkner, quasi un calco, e per di più parecchio evanescente. Sono quindi finalmente passato ai due romanzi dei film di cui sopra. Una volta letto dopo il pugno nello stomaco cinematografico infertomi dai fratelli Cohen, No Country for Old Men ha per me purtroppo perso ogni tensione, rischiando persino di diventare noioso. Un catalogo di sparatorie, non di rado persino di complicata attribuzione. Chi ha sparato a chi? Lo psico-assassino seriale Anton Chighur è in definitiva una replica (vent’anni esatti dopo) dello psicopatico massacratore John Glanton, e la malinconia del “vecchio” sceriffo Bell borbotta luoghi piuttosto comuni una volta messa a confronto con quella molto più articolata e partecipabile del ragazzo John Grady Cole di All the Pretty Horses. Il migliore, a mio parere, dei romanzi di McCarthy che ho letto. Che belle le pagine in cui racconta il suo amaro affetto per i vecchi messicani che l’hanno fatto crescere in solitudine. E che splendore di dignità i racconti della vecchia nobildonna messicana. Lì davvero McCarthy è grande.
Però sembra subito pentirsi e farsi travolgere di nuovo dall’ansia di immergere il suo testo in fiumi di sangue. Un’ansia che (mi pare) gli impedisce di ricordare che il ragazzo Cole ha soltanto quasi diciassette anni, oltre a essere in quel momento sopravvissuto a stento a un autentico massacro fisico personale. Come fa a cavarsela da solo — dovendo al contempo tenere a bada tre cavalli —, con il “capitano” e con i suoi accoliti, tutti armati fino ai denti, riuscendo addirittura a rapire il primo? E tutto l’itinerario a rotta di collo verso il Rio Grande e il Texas? Come fa a superarlo indenne? E come fa, sempre ad anni diciassette, a risultare così convincente con il giudice texano cui consegna il cavallo dello sfortunato (tredicenne!) Blevins? A parte la poco credibile considerazione in cui già lo teneva l’hidalgo messicano, uomo di gran mondo, latifondista addirittura in qualche modo discendente dallo sfortunato presidente Madero o perlomeno dal suo entourage di classe dirigente nobiliare spagnola. Un sedicenne? Perché mai? Va be’, lo sappiamo: perché gli infuocati territori del West sono un “paese non per vecchi” (dove domina il Male).
Bellissime comunque le pagine finali in cui il diciassettenne, novello Shane, si allontana in solitudine verso il chissà dove come Il cavaliere della valle solitaria Alan Ladd, senza però che nessun simbolo dell’innocenza perduta, in lacrime, lo chiami disperatamente indietro: Shane! Come back, Shane! Settant’anni fa… qualcuno se ne ricorda? E quaranta circa dopo un altro Cavaliere, quello pallido, ovvero il Predicatore Clint Eastwood. Sempre Apocalisse, Gnosi e dintorni, anche se queste due volte nella luce del Bene. Luogo complicato, il West degli Stati Uniti, da affrontare sapendo citare a memoria i testi sacri, cattolici e protestanti, canonici e gnostici…
Conclusione. Autore senz’altro notevolissimo, Cormac McCarthy, capace di maneggiare da vero maestro la lingua, ma la sua, non quella dei bravi traduttori, e in ogni caso di multiforme difficoltà, da assumere con estrema cautela in assenza di prescrizione medica…
II.
Sì, nuove riflessioni, indispensabili. Cormac McCarthy è uno scrittore singolare, di lettura (e digeribilità) tutt’altro che facile, ma al tempo stesso difficile da abbandonare: induce sempre, quasi costringe, a ulteriori letture. Quindi è davvero, se forse non proprio grande, un autore almeno importante. Finché, eventualmente, non gli prendono i cinque minuti e fa di tutto per diventare indigesto. Che bisogno avrà avuto, per esempio, di far succhiar fuori gli occhi a un misero messicano — letteralmente succhiar fuori, aspirando con le labbra, e con accuratissima descrizione — in The Crossing? Un romanzo che per altro si legge con grande gusto fino (ma anche dopo) il meticoloso, puntiglioso racconto degli occhi succhiati fuori e lasciati lì penduli dalle orbite, come corollario alla già allegra vicenda del fratellino quattordicenne sparato, che è il vero personaggio su cui ruota la trama del romanzo e poi anche del successivo Cities of the Plain.
Qualche pagina prima, però, ci sono le straordinarie scene della cenciosa compagnia girovaga di opera che rappresenta I pagliacci nelle comuni del Messico rurale anni Quaranta. Con quella prima donna che sembra un mirabile calco della Callas (morta) vista da Fellini in E la nave va. Semplicemente meravigliosa. Quanto Fellini trasuda dai testi di McCarthy. Sempre, però, con una sulfurea tendenza a convertirsi in Ingmar Bergman. Volutamente o inconsapevolmente? Non saprei dire. Splendide, comunque, le sopra citate scene, che denotano un’intima conoscenza da parte dell’autore della cultura messicana, molto al di là della padronanza della lingua spagnola che costella tutti i suoi testi “di confine”. Temo che quasi nessuno ricordi più il contributo dato dal Messico ispanico, con il Teatro della sua capitale, alla cultura dell’opera lirica. Insieme per altro a quasi tutto il Sudamerica, e queste scene di The Crossing, oltre che al Fellini del 1983, rimandano direttamente al furore operistico sudamericano del film Fitzcarraldo, che è del 1982. Digressione conclusa, proseguo.
“È del poeta il fin la meraviglia - (parlo de l’eccellente e non del goffo): - chi non sa far stupir, vada alla striglia!” cantava Giambattista Marino, versi che (oltre ai poeti) ogni narratore dovrebbe avere fissi nella mente, come fissi nella mente mostra di averli Cormac McCarthy, autore non certamente “goffo” ma anzi strepitoso quanto a uso della lingua, quel famoso americano “della frontiera” cui ho già accennato, letterariamente proposto da Fenimore Cooper un secolo e mezzo prima di lui: “Venti milioni di persone possono non soltanto fare un mondo, ma anche una lingua, se occorre”. Una lingua, nella fattispecie, composta essenzialmente dallo sgrammaticato inglese dei primi coloni britannici (they - theys, invece di there is, caint invece di can’t, semplicemente ’d invece di had o would, sumbuck invece di son of bitch, hoss invece di horse eccetera) in cui si innestano il tedesco e l’olandese dei secondi venuti più il francese masticato dai pellerossa del Nord e in seguito lo spagnolo storpiato da quelli del Sud.
Una lingua che evidentemente “occorreva”, visto che è poi stata usata da ben più di venti milioni di persone, tra cui anche molti scrittori, seppure con esiti non sempre ugualmente elevati, da Steinbeck e soprattutto Faulkner in giù. Eccelsi, gli esiti, nel caso di McCarthy, e qui arrivato non posso fare a meno di rendere omaggio ai suoi traduttori: quale che ne sia il risultato, il solo impegno a cercar di rendere quell’americano in un’altra lingua è commendevole in sé. Già leggerlo in originale impone di avere a disposizione (e saper usare) un formidabile apparato di esegesi: dizionari, repertori, manuali, motori di ricerca eccetera.
Dopo Not a Country for Old Men (per me più che deludente), avevo deciso di non leggere più niente di suo, ma poi non ho potuto farlo: rimuginando su All the Pretty Horses — il libro, non il film, molto mediocre —, quasi senza accorgermene mi son trovato a continuare. Avendo ormai definitivamente deciso che, a parte probabilmente la pecunia — mai eccessiva per uno scrittore e in genere appena sufficiente —, il cinema non ha davvero reso un buon servizio a McCarthy e al contrario lo ha svilito. La seconda e la terza parte della “Trilogia”, che per adesso sembra Hollywood non sia stata capace di sconciare, sono una grande lettura quasi come la prima. E, ancora una volta, soprattutto sotto il profilo di prosa e lingua. Che maestro. Le trame invece sono quel che sono, non di rado pasticciate e tirate avanti a strattoni; i personaggi non sono precisamente credibili; e sui finali l’autore avrebbe potuto riflettere più a lungo. Se quello di Horses è di amarissima bellezza, per altro perfettamente inserito nel ricco filone western del “Cavaliere Solitario”, quelli degli altri due non lo sono. Troppo strascicati.
Soprattutto quello di Cities of the Plain. Al cui proposito non riesco a esimermi dal far notare che il titolo italiano è ancora una volta poco corretto. È una citazione dalla Genesi, signori, 19:29: nel testo italiano cattolico (e anche interconfessionale) Sodoma e Gomorra sono le città della “valle”, non della “pianura”: “Così, quando distrusse le città della valle dove Lot aveva abitato…” Sempre che la Bibbia abbia una qualche importanza, ma per il cattolico McCarthy ce l’ha senz’altro, e anzi è essenziale. Tornando comunque a noi, un finale troppo filosofeggiante e pochissimo convincente. Certo, l’autore cerca di mettere in scena la Morte, passando dalle tonalità di Fellini a quelle di Bergman, impresa certamente non agevole e che non gli riesce bene. Un finale, inoltre e soprattutto, che contraddice se non addirittura rinnega quello che sembrava essere l’assunto principale della filosofia di McCarthy, ovvero che il West non sarebbe “un paese per vecchi”. A veder bene lo è eccome: gli unici dei giovinetti della “Trilogia” a sfangarsela sono anche gli unici che riescono a diventare vecchi: sicuramente Billy Parham e forse Lacey Rawlins, che però potrebbe anche essere morto a poco più di vent’anni. Tremenda la fine degli altri, che se ne vanno giovanissimi in varie modalità di strazio. Nell’ordine: Jimmy Blevins, Boyd Parham, John Cole Grady…
Il fatto si è che i giovani raccontati da McCarthy non sono giovani. Agiscono, borbottano, ragionano da vecchi, nascono già vecchi. Dall’assennatissimo quattordicenne di The Orchard Keeper fino ai cinque della “Trilogia” attraverso il “kid” di Blood Meridian. Non leggono quasi niente o niente del tutto — ricordo soltanto Billy Parham che a un certo punto, sdraiato nel suo giaciglio di cowboy, ha tra le mani Destry Rides Again, vedi caso di Max Brand, onestissima gallina della letteratura western — ma trovano di continuo modo di effondersi in contorte discettazioni filosofiche — sul senso della realtà, della vita (come sogno) e della morte — con pensosissimi personaggi di campagna, deserto o chiesa, fino alla presunta Morte al di là del cui sogno va a concludersi Cities.
Con il corollario del millenarismo privo di speranza celato dietro la miltoniana “darkness visible (oscurità, buio visibile)”: «Penso vedesse apparire [quindi farsi visibile, interpreto io] una terribile oscurità», dice verso la fine di Cities la presunta Morte parlando del personaggio di cui essa stessa ha visto in sogno il sogno… E: «Nights dark beyond darkness… (Notti buie al di là del buio…)» vedrà già nelle primissime righe di The Road il padre senza speranza di salvezza…