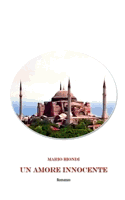Scrive di: Jack London
Introduzione a una edizione italiana di “Il richiamo della foresta” (1995)
Introduzione a una edizione italiana di “Il richiamo della foresta” (1995)
© Mario Biondi
Divieto di riproduzione integrale
e obbligo di citazione (per cortesia...)
Basta levarsi in volo da uno degli aeroporti di New York, diretti a Ovest, verso il West dei pionieri più o meno antichi, per capire molte cose. Tante idee si chiariscono, tanta letteratura si colora di realtà. Si capiscono subito, per esempio, i motivi di uno dei più resistenti miti della cultura e della scrittura Usa, quello del vagabondaggio, della «strada». Ti vedi scorrere sotto gli occhi migliaia e migliaia di riquadri di terreno in un’intera tavolozza di colori: giallo, rosso, verde, bianchiccio, nero. Fiumi, laghi, foreste, fattorie isolate, villaggi, cittadine, città, metropoli, tutti legati tra loro da un interminabile reticolo di «strade», in asfalto, in cemento, in terra battuta, in ferro.
Quella «strada» su cui tanti scrittori americani hanno deciso di inoltrarsi (e in qualche caso di perdersi) dissimulati in mezzo a una marea di altri esseri umani, come spinti da un impulso irrefrenabile, connaturato con la loro formazione di cittadini degli Stati Uniti, divenuti tali proprio in conseguenza di un gesto di rottura insanabile messo in atto da un antenato con la lontana patria di origine (oltre che con il più avventuroso e faticoso dei viaggi, quello attraverso l’Atlantico). Una «strada» che si affrontava e si affronta tuttora in mezzo ad avventurieri di varia caratura e predicatori, a braccianti in cerca di lavoro e disoccupati in cerca di riscatto sociale, a vittime dell’alcol e seguaci del Dharma, a uomini e topi (e, da ultimo, a una patinata sequela di turisti post-hippie e blue-grass). Tutti, essenzialmente, alla ricerca di quell’irraggiungibile Eldorado che per tante persone, soprattutto nelle società affluenti, rimane l’«io», l’«essere se stesso».
A mano a mano che sotto gli occhi, qualche migliaio di metri più in basso, si snoda questo magnifico universo di terra abitata — scarsamente, ma abitata —, se si hanno occhi e cuore si è costretti a rendersi conto che chi partiva dalla East Coast verso il West doveva lasciarsi alle spalle tutto una seconda volta: amicizie, affetti, sentimenti. Roba troppo pesante per poter essere impacchettata sul carro della carovana, come già non aveva trovato posto nella stiva di uno dei tanti trabiccoli marini seguiti al Mayflower. Quasi sempre, purtroppo, ci si lasciava dietro le spalle anche quel nobile senso di solidarietà che in moltissimi casi aveva costituito la molla per abbandonare la vecchia patria europea. L’imperativo diventava, subito e prima di tutti gli altri, sopravvivere. L’Eldorado «se stesso» era quasi sempre mascherato da altri Eldorado infinitamente più terrestri e terragni: la terra, appunto, l’«angolino al sole» di infausta memoria, il bestiame, le pellicce, l’oro. La ricchezza, insomma. Una cosa che, a pensarci bene, era del tutto possibile conseguire anche nel ricchissimo East dei burberi padri fondatori, dei parsimoniosi quaccheri, di tanti rompiscatole fondamentalisti di varia denominazione religiosa espulsi dall’Europa. Non lo si ripeterà mai abbastanza: il vero oggetto della ricerca era «se stesso». Per trovarlo si era disposti a morire. Alla nostra coscienza di europei più o meno civili, con decine di secoli di storia radicati nell’inconscio collettivo, può fare orrore, ma bisogna prenderne atto. Era la realtà di quei tempi e di quella gente, una realtà che non poteva non riverberarsi sul futuro, fino a oggi. Si può chiedere ai nomadi di non essere tali? Già soltanto i più forti riuscivano a superare l’Atlantico.
Proseguendo nel viaggio aereo, a un certo punto il territorio americano che si sorvola fa compiere un ulteriore passo in avanti nell’ambito di queste considerazioni. Un passo lungo e grave, ai limiti dell’ideologicamente pericoloso. Ma la realtà è realtà, inutile fingere il contrario. Dopo qualche ora di volo, campi coltivati e fiumi, laghi e villaggi, stradoni e binari cominciano a cedere alla wilderness, al mondo selvaggio. Vedi scorrere sotto di te lenzuoli di foreste impenetrabili, dorsali di montagne invalicabili, spianate di deserti intraversabili. Ai tempi dei pionieri, chi arrivava fino a lì era già pronto al passo successivo: ad affermarsi con qualsiasi mezzo, perché affermarsi era la condizione essenziale per sopravvivere. Al di là di un certo limite non tanto geografico quanto ideale o morale, all’infuori di qualche più o meno convincente sceriffo o bounty killer da film western o spettacolo circense, non esisteva più altra legge se non quella del più forte. Su quella frontiera estrema, chi era pronto a morire pur di conseguire il sacro «se stesso» aveva già pensato bene di farlo da tempo. Arrivato lì, chi era sopravvissuto era più che pronto a continuare a farlo con qualsiasi mezzo. Per non morire, era pronto a uccidere.
Che tipo di uomini sarà dunque stato quello arrivato fino alla Golden Gate, alla «Porta d’oro» della West Coast che ha dato il nome al celebre ponte rosso di San Francisco, con il suo quasi perenne velo di caligine? Si può pensare che in loro fosse potuta sopravvivere anche soltanto un’ombra dello spirito di solidarietà che li animava ancora quando erano partiti in carovana dalla costa opposta, quella affacciata sulla vecchia, ingrata patria Europa? Si può pretenderlo, con senso della storia, a prescindere dai buoni sentimenti e dalle giustissime considerazioni morali? Sarebbe sicuramente stato meglio che così non fosse, è del tutto auspicabile che non succeda mai più, ma la storia ammette soltanto riflessioni, non contorsioni all’indietro. Quello che è stato è stato.
Sono pensieri che divengono obbligatori davanti alla prospettiva di affrontare un’opera complessa e contraddittoria di uno scrittore disceso quasi direttamente da quella schiera di uomini, di un narratore appartenente alla generazione di poco successiva a quella dei pionieri del West. John Griffith Chaney, in arte Jack London, nato nel 1876 a San Francisco (meta estrema del pellegrinaggio a Ovest), e morto nel 1916 non lontano da lì, sempre in terra di California (lembo estremo del West degli Stati Uniti). Autore amatissimo dal pubblico ma animosamente discusso dalla critica, come spesso succede. Personaggio davvero contraddittorio, violento e dolcissimo, grandioso e miserabile, costruttore di fortune e dissipatore di ogni cosa (compresi gli affetti), fervido socialista e meschino piccolo borghese, strenuo denunciatore delle condizioni dei derelitti suoi simili (il sottoproletariato americano e londinese, nel Popolo dell’abisso) e sarcastico schernitore di altri derelitti (il popolo messicano in guerra con il suo paese, gli Stati Uniti), ardente propagandista del socialismo e al tempo stesso esaltatore di un confuso mito superomistico. Marx mescolato a Nietzsche, si è detto. Darwin più Spencer. E così via, attribuendogli, come spesso succede nelle ansie denigratrici di vario genere, una ridda in più di ambizioni e finalità rispetto a quella da cui era in realtà animato. Che si riducevano in sostanza a una: quella di scrivere, raccontare le vicende che si era visto dipanare davanti agli occhi nella sua vita avventurosa e altre, più misteriose, che tesseva giorno e notte la sua mente infaticabile.
Non potrebbe esserci aggettivo più pertinente: cinquanta libri di narrativa e varia in più o meno vent’anni di infaticabile attività. Troppi, sostiene qualcuno. Ah sì? E dove starebbe il limite del giusto? Quale Suprema Anima Bella gestisce la bilancia del corretto? Quante opere sarà lecito donare all’umanità? Hanno scritto «troppo» Balzac e Goethe, tanto per fare due nomi lontanissimi fra loro? E Shakespeare? Hanno composto «troppo» Donizetti e Rossini? E Mozart? Quale rinnovato (ma ugualmente sinistro) Ministero della Cultura Popolare auspicano coloro che spolverano simili calmieristici criteri di «troppo»? Assomigliano molto a quelli che denunciano la pubblicazione di «troppi» libri. Dimenticano che, ai fini di una cultura veramente libera e articolata, i libri non possono mai essere «troppi» e al contrario sono sempre «troppo pochi». Ma forse, a loro, una cultura veramente libera e articolata non interessa. Sono più interessati alla tetraggine del loro personalissimo (e irrisolto) «se stesso». Esattamente come i coriacei pionieri del West e i loro discendenti, tra cui Jack London.
Magniloquente, si è decretato. Tenendo veramente in scarso conto le condizioni storiche in cui Jack London si è formato e ha prodotto le sue opere, il contesto culturale (o subculturale) da cui usciva. Un contesto in cui, magari con la pistola al fianco, la domenica non si mancava di seguire, sia pure un po’ obtorto collo, il sermone del pastore; un contesto di religiosità protestante e/o protestataria fondata sull’imperativo imprescindibile del rapporto diretto con Dio attraverso la lettura del «Libro». Sarà un’opera poco magniloquente, la Bibbia, soprattutto se recitata o cantata da un pulpito? Era la prima e in molti casi unica lettura dei figli del popolo; non poteva dunque non risentirne, nel suo stile, un figlio del popolo che intendeva nel suo piccolissimo imitare Dio e creare un «altro» mondo scrivendo. Quanti libri (e film) in lingua inglese — usciti dalle isole britanniche, dagli Usa, dal Canada, dall’Australia, dalla Nuova Zelanda, dal Sud Africa, dall’India, dal Pakistan e via enumerando — hanno magniloquenti (e volute) cadenze «bibliche»! Ma, certo, per cogliere queste cadenze bisognerebbe saper leggere le opere in originale e coglierne tutte le sottigliezze linguistiche e stilistiche, perché la traduzione (al di là della qualità) è sempre opera del traduttore: non dovrebbe essere utilizzata più di tanto ai fini di arzigogolare giudizi critici. Certo: lo stile di Jack London è spesso magniloquente, come di sicuro magniloquenti dovevano essere i predicatori della parola di Dio che ascoltava. Ma saranno magniloquenti le sue asciutte, appassionate descrizioni di territori lontani e riti naturali? Uno stile diseguale, certo, ma l’espressione «capolavoro» è stata coniata proprio per stabilire una volta per tutte che non tutti i «lavori» sono «capo». C’è il meglio e c’è il peggio, per tutti.
Avido, è stato scritto da più parti. Sempre pronto a farsi pagare. Eppure qualcuno, nel nostro paese, già più o meno un secolo fa scriveva con impeto: «Il poeta, o vulgo sciocco, un pitocco non è già che all’altrui mensa...». Riprendeva da lontano un amaro concetto espresso da uno dei padri della nostra lingua: «Tu proverai sì come sa di sale / lo pane altrui...». Non poter campare del proprio lavoro, dover dipendere dal favore o dal capriccio del potente, non è una sorta di esilio dalla libertà? Che strano: c’è chi è entusiasticamente pronto a riconoscere dignità di professionista a lobbisti e tangentari, al grande regista che fa la pubblicità dei maccheroni e al pittore che reclamizza il lucido per scarpe, ma allo scrittore che vuole fare onestamente il suo mestiere non la riconoscerà sdegnosamente mai. Secondo simili criteri di dignità e libertà, lo scrittore non può essere un professionista: deve essere e rimanere sempre un «pitocco». È secondo gente del genere che Jack London «scriveva troppo». E perché? Rubava, imbrogliava? No: semplicemente perché non era un «pitocco» e voleva campare (bene: aspirazione di tutti) del suo lavoro, senza sgraffignare il pane nella dispensa degli altri. Forse perché troppe volte aveva trovato desolantemente vuota quella di casa London. Difficile davvero la vita dello scrittore, sulla frontiera estrema del West come altrove.
Ripercorriamola un po’ questa vita, brevemente, sommariamente, per cercare di trarne qualche elemento di ulteriore giudizio. John Griffith Chaney nasce nel 1876 a San Francisco, figlio di una bizzarra spiritualista, maestra di musica, e di un astrologo girovago, per altro bellamente scomparso prima della sua nascita. Cresce disordinatamente nella girovaga e misera casa di un patrigno dai mille mestieri (ma evidentemente di cuore non cattivo), che gli dà il suo cognome. A 14 anni è già «on the road». (Ai fini della ricerca di «se stesso», infatti, il mare è una strada come un’altra.) Fa alternativamente il razziatore di banchi di ostriche e il collaboratore della polizia marittima che combatte contro le razzie. Arriva fino in Giappone come mozzo, fa lo «hobo» ferroviario in giro per gli Stati Uniti, si aggrega all’esercito di disoccupati che (in seguito alla crisi economica del 1893) Jacob Sechler Coxey guida in una colossale protesta fino a Washington. Diventa socialista militante. E da buon socialista del bel tempo andato si crea un confuso conglomerato di cultura a poco prezzo nelle biblioteche pubbliche che frequenta con avidità. Marx, si è detto, Darwin e Nietzsche. Più forse Spencer. Più Kipling, Milton e Dante (vedi caso). Ma letti come? In quali condizioni ambientali? Con quale attrezzatura gnoseologica? Le scuole ufficiali le aveva frequentate molto poco. I quattro anni di high school li aveva ridotti a uno, a 19 anni, per essere ammesso alla University of California in Berkeley. Ma la piantò subito per andare nel Klondike durante la Corsa all’oro del ’97 - ’98. Cominciava forse a capire che l’oro lo portava dentro di sé, nell’inesauribile capacità di raccontare che gli si stava formando nello spirito. Sta di fatto che credeva molto di più, istintivamente, alla scuola della «strada», agli insegnamenti della vita. Quando non viveva della misteriosa carità che ancora oggi, negli Stati Uniti, consente a milioni di «hobo» di campare «on the road», si adattava a fare di tutto, il lavandaio, l’operaio in un conservificio.
Dal Klondike tornò senza una briciola di metallo e con lo scorbuto, ma con un bagaglio di esperienza che valeva almeno come l’oro. Ne nacquero, oltre a tanti racconti esemplari, Zanna bianca (1906) e uno dei suoi libri più belli, duraturi e amati dal pubblico, Il richiamo della foresta (1903). Storie di lupi e/o di cani. Anzi, di lupi che non sanno bene se sono cani e di cani che non sanno bene se sono lupi. Di esseri viventi che non sanno bene a dove risalga la loro ascendenza. Come il loro inventore, Jack London, che non sapeva bene di chi fosse figlio e comunque non aveva mai conosciuto il vero padre. Si provi a pensare alla sua opera in questi termini: come un’immensa, sterminata autobiografia, in cui lo scrittore, come fa ogni autore che si rispetti, mescola vero e falso, recriminazioni e aspirazioni, delusioni e speranze, ciò che è effettivamente stato e ciò che avrebbe potuto essere, ciò che purtroppo è successo e ciò che si poteva sognare avvenisse. Costruendosi non una sola ma cento, mille personalità, una più sfuggente dell’altra, non una sola ma cento, mille vite da dare in pasto a lettori e biografi, a sostenitori e denigratori. I grandi scrittori fanno così.
Dunque è lo stesso Jack London che si nasconde in maniera tutto sommato abbastanza trasparente dentro gli inquietanti panni dei protagonisti del Lupo dei mari, del Tallone di ferro e giù giù, fino alle Memorie di un bevitore. Dunque Zanna Bianca non è altri che il piccolo John Griffith Chaney, naturalizzato London, che comincia ad affacciarsi alla vagante porta di casa (mai nello stesso posto per più di tanto tempo, esattamente come la tana della mezza lupa Kiche con il lupo Guercio) per esplorare i rischi delle vie adiacenti e poi sempre più lontane, fino al mondo degli Uomini con le sue inesplicabili difficoltà e bassezze. Dunque non altri che un Jack London adolescente è il cane Buck, costretto dalla violenza degli uomini (questi sì veramente avidi, spietatamente in corsa suicida verso l’oro) a cercare definitivo rifugio tra i propri ancestrali simili, ad ascoltare «il richiamo della foresta», ad abbandonare il consesso umano per unirsi ai lupi. Un itinerario molto simile lo si può percorrere in sembianze di disoccupato, che ulula alla luna la sua fame non dalla neve del Klondike ma da un treno in corsa nelle pianure senza fine degli Stati Uniti. O di ragazzo disperato che cerca di sopravvivere rubando ostriche. Se non addirittura di infelice con l’abito a strisce del carcerato, costretto a conoscere tutta l’abiezione morale e fisica della galera. Ma anche capace di scoprire l’amicizia, la solidarietà e insieme a esse la coscienza di se stesso in quanto individuo: è il tempo che Buck trascorre nella capanna di John Thornton, parallelo all’incontro di Zanna Bianca con Weedon Scott. Che straordinaria lezione in poche righe, priva di qualsiasi magniloquenza, viene impartita al lettore dal disprezzo con cui Buck osserva gli infelici, assetati di oro, che nessuno potrebbe arrestare sulle labili tracce del loro irraggiungibile Eldorado: li lascia andare ostinatamente a cercare la morte nel ghiaccio.
Del resto, altre idee di lupo-uomo o di cane-uomo ci sono state regalate dalla storia del romanzo di riflessione sulla condizione umana o di quello «di formazione», dal Lupo della steppa al Ritratto dell’artista da cucciolo. Ma non si potrà di certo aggiungere Hermann Hesse e Dylan Thomas all’elenco dei maestri di Jack London, se non altro per motivi di data. Proviamo, invece, ad aggiungere a quelli dei padri spirituali sopra citati il nome di Sigmund Freud, con la psicoanalisi. Pensatore da lui quasi sicuramente mai letto e forse nemmeno sentito nominare. Ma c’è bisogno di leggere libri e riempirsi di nozioni per avvertire a livello istintivo, creativo, di avere un subconscio che preme incontenibile per traboccare e raccontare, travestito da sogno, da mito, da fantasticheria, persino da sbruffonata? È un criterio rischioso, di sicuro non valido per tutti gli autori, ma è probabilmente il modo più corretto di leggere le opere di Jack London, specchio vivente di una vita: di un autore a cui la letteratura americana deve far risalire per lo meno John Steinbeck e Ernest Hemingway, più Jack Kerouac, con i loro seguaci o epigoni.
Per tutta la sua breve vita (quarant’anni!) Jack London non fece quasi altro che raccontare e riraccontare se stesso, le sue vicende e i suoi sogni, le sue rivendicazioni e le sue delusioni, il suo frustrato bisogno d’amore di figlio bastardo, il suo disperato cupio dissolvi. In un modo spesso velato e mascherato, ma in qualche caso in maniera palesemente candida: vedi almeno La strada (1907) e John Barleycorn (1913). Ancora di più. Nella sua insopprimibile, febbricitante ansia di raccontarsi, di mettersi a nudo di fronte a un mondo dal quale continuò fino all’ultimo giorno a sentirsi misconosciuto — come dal padre fuggitivo —, Jack London arrivò a raccontare, trasfigurata, la propria fine: in Martin Eden. Nel 1909, sette anni prima di finire lui stesso i suoi giorni in maniera poco chiara, vittima forse dell’alcol, forse di una droga antidolorifica, molto più probabilmente di se stesso, della sua inguaribile solitudine, della profonda difficoltà che incontrava — come il cane-lupo Buck, come il lupo-cane Zanna Bianca — a vivere in mezzo agli strani animali che si definiscono uomini e che, anche senza avere fame, sono capaci di comportarsi molto peggio dei lupi affamati.
Introduzione a: Jack London, Il richiamo della foresta, Newton Compton
Quella «strada» su cui tanti scrittori americani hanno deciso di inoltrarsi (e in qualche caso di perdersi) dissimulati in mezzo a una marea di altri esseri umani, come spinti da un impulso irrefrenabile, connaturato con la loro formazione di cittadini degli Stati Uniti, divenuti tali proprio in conseguenza di un gesto di rottura insanabile messo in atto da un antenato con la lontana patria di origine (oltre che con il più avventuroso e faticoso dei viaggi, quello attraverso l’Atlantico). Una «strada» che si affrontava e si affronta tuttora in mezzo ad avventurieri di varia caratura e predicatori, a braccianti in cerca di lavoro e disoccupati in cerca di riscatto sociale, a vittime dell’alcol e seguaci del Dharma, a uomini e topi (e, da ultimo, a una patinata sequela di turisti post-hippie e blue-grass). Tutti, essenzialmente, alla ricerca di quell’irraggiungibile Eldorado che per tante persone, soprattutto nelle società affluenti, rimane l’«io», l’«essere se stesso».
A mano a mano che sotto gli occhi, qualche migliaio di metri più in basso, si snoda questo magnifico universo di terra abitata — scarsamente, ma abitata —, se si hanno occhi e cuore si è costretti a rendersi conto che chi partiva dalla East Coast verso il West doveva lasciarsi alle spalle tutto una seconda volta: amicizie, affetti, sentimenti. Roba troppo pesante per poter essere impacchettata sul carro della carovana, come già non aveva trovato posto nella stiva di uno dei tanti trabiccoli marini seguiti al Mayflower. Quasi sempre, purtroppo, ci si lasciava dietro le spalle anche quel nobile senso di solidarietà che in moltissimi casi aveva costituito la molla per abbandonare la vecchia patria europea. L’imperativo diventava, subito e prima di tutti gli altri, sopravvivere. L’Eldorado «se stesso» era quasi sempre mascherato da altri Eldorado infinitamente più terrestri e terragni: la terra, appunto, l’«angolino al sole» di infausta memoria, il bestiame, le pellicce, l’oro. La ricchezza, insomma. Una cosa che, a pensarci bene, era del tutto possibile conseguire anche nel ricchissimo East dei burberi padri fondatori, dei parsimoniosi quaccheri, di tanti rompiscatole fondamentalisti di varia denominazione religiosa espulsi dall’Europa. Non lo si ripeterà mai abbastanza: il vero oggetto della ricerca era «se stesso». Per trovarlo si era disposti a morire. Alla nostra coscienza di europei più o meno civili, con decine di secoli di storia radicati nell’inconscio collettivo, può fare orrore, ma bisogna prenderne atto. Era la realtà di quei tempi e di quella gente, una realtà che non poteva non riverberarsi sul futuro, fino a oggi. Si può chiedere ai nomadi di non essere tali? Già soltanto i più forti riuscivano a superare l’Atlantico.
Proseguendo nel viaggio aereo, a un certo punto il territorio americano che si sorvola fa compiere un ulteriore passo in avanti nell’ambito di queste considerazioni. Un passo lungo e grave, ai limiti dell’ideologicamente pericoloso. Ma la realtà è realtà, inutile fingere il contrario. Dopo qualche ora di volo, campi coltivati e fiumi, laghi e villaggi, stradoni e binari cominciano a cedere alla wilderness, al mondo selvaggio. Vedi scorrere sotto di te lenzuoli di foreste impenetrabili, dorsali di montagne invalicabili, spianate di deserti intraversabili. Ai tempi dei pionieri, chi arrivava fino a lì era già pronto al passo successivo: ad affermarsi con qualsiasi mezzo, perché affermarsi era la condizione essenziale per sopravvivere. Al di là di un certo limite non tanto geografico quanto ideale o morale, all’infuori di qualche più o meno convincente sceriffo o bounty killer da film western o spettacolo circense, non esisteva più altra legge se non quella del più forte. Su quella frontiera estrema, chi era pronto a morire pur di conseguire il sacro «se stesso» aveva già pensato bene di farlo da tempo. Arrivato lì, chi era sopravvissuto era più che pronto a continuare a farlo con qualsiasi mezzo. Per non morire, era pronto a uccidere.
Che tipo di uomini sarà dunque stato quello arrivato fino alla Golden Gate, alla «Porta d’oro» della West Coast che ha dato il nome al celebre ponte rosso di San Francisco, con il suo quasi perenne velo di caligine? Si può pensare che in loro fosse potuta sopravvivere anche soltanto un’ombra dello spirito di solidarietà che li animava ancora quando erano partiti in carovana dalla costa opposta, quella affacciata sulla vecchia, ingrata patria Europa? Si può pretenderlo, con senso della storia, a prescindere dai buoni sentimenti e dalle giustissime considerazioni morali? Sarebbe sicuramente stato meglio che così non fosse, è del tutto auspicabile che non succeda mai più, ma la storia ammette soltanto riflessioni, non contorsioni all’indietro. Quello che è stato è stato.
Sono pensieri che divengono obbligatori davanti alla prospettiva di affrontare un’opera complessa e contraddittoria di uno scrittore disceso quasi direttamente da quella schiera di uomini, di un narratore appartenente alla generazione di poco successiva a quella dei pionieri del West. John Griffith Chaney, in arte Jack London, nato nel 1876 a San Francisco (meta estrema del pellegrinaggio a Ovest), e morto nel 1916 non lontano da lì, sempre in terra di California (lembo estremo del West degli Stati Uniti). Autore amatissimo dal pubblico ma animosamente discusso dalla critica, come spesso succede. Personaggio davvero contraddittorio, violento e dolcissimo, grandioso e miserabile, costruttore di fortune e dissipatore di ogni cosa (compresi gli affetti), fervido socialista e meschino piccolo borghese, strenuo denunciatore delle condizioni dei derelitti suoi simili (il sottoproletariato americano e londinese, nel Popolo dell’abisso) e sarcastico schernitore di altri derelitti (il popolo messicano in guerra con il suo paese, gli Stati Uniti), ardente propagandista del socialismo e al tempo stesso esaltatore di un confuso mito superomistico. Marx mescolato a Nietzsche, si è detto. Darwin più Spencer. E così via, attribuendogli, come spesso succede nelle ansie denigratrici di vario genere, una ridda in più di ambizioni e finalità rispetto a quella da cui era in realtà animato. Che si riducevano in sostanza a una: quella di scrivere, raccontare le vicende che si era visto dipanare davanti agli occhi nella sua vita avventurosa e altre, più misteriose, che tesseva giorno e notte la sua mente infaticabile.
Non potrebbe esserci aggettivo più pertinente: cinquanta libri di narrativa e varia in più o meno vent’anni di infaticabile attività. Troppi, sostiene qualcuno. Ah sì? E dove starebbe il limite del giusto? Quale Suprema Anima Bella gestisce la bilancia del corretto? Quante opere sarà lecito donare all’umanità? Hanno scritto «troppo» Balzac e Goethe, tanto per fare due nomi lontanissimi fra loro? E Shakespeare? Hanno composto «troppo» Donizetti e Rossini? E Mozart? Quale rinnovato (ma ugualmente sinistro) Ministero della Cultura Popolare auspicano coloro che spolverano simili calmieristici criteri di «troppo»? Assomigliano molto a quelli che denunciano la pubblicazione di «troppi» libri. Dimenticano che, ai fini di una cultura veramente libera e articolata, i libri non possono mai essere «troppi» e al contrario sono sempre «troppo pochi». Ma forse, a loro, una cultura veramente libera e articolata non interessa. Sono più interessati alla tetraggine del loro personalissimo (e irrisolto) «se stesso». Esattamente come i coriacei pionieri del West e i loro discendenti, tra cui Jack London.
Magniloquente, si è decretato. Tenendo veramente in scarso conto le condizioni storiche in cui Jack London si è formato e ha prodotto le sue opere, il contesto culturale (o subculturale) da cui usciva. Un contesto in cui, magari con la pistola al fianco, la domenica non si mancava di seguire, sia pure un po’ obtorto collo, il sermone del pastore; un contesto di religiosità protestante e/o protestataria fondata sull’imperativo imprescindibile del rapporto diretto con Dio attraverso la lettura del «Libro». Sarà un’opera poco magniloquente, la Bibbia, soprattutto se recitata o cantata da un pulpito? Era la prima e in molti casi unica lettura dei figli del popolo; non poteva dunque non risentirne, nel suo stile, un figlio del popolo che intendeva nel suo piccolissimo imitare Dio e creare un «altro» mondo scrivendo. Quanti libri (e film) in lingua inglese — usciti dalle isole britanniche, dagli Usa, dal Canada, dall’Australia, dalla Nuova Zelanda, dal Sud Africa, dall’India, dal Pakistan e via enumerando — hanno magniloquenti (e volute) cadenze «bibliche»! Ma, certo, per cogliere queste cadenze bisognerebbe saper leggere le opere in originale e coglierne tutte le sottigliezze linguistiche e stilistiche, perché la traduzione (al di là della qualità) è sempre opera del traduttore: non dovrebbe essere utilizzata più di tanto ai fini di arzigogolare giudizi critici. Certo: lo stile di Jack London è spesso magniloquente, come di sicuro magniloquenti dovevano essere i predicatori della parola di Dio che ascoltava. Ma saranno magniloquenti le sue asciutte, appassionate descrizioni di territori lontani e riti naturali? Uno stile diseguale, certo, ma l’espressione «capolavoro» è stata coniata proprio per stabilire una volta per tutte che non tutti i «lavori» sono «capo». C’è il meglio e c’è il peggio, per tutti.
Avido, è stato scritto da più parti. Sempre pronto a farsi pagare. Eppure qualcuno, nel nostro paese, già più o meno un secolo fa scriveva con impeto: «Il poeta, o vulgo sciocco, un pitocco non è già che all’altrui mensa...». Riprendeva da lontano un amaro concetto espresso da uno dei padri della nostra lingua: «Tu proverai sì come sa di sale / lo pane altrui...». Non poter campare del proprio lavoro, dover dipendere dal favore o dal capriccio del potente, non è una sorta di esilio dalla libertà? Che strano: c’è chi è entusiasticamente pronto a riconoscere dignità di professionista a lobbisti e tangentari, al grande regista che fa la pubblicità dei maccheroni e al pittore che reclamizza il lucido per scarpe, ma allo scrittore che vuole fare onestamente il suo mestiere non la riconoscerà sdegnosamente mai. Secondo simili criteri di dignità e libertà, lo scrittore non può essere un professionista: deve essere e rimanere sempre un «pitocco». È secondo gente del genere che Jack London «scriveva troppo». E perché? Rubava, imbrogliava? No: semplicemente perché non era un «pitocco» e voleva campare (bene: aspirazione di tutti) del suo lavoro, senza sgraffignare il pane nella dispensa degli altri. Forse perché troppe volte aveva trovato desolantemente vuota quella di casa London. Difficile davvero la vita dello scrittore, sulla frontiera estrema del West come altrove.
Ripercorriamola un po’ questa vita, brevemente, sommariamente, per cercare di trarne qualche elemento di ulteriore giudizio. John Griffith Chaney nasce nel 1876 a San Francisco, figlio di una bizzarra spiritualista, maestra di musica, e di un astrologo girovago, per altro bellamente scomparso prima della sua nascita. Cresce disordinatamente nella girovaga e misera casa di un patrigno dai mille mestieri (ma evidentemente di cuore non cattivo), che gli dà il suo cognome. A 14 anni è già «on the road». (Ai fini della ricerca di «se stesso», infatti, il mare è una strada come un’altra.) Fa alternativamente il razziatore di banchi di ostriche e il collaboratore della polizia marittima che combatte contro le razzie. Arriva fino in Giappone come mozzo, fa lo «hobo» ferroviario in giro per gli Stati Uniti, si aggrega all’esercito di disoccupati che (in seguito alla crisi economica del 1893) Jacob Sechler Coxey guida in una colossale protesta fino a Washington. Diventa socialista militante. E da buon socialista del bel tempo andato si crea un confuso conglomerato di cultura a poco prezzo nelle biblioteche pubbliche che frequenta con avidità. Marx, si è detto, Darwin e Nietzsche. Più forse Spencer. Più Kipling, Milton e Dante (vedi caso). Ma letti come? In quali condizioni ambientali? Con quale attrezzatura gnoseologica? Le scuole ufficiali le aveva frequentate molto poco. I quattro anni di high school li aveva ridotti a uno, a 19 anni, per essere ammesso alla University of California in Berkeley. Ma la piantò subito per andare nel Klondike durante la Corsa all’oro del ’97 - ’98. Cominciava forse a capire che l’oro lo portava dentro di sé, nell’inesauribile capacità di raccontare che gli si stava formando nello spirito. Sta di fatto che credeva molto di più, istintivamente, alla scuola della «strada», agli insegnamenti della vita. Quando non viveva della misteriosa carità che ancora oggi, negli Stati Uniti, consente a milioni di «hobo» di campare «on the road», si adattava a fare di tutto, il lavandaio, l’operaio in un conservificio.
Dal Klondike tornò senza una briciola di metallo e con lo scorbuto, ma con un bagaglio di esperienza che valeva almeno come l’oro. Ne nacquero, oltre a tanti racconti esemplari, Zanna bianca (1906) e uno dei suoi libri più belli, duraturi e amati dal pubblico, Il richiamo della foresta (1903). Storie di lupi e/o di cani. Anzi, di lupi che non sanno bene se sono cani e di cani che non sanno bene se sono lupi. Di esseri viventi che non sanno bene a dove risalga la loro ascendenza. Come il loro inventore, Jack London, che non sapeva bene di chi fosse figlio e comunque non aveva mai conosciuto il vero padre. Si provi a pensare alla sua opera in questi termini: come un’immensa, sterminata autobiografia, in cui lo scrittore, come fa ogni autore che si rispetti, mescola vero e falso, recriminazioni e aspirazioni, delusioni e speranze, ciò che è effettivamente stato e ciò che avrebbe potuto essere, ciò che purtroppo è successo e ciò che si poteva sognare avvenisse. Costruendosi non una sola ma cento, mille personalità, una più sfuggente dell’altra, non una sola ma cento, mille vite da dare in pasto a lettori e biografi, a sostenitori e denigratori. I grandi scrittori fanno così.
Dunque è lo stesso Jack London che si nasconde in maniera tutto sommato abbastanza trasparente dentro gli inquietanti panni dei protagonisti del Lupo dei mari, del Tallone di ferro e giù giù, fino alle Memorie di un bevitore. Dunque Zanna Bianca non è altri che il piccolo John Griffith Chaney, naturalizzato London, che comincia ad affacciarsi alla vagante porta di casa (mai nello stesso posto per più di tanto tempo, esattamente come la tana della mezza lupa Kiche con il lupo Guercio) per esplorare i rischi delle vie adiacenti e poi sempre più lontane, fino al mondo degli Uomini con le sue inesplicabili difficoltà e bassezze. Dunque non altri che un Jack London adolescente è il cane Buck, costretto dalla violenza degli uomini (questi sì veramente avidi, spietatamente in corsa suicida verso l’oro) a cercare definitivo rifugio tra i propri ancestrali simili, ad ascoltare «il richiamo della foresta», ad abbandonare il consesso umano per unirsi ai lupi. Un itinerario molto simile lo si può percorrere in sembianze di disoccupato, che ulula alla luna la sua fame non dalla neve del Klondike ma da un treno in corsa nelle pianure senza fine degli Stati Uniti. O di ragazzo disperato che cerca di sopravvivere rubando ostriche. Se non addirittura di infelice con l’abito a strisce del carcerato, costretto a conoscere tutta l’abiezione morale e fisica della galera. Ma anche capace di scoprire l’amicizia, la solidarietà e insieme a esse la coscienza di se stesso in quanto individuo: è il tempo che Buck trascorre nella capanna di John Thornton, parallelo all’incontro di Zanna Bianca con Weedon Scott. Che straordinaria lezione in poche righe, priva di qualsiasi magniloquenza, viene impartita al lettore dal disprezzo con cui Buck osserva gli infelici, assetati di oro, che nessuno potrebbe arrestare sulle labili tracce del loro irraggiungibile Eldorado: li lascia andare ostinatamente a cercare la morte nel ghiaccio.
Del resto, altre idee di lupo-uomo o di cane-uomo ci sono state regalate dalla storia del romanzo di riflessione sulla condizione umana o di quello «di formazione», dal Lupo della steppa al Ritratto dell’artista da cucciolo. Ma non si potrà di certo aggiungere Hermann Hesse e Dylan Thomas all’elenco dei maestri di Jack London, se non altro per motivi di data. Proviamo, invece, ad aggiungere a quelli dei padri spirituali sopra citati il nome di Sigmund Freud, con la psicoanalisi. Pensatore da lui quasi sicuramente mai letto e forse nemmeno sentito nominare. Ma c’è bisogno di leggere libri e riempirsi di nozioni per avvertire a livello istintivo, creativo, di avere un subconscio che preme incontenibile per traboccare e raccontare, travestito da sogno, da mito, da fantasticheria, persino da sbruffonata? È un criterio rischioso, di sicuro non valido per tutti gli autori, ma è probabilmente il modo più corretto di leggere le opere di Jack London, specchio vivente di una vita: di un autore a cui la letteratura americana deve far risalire per lo meno John Steinbeck e Ernest Hemingway, più Jack Kerouac, con i loro seguaci o epigoni.
Per tutta la sua breve vita (quarant’anni!) Jack London non fece quasi altro che raccontare e riraccontare se stesso, le sue vicende e i suoi sogni, le sue rivendicazioni e le sue delusioni, il suo frustrato bisogno d’amore di figlio bastardo, il suo disperato cupio dissolvi. In un modo spesso velato e mascherato, ma in qualche caso in maniera palesemente candida: vedi almeno La strada (1907) e John Barleycorn (1913). Ancora di più. Nella sua insopprimibile, febbricitante ansia di raccontarsi, di mettersi a nudo di fronte a un mondo dal quale continuò fino all’ultimo giorno a sentirsi misconosciuto — come dal padre fuggitivo —, Jack London arrivò a raccontare, trasfigurata, la propria fine: in Martin Eden. Nel 1909, sette anni prima di finire lui stesso i suoi giorni in maniera poco chiara, vittima forse dell’alcol, forse di una droga antidolorifica, molto più probabilmente di se stesso, della sua inguaribile solitudine, della profonda difficoltà che incontrava — come il cane-lupo Buck, come il lupo-cane Zanna Bianca — a vivere in mezzo agli strani animali che si definiscono uomini e che, anche senza avere fame, sono capaci di comportarsi molto peggio dei lupi affamati.
Introduzione a: Jack London, Il richiamo della foresta, Newton Compton