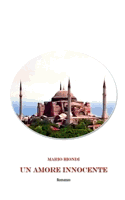Scrive di: John Irving
1. Recensione: “Le regole della casa del sidro” (1985)
2. Recensione: “Doppia coppia” (1986)
3. Recensione: “Figlio del circo” (1994)
1. Recensione: “Le regole della casa del sidro” (1985)
2. Recensione: “Doppia coppia” (1986)
3. Recensione: “Figlio del circo” (1994)
© Mario Biondi
Divieto di riproduzione integrale
e obbligo di citazione (per cortesia...)
Nel 188..., sconvolto da un turbolento incontro erotico, Wilbur Larch, studente di medicina americano, decide di non sposarsi mai più e di dedicare la vita ad assistere i frutti delle relazioni illecite o poco fortunate. Diviene quindi ginecologo e direttore dell’orfanotrofio di St Cloud’s, nel Maine, e in tale veste assisterà centinaia di puerpere e farà venire al mondo un numero infinito di trovatelli di entrambi i sessi, a cui si dedicherà anima e corpo. In particolare si dedicherà a uno di essi, Homer Wells, che non riuscirà a trovare una famiglia adottiva fino in età più che adolescente e che quindi diverrà per lui una specie di figlio. Gli si affezionerà talmente da insegnargli, ancora ragazzino, le tecniche della sua arte, facendone un perfetto ginecologo, seppur ancora privo di barba e soprattutto di laurea.
Attorno ai diciannove anni, tuttavia, il caso vuole che anche Homer trovi una famiglia adottiva, con la quale andrà felicemente a vivere, lasciando solo il povero dottor Larch, ben lieto della fortunata svolta impressa alla vita del suo pupillo, ma d’altro canto desolato perché il suddetto pupillo non vuole assolutamente diventare medico, nonostante la bravura dimostrata sul campo, ovvero accanto al lettino delle gestanti, preferendo fare di se stesso un coltivatore di mele. Le vite dei due si incroceranno di nuovo in diverse occasioni, e ogni volta Homer respingerà le lusinghe di Larch, che invano insisterà per farne un medico al servizio delle sfortunate vittime del peccato.
Ma quando finalmente, più che novantenne, il buon dottore, aureolato di santità, passerà a miglior vita, di fronte al pericolo che l’orfanotrio di St Cloud’s finisca in mani poco acconce, Homer non potrà resistere al richiamo del dovere, per cui abbandonerà le piacevolezze della famiglia adottiva e, sotto mentite spoglie, con un sotterfugio a fin di bene, vi tornerà per esercitarvi quell’arte ginecologica la cui conoscenza in lui non si è appannata nonostante il passare dei decenni. Gli orfani di St Cloud’s continuano felicemente a prosperare. Fine.
Così raccontata, sembrerebbe la trama di uno sgangherato romanzo edificante anglosassone sul mondo degli orfani. Non a caso, infatti, nella camerata dei maschietti di St Cloud’s ogni sera a rotazione si legge interminabilmente un brano di David Copperfield, mentre in quella delle femminucce si legge Jane Eyre, due archetipi dell’orfano nel romanzo. Ma le cose si complicano notevolmente non appena si aggiunga che tale trama è quella di Le regole della casa del sidro, ultimo romanzo di John Irving, quasi sicuramente il più interessante romanziere prodotto in quest’ultimo decennio dalla letteratura degli Stati Uniti, un vero maestro del grottesco e del comico.
Le cose, dicevo, si complicano; i problemi delle ginecologia sono assai delicati, e il buon dottor Larch si trova a dover fare scelte molto difficili: dovrà compiere il lavoro del Signore e quello del Diavolo, ovvero far partorire e far abortire. Lo farà sempre con grande senso civile, obbedendo a una forza morale che gli impone addirittura di scrivere per decenni lunghe lettere ai presidenti Roosvelt e Truman per chiedere che l’aborto venga legalizzato. Ne rimarrà tuttavia talmente stressato che dovrà cercare conforto nell’etere, arrivando a poco a poco a drogarsene. John Irving, pur tingendolo ininterrottamente di rosanero e stravolgendolo in profluvi di irresistibile comicità, secondo la sua poetica (si pensi solamente al vecchio buon medico in preda ai fumi dell’etere, che scrive lettere deliranti ai presidenti degli Stati Uniti!), affronta il problema di petto, con baldanza linguistica tutta americana e facendo prevalere nettamente le esigenze della letteratura su quelle della pruderie. All’arte non si comanda: il lettore che non ami il linguaggio duro e le situazioni scabrose, è avvertito.
Chi invece abbia già goduto il fantastico romanzo Il mondo secondo Garp e la prima metà di Hotel New Hampshire, ovvero i due precedenti romanzi di Irving, in Le regole della casa del sidro ritroverà gran parte dello stesso divertimento. Il funambolismo delle situazioni, le crepitanti scariche di comicità e satira, i giochi di parole, la profonda tenerezza di certi momenti di intimità, soprattutto quelli che riguardano i piccoli orfani e chi li assiste: pagine di autentica commozione, che traspare prepotente anche se si cerca quasi a forza di comprimerla sotto lo sberleffo. Il tutto, però, meno incalzante che nei romanzi precedenti, quasi più meditato, sfumato da un generale velo di malinconia, dal quale prorompe la bravura dello scrittore di alta qualità, per esempio nelle magistrali limerick di argomento giocosamente osceno. C’è poco da scandalizzarsi: si tratta di un’antica forma poetica britannica con tutti i suoi canoni di dignità, forma poetica che Irving, dottissimo artigiano della parola scritta, dimostra di saper padroneggiare da attento studioso delle strutture letterarie dell’inglese.
John Irving, Le regole della casa del sidro, Bompiani
(Il giornale, 29 dicembre 1985)
II.
A cavallo degli anni Sessanta/Settanta, evidentemente, le giovani famiglie «liberate» degli Stati Uniti dovevano essere pervase da un gran prurito di scambio dei legittimi partner: la mia consorte a te, io con la tua moglier, o che gioia o che piacer. E’ infatti del ’68 il trionfo del romanzo Coppie di John Updike. Che cosa non è disposta a fare la gente in nome della stabilità e inscindibilità della coppia! Insomma: visto il successo di Updike, il poco più che trentenne John Irving deve aver deciso di seguirne le fortunate orme. E così eccolo a sua volta raccontare la storia di un doppio matrimonio con incrocio di coppie in The 158-pound Marriage, romanzo pubblicato negli Stati Uniti nei primi anni Settanta e presentato soltanto ora in Italia dalla Bompiani con il titolo Doppia coppia. Non necessariamente, tuttavia, il recupero, la ripubblicazione o pubblicazione ritardata di un’opera giovanile, al di là dell’indubbio interesse documentario, si converte in una consistente aggiunta incrementale di stima nei confronti dell’autore della medesima.
Scrivendo Doppia coppia - già, salvo errore, al suo terzo romanzo - Irving dimostra di essere largamente padrone di tutti i trucchi, le estrosità e la carica di humour, insomma, del complesso di «ricette di fabbricazione» di cui si servirà successivamente per realizzare il suo (formidabile) best-seller Il mondo secondo Garp, il semi-seller Hotel New Hampshire e l’interessante ma piuttosto lento Le regole della casa del sidro. Dunque funambolico uso del comico e del grottesco, con generose spruzzate di macabro, nella quasi costante forma di sangue sparso da bambini. Impiego smagliante della lingua americana delle classi alte, disinvolta e colta. Eros pantagruelico. Occhiolino all’esotismo estetizzante della mitteleuropa, ovvero parti ambientate a Vienna. Intere lezioni di filosofia della lotta, sport praticato dall’autore. Svolgersi dell’intreccio e presentarsi dei personaggi - nonché delle loro considerazioni - per sprazzi di presente e passato, quasi in forma di romanzo storico o, meglio, di «interviste sulla vicenda». (Non a caso, infatti, l’io narrante è autore di romanzi storici.) Per un risultato che nel complesso non riesce a sollevarsi lieve verso impagabili risultati comici - come avverrà nei libri più tardi -, adagiandosi invece assai spesso su effetti di una certa pesantezza.
Protagonisti della storia sono due docenti di un’università periferica americana, con rispettive consorti (e bambini). Già una condizione per così dire geografico-nazionale sembra fare da pronuba all’inevitabile, pedantescamente codificato e disciplinatamente accettato incrocio: la moglie dell’io narrante e il marito della seconda coppia sono entrambi nati in Austria, l’una figlia di una contadina - riuscita grottescamente a farla sfuggire alle atrocità degli occupanti (fine della Seconda Guerra Mondiale) cucendola nella carogna di una vacca - e poi allevata da un ufficiale sovietico, l’altro figlio di un agitatore antinazista, attentatore della Messerschmitt, e di una bizzarra modella di pittori espressionisti. Ed è proprio nella filigrana delle sparse, lievi e fantasiose rievocazioni delle loro vite giovanili, con contorno di bizzarri personaggi picareschi, che il romanzo prende quota, per poi sprofondare nelle lungaggini, non prive di qualche ombra di volgarità, delle scene erotiche a partner e sessi ingarbugliati. Ma naturalmente tutti i gusti sono gusti. E’ noto come anche la lettura di testi ad hoc, oltre che lo scambio di mogli e mariti, possa giovare alle fatiche della coppia in crisi.
Per la cronaca, il garbuglio era stato imposto da una delle due mogli come vendetta nei confronti del marito, docente di tedesco e allenatore di lotta, reo di avere copulato sui materassini della palestra con una danzatrice privata di mezzo piede da un incidente con falciatrice. Tutto comunque tenderà a rientrare nel concitato ordine della vita di coppia, sia pure con qualche sconcerto di natura sentimentale, in un finale nel quale appaiono un po’ stucchevoli l’ennesimo disastro imposto ai bambini (con granguignolesco spargimento di sangue, ma per fortuna una volta tanto senza cadaveri), nonché l’ennesima oleografia di una Vienna più sognata che reale: stucchevoli, naturalmente, con il senno di poi della lettura ritardata. Li si è trovati nei romanzi più tardi, erano elementi di futuro successo già allora contenuti nel repertorio dell’autore, dunque documenti di indubbio interesse, ma il comune lettore italiano, non mosso da motivazioni di natura filologico-critica e arrivato soltanto ora a questo libro di tredici anni fa, rischia di provare un certo senso di deja vu.
John Irving, Doppia coppia, Bompiani
(Il giornale, 14 dicembre 1986)
III.
Un filo tutt’altro che esile lega la satura lanx, il "piatto pieno" di Lucilio, Persio e Giovenale (e Petronio) al travolgente comico-grottesco di un romanziere contemporaneo in lingua inglese come John Irving, a cui la forma letteraria è arrivata, tra l’altro, attraverso la straripante (ma coltissima, addirittura scientifica) comicità del Gargantua di Rabelais, da lui coltivata e studiata a livello accademico. Irving è largamente noto presso il nostro pubblico soprattutto per il grande successo arriso al romanzo Il mondo secondo Garp, esemplare esempio di satura lanx contemporanea in chiave neorabelaisiana, anche se la critica tende a trattarlo con una certa sufficienza, a conferma del fatto che da noi il comico di qualità ha vita difficile, venendo sempre derubricato a "corrivo" con un’albagia che non di rado si connota di superficialità. Le sue opere debordano di irrefrenabile funambolismo delle situazioni, crepitanti scariche di comicità — ma con il controcanto di scene di straziante tristezza —, calembour fulminanti, sapientissimo uso di linguaggio alto e linguaggio basso-greve se non, diciamo pure, scopertamente sboccato (altro espediente formale visto con sospetto nel nostro professorale milieu letterario, dove mal si tollera che in una portineria non ci si esprima come nel boudoir di una poetessa d’Arcadia). Minore successo hanno avuto le opere successive, che in effetti appaiono a tratti appesantite dallo strenuo impegno a mantenere fede alla formula della grande satura. Per larghi tratti il «piatto» rischia di essere troppo «pieno», generando una certa pesantezza.
Difetto in cui rischia qua e là di incorrere anche l’ultima, colossale fatica di Irving, Figlio del circo, romanzo che a certe tematiche tipiche dell’autore — enfantines, strampalata pratica della medicina, Vienna (e psicoanalisi), circo, animali, filastrocche, pidgin english (con connesse abissali difficoltà di traduzione) — aggiunge un’ambientazione inedita, l’India, con le connesse problematiche interrazziali, e una decisa connotazione di detective story che trasforma un bizzarro medico indiano-canadese zoroastriano-cristiano nello svelatore di un torbido intrigo con omicidi. Motivi di novità che valgono da soli per raccomandare il romanzo alla vasta schiera dei lettori di Irving, nell’auspicio di conquistare anche qualche neofita. Il divertimento, seppure diluito, sparso a larghe chiazze, è straordinario, purché il lettore sappia godere del «piatto pieno» con criterio e pazienza, consumandolo a poco a poco, così come a poco a poco, con cura, è stato concepito e scritto. Altrimenti può sempre trovare rifugio nelle «formiche» e nei «pancreas» sotto cui ci sta sommergendo, in un raro empito di creatività comica, la nostra stimata editoria.
John Irving, Figlio del Circo, Bompiani
(Letture)
Attorno ai diciannove anni, tuttavia, il caso vuole che anche Homer trovi una famiglia adottiva, con la quale andrà felicemente a vivere, lasciando solo il povero dottor Larch, ben lieto della fortunata svolta impressa alla vita del suo pupillo, ma d’altro canto desolato perché il suddetto pupillo non vuole assolutamente diventare medico, nonostante la bravura dimostrata sul campo, ovvero accanto al lettino delle gestanti, preferendo fare di se stesso un coltivatore di mele. Le vite dei due si incroceranno di nuovo in diverse occasioni, e ogni volta Homer respingerà le lusinghe di Larch, che invano insisterà per farne un medico al servizio delle sfortunate vittime del peccato.
Ma quando finalmente, più che novantenne, il buon dottore, aureolato di santità, passerà a miglior vita, di fronte al pericolo che l’orfanotrio di St Cloud’s finisca in mani poco acconce, Homer non potrà resistere al richiamo del dovere, per cui abbandonerà le piacevolezze della famiglia adottiva e, sotto mentite spoglie, con un sotterfugio a fin di bene, vi tornerà per esercitarvi quell’arte ginecologica la cui conoscenza in lui non si è appannata nonostante il passare dei decenni. Gli orfani di St Cloud’s continuano felicemente a prosperare. Fine.
Così raccontata, sembrerebbe la trama di uno sgangherato romanzo edificante anglosassone sul mondo degli orfani. Non a caso, infatti, nella camerata dei maschietti di St Cloud’s ogni sera a rotazione si legge interminabilmente un brano di David Copperfield, mentre in quella delle femminucce si legge Jane Eyre, due archetipi dell’orfano nel romanzo. Ma le cose si complicano notevolmente non appena si aggiunga che tale trama è quella di Le regole della casa del sidro, ultimo romanzo di John Irving, quasi sicuramente il più interessante romanziere prodotto in quest’ultimo decennio dalla letteratura degli Stati Uniti, un vero maestro del grottesco e del comico.
Le cose, dicevo, si complicano; i problemi delle ginecologia sono assai delicati, e il buon dottor Larch si trova a dover fare scelte molto difficili: dovrà compiere il lavoro del Signore e quello del Diavolo, ovvero far partorire e far abortire. Lo farà sempre con grande senso civile, obbedendo a una forza morale che gli impone addirittura di scrivere per decenni lunghe lettere ai presidenti Roosvelt e Truman per chiedere che l’aborto venga legalizzato. Ne rimarrà tuttavia talmente stressato che dovrà cercare conforto nell’etere, arrivando a poco a poco a drogarsene. John Irving, pur tingendolo ininterrottamente di rosanero e stravolgendolo in profluvi di irresistibile comicità, secondo la sua poetica (si pensi solamente al vecchio buon medico in preda ai fumi dell’etere, che scrive lettere deliranti ai presidenti degli Stati Uniti!), affronta il problema di petto, con baldanza linguistica tutta americana e facendo prevalere nettamente le esigenze della letteratura su quelle della pruderie. All’arte non si comanda: il lettore che non ami il linguaggio duro e le situazioni scabrose, è avvertito.
Chi invece abbia già goduto il fantastico romanzo Il mondo secondo Garp e la prima metà di Hotel New Hampshire, ovvero i due precedenti romanzi di Irving, in Le regole della casa del sidro ritroverà gran parte dello stesso divertimento. Il funambolismo delle situazioni, le crepitanti scariche di comicità e satira, i giochi di parole, la profonda tenerezza di certi momenti di intimità, soprattutto quelli che riguardano i piccoli orfani e chi li assiste: pagine di autentica commozione, che traspare prepotente anche se si cerca quasi a forza di comprimerla sotto lo sberleffo. Il tutto, però, meno incalzante che nei romanzi precedenti, quasi più meditato, sfumato da un generale velo di malinconia, dal quale prorompe la bravura dello scrittore di alta qualità, per esempio nelle magistrali limerick di argomento giocosamente osceno. C’è poco da scandalizzarsi: si tratta di un’antica forma poetica britannica con tutti i suoi canoni di dignità, forma poetica che Irving, dottissimo artigiano della parola scritta, dimostra di saper padroneggiare da attento studioso delle strutture letterarie dell’inglese.
John Irving, Le regole della casa del sidro, Bompiani
(Il giornale, 29 dicembre 1985)
II.
A cavallo degli anni Sessanta/Settanta, evidentemente, le giovani famiglie «liberate» degli Stati Uniti dovevano essere pervase da un gran prurito di scambio dei legittimi partner: la mia consorte a te, io con la tua moglier, o che gioia o che piacer. E’ infatti del ’68 il trionfo del romanzo Coppie di John Updike. Che cosa non è disposta a fare la gente in nome della stabilità e inscindibilità della coppia! Insomma: visto il successo di Updike, il poco più che trentenne John Irving deve aver deciso di seguirne le fortunate orme. E così eccolo a sua volta raccontare la storia di un doppio matrimonio con incrocio di coppie in The 158-pound Marriage, romanzo pubblicato negli Stati Uniti nei primi anni Settanta e presentato soltanto ora in Italia dalla Bompiani con il titolo Doppia coppia. Non necessariamente, tuttavia, il recupero, la ripubblicazione o pubblicazione ritardata di un’opera giovanile, al di là dell’indubbio interesse documentario, si converte in una consistente aggiunta incrementale di stima nei confronti dell’autore della medesima.
Scrivendo Doppia coppia - già, salvo errore, al suo terzo romanzo - Irving dimostra di essere largamente padrone di tutti i trucchi, le estrosità e la carica di humour, insomma, del complesso di «ricette di fabbricazione» di cui si servirà successivamente per realizzare il suo (formidabile) best-seller Il mondo secondo Garp, il semi-seller Hotel New Hampshire e l’interessante ma piuttosto lento Le regole della casa del sidro. Dunque funambolico uso del comico e del grottesco, con generose spruzzate di macabro, nella quasi costante forma di sangue sparso da bambini. Impiego smagliante della lingua americana delle classi alte, disinvolta e colta. Eros pantagruelico. Occhiolino all’esotismo estetizzante della mitteleuropa, ovvero parti ambientate a Vienna. Intere lezioni di filosofia della lotta, sport praticato dall’autore. Svolgersi dell’intreccio e presentarsi dei personaggi - nonché delle loro considerazioni - per sprazzi di presente e passato, quasi in forma di romanzo storico o, meglio, di «interviste sulla vicenda». (Non a caso, infatti, l’io narrante è autore di romanzi storici.) Per un risultato che nel complesso non riesce a sollevarsi lieve verso impagabili risultati comici - come avverrà nei libri più tardi -, adagiandosi invece assai spesso su effetti di una certa pesantezza.
Protagonisti della storia sono due docenti di un’università periferica americana, con rispettive consorti (e bambini). Già una condizione per così dire geografico-nazionale sembra fare da pronuba all’inevitabile, pedantescamente codificato e disciplinatamente accettato incrocio: la moglie dell’io narrante e il marito della seconda coppia sono entrambi nati in Austria, l’una figlia di una contadina - riuscita grottescamente a farla sfuggire alle atrocità degli occupanti (fine della Seconda Guerra Mondiale) cucendola nella carogna di una vacca - e poi allevata da un ufficiale sovietico, l’altro figlio di un agitatore antinazista, attentatore della Messerschmitt, e di una bizzarra modella di pittori espressionisti. Ed è proprio nella filigrana delle sparse, lievi e fantasiose rievocazioni delle loro vite giovanili, con contorno di bizzarri personaggi picareschi, che il romanzo prende quota, per poi sprofondare nelle lungaggini, non prive di qualche ombra di volgarità, delle scene erotiche a partner e sessi ingarbugliati. Ma naturalmente tutti i gusti sono gusti. E’ noto come anche la lettura di testi ad hoc, oltre che lo scambio di mogli e mariti, possa giovare alle fatiche della coppia in crisi.
Per la cronaca, il garbuglio era stato imposto da una delle due mogli come vendetta nei confronti del marito, docente di tedesco e allenatore di lotta, reo di avere copulato sui materassini della palestra con una danzatrice privata di mezzo piede da un incidente con falciatrice. Tutto comunque tenderà a rientrare nel concitato ordine della vita di coppia, sia pure con qualche sconcerto di natura sentimentale, in un finale nel quale appaiono un po’ stucchevoli l’ennesimo disastro imposto ai bambini (con granguignolesco spargimento di sangue, ma per fortuna una volta tanto senza cadaveri), nonché l’ennesima oleografia di una Vienna più sognata che reale: stucchevoli, naturalmente, con il senno di poi della lettura ritardata. Li si è trovati nei romanzi più tardi, erano elementi di futuro successo già allora contenuti nel repertorio dell’autore, dunque documenti di indubbio interesse, ma il comune lettore italiano, non mosso da motivazioni di natura filologico-critica e arrivato soltanto ora a questo libro di tredici anni fa, rischia di provare un certo senso di deja vu.
John Irving, Doppia coppia, Bompiani
(Il giornale, 14 dicembre 1986)
III.
Un filo tutt’altro che esile lega la satura lanx, il "piatto pieno" di Lucilio, Persio e Giovenale (e Petronio) al travolgente comico-grottesco di un romanziere contemporaneo in lingua inglese come John Irving, a cui la forma letteraria è arrivata, tra l’altro, attraverso la straripante (ma coltissima, addirittura scientifica) comicità del Gargantua di Rabelais, da lui coltivata e studiata a livello accademico. Irving è largamente noto presso il nostro pubblico soprattutto per il grande successo arriso al romanzo Il mondo secondo Garp, esemplare esempio di satura lanx contemporanea in chiave neorabelaisiana, anche se la critica tende a trattarlo con una certa sufficienza, a conferma del fatto che da noi il comico di qualità ha vita difficile, venendo sempre derubricato a "corrivo" con un’albagia che non di rado si connota di superficialità. Le sue opere debordano di irrefrenabile funambolismo delle situazioni, crepitanti scariche di comicità — ma con il controcanto di scene di straziante tristezza —, calembour fulminanti, sapientissimo uso di linguaggio alto e linguaggio basso-greve se non, diciamo pure, scopertamente sboccato (altro espediente formale visto con sospetto nel nostro professorale milieu letterario, dove mal si tollera che in una portineria non ci si esprima come nel boudoir di una poetessa d’Arcadia). Minore successo hanno avuto le opere successive, che in effetti appaiono a tratti appesantite dallo strenuo impegno a mantenere fede alla formula della grande satura. Per larghi tratti il «piatto» rischia di essere troppo «pieno», generando una certa pesantezza.
Difetto in cui rischia qua e là di incorrere anche l’ultima, colossale fatica di Irving, Figlio del circo, romanzo che a certe tematiche tipiche dell’autore — enfantines, strampalata pratica della medicina, Vienna (e psicoanalisi), circo, animali, filastrocche, pidgin english (con connesse abissali difficoltà di traduzione) — aggiunge un’ambientazione inedita, l’India, con le connesse problematiche interrazziali, e una decisa connotazione di detective story che trasforma un bizzarro medico indiano-canadese zoroastriano-cristiano nello svelatore di un torbido intrigo con omicidi. Motivi di novità che valgono da soli per raccomandare il romanzo alla vasta schiera dei lettori di Irving, nell’auspicio di conquistare anche qualche neofita. Il divertimento, seppure diluito, sparso a larghe chiazze, è straordinario, purché il lettore sappia godere del «piatto pieno» con criterio e pazienza, consumandolo a poco a poco, così come a poco a poco, con cura, è stato concepito e scritto. Altrimenti può sempre trovare rifugio nelle «formiche» e nei «pancreas» sotto cui ci sta sommergendo, in un raro empito di creatività comica, la nostra stimata editoria.
John Irving, Figlio del Circo, Bompiani
(Letture)