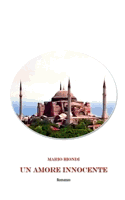Scrive di: Don DeLillo
I. Recensione: “Rumore Bianco” (1987)
II. Recensione: “Mao II” (1992)
I. Recensione: “Rumore Bianco” (1987)
II. Recensione: “Mao II” (1992)
© Mario Biondi
Divieto di riproduzione integrale
e obbligo di citazione (per cortesia...)
Se gli editori di casa nostra, oltre che contare, sapessero anche leggere in lingua straniera... E se, oltre che le classifiche di vendita dei maggiori mass media non-italiani, avessero anche voglia di fare lo sforzo di leggere attentamente qualche recensione... Ciò dato, probabilmente la storia delle mode letterarie importate in Italia dall’estero sarebbe totalmente diversa. Ma, si sa, la storia non è mai fatta di «se». Invece così succede che, rischiando il raggiro del lettore, venga inventato questo o quell’inesistente movimento letterario e vengano distribuiti a destra e a manca patenti di genialità a modeste persone che mai se le sarebbero aspettate. E succede, all’opposto, che un autore americano per molti versi autenticamente geniale come Don DeLillo passi totalmente inosservato presso i Massimi Sistemi Editoriali Italiani. Per forza: usa un americano difficile, di impasto brillantissimo, fatto di un intero dizionario con annessi stravolgimenti linguistici, e non soltanto lo sciatto fumetto lessicale di certi suoi giovani compaesani! Ignoto rimane, però, soltanto fino a quando di lui si accorgono i collaboratori di un piccolo editore periferico e avventuroso come Tullio Pironti da Napoli. Il quale subito lo pubblica.
Don DeLillo? Chi è costui? Si lagna forse, impiegando tredici parole e pochissimi congiuntivi, della condizione gay-piccolo-borghese a New York? Si agita e contorce (in quattro, sempre parole, e del tutto senza congiuntivi), per le delinquenziali sciocchezze dei giovinetti californiani? Nulla di tutto ciò: scrive notevolissimi romanzi, che definiremo «di storia contemporanea americana», visto che già qualcuno si affanna a definirli «postmoderni». (Nell’era della «Moda», ciò che ne resta fuori rischia di rimanere non-classificato. Poveri noi!)... Dunque: Don DeLillo. Poco più che cinquantenne, autore, tra gli altri, del romanzo White Noise, ovvero Rumore Bianco. Avendo avuto il vero piacere di tradurlo, ed essendo quindi una delle pochissime persone che lo ha letto fino in fondo e con attenzione in Italia, ne avevo già brevemente riferito alcuni mesi or sono su queste pagine. «Con ben diversa intelligenza e bravura letteraria» - (rispetto ai melensi “fatti minimi” di certi presunti giovani geni letterari americani del sabato sera) scrivevamo, - «nel romanzo White Noise il non più giovanissimo Don DeLillo inserisce pagine assolutamente esilaranti circa la mania dei "trivia", inscenando un favoloso dibattito tra il rettore di un college e lo staff insegnante di "ambienti americani", a base di "e tu che cosa stavi facendo quando è morto James Dean?", "ma ti sei mai fatto togliere la pelle della scottatura da una donna? e in che data? e dove? ed era nuda?" e altre impagabili piacevolezze minime, nonché una stupefacente lezione di vite comparate Adolf Hitler/Elvis Presley. Grande comicità, sublime ironia, intelligenza lucidissima.» Già.
Come ho più volte avuto occasione di ricordare, la giovanissima società americana è pervasa da una fervida ansia di ricerca e fondazione delle proprie brevi radici storiche, cercando di raccogliere e classificare tutto ciò che tale storia riguarda, dai fatti sensazionali ai citati "trivia", ovvero agli eventi minimi, siano essi pubblici, privati o più strettamente autobiografici. Ansia che può anche provocare effetti di un’ingenuità profondamente comica. È appunto su questo, sul paese in cui vive e che ama, sul suo modo di vivere e sulle sue ingenuità che l’italo-americano DeLillo ironizza con sublime finezza. Ma usando il sorriso per castigare i costumi. E, soprattutto, una cultura profonda e viva, non soltanto linguistico-letteraria, ma anche storica, sociale, psicologica.
Rumore bianco, infatti, è ben altro che pura ironia. È, prima di tutto, un sapiente e succoso apologo sulla vita di oggi nella civiltà supertecnologica, con i suoi stress le sue crisi, in mezzo a cento minacce di inquinamenti vari, che lo stesso inquinamento delle notizie non consente quasi mai di capire quanto siano effettivamente reali e quanto inventati a fini propagandistici o di cassetta. Attori della vicenda sono un docente di un’università periferica americana (insegna nientemeno che «Hitler», materia a cui è riuscito a far dedicare un intero dipartimento di studi!), con tutta la sua famiglia. Una famiglia assai complicata, con una terza moglie (o quarta?) e un variegato miscuglio di figli, imparzialmente provenienti dai diversi precedenti matrimoni della coppia, con tutti i loro problemi di crescita, trattati con mano magistrale. Bene: l’intera famiglia si trova coinvolta nella fuga di una nuvola tossica. Esilarante il racconto dell’evacuazione di tutta una città -, in un tragi-comico miscuglio di disagi, disfunzioni, messaggi sballati e fini notazioni psicologiche -, e grandiosa l’invenzione che ne consegue. La mamma - scopre una delle tremende e formidabili figlie-bambine, ferree nella loro logica di esseri umani che intendono prima di tutto sopravvivere - prende di nascosto una sconosciuta medicina di nome Dylar. Si tratta, scoprirà il lettore nel giro di non poche impagabili e grottesche vicende, nientemeno che di una panacea sperimentale contro la paura della morte, cui la donna ha accettato di sottoporsi come cavia. (Dylar, pronunciato più o meno “dailah”, come ha spiegato lo stesso autore in un’intervista, sarebbe una contrazione di die, ovvero «muori» e laugh, ovvero «ridi». «Muori ridendo», insomma). Ma, dopo la fuga della nube tossica, chi non ha paura? Tutto ciò comporta l’evolversi di un’appassionante spirale di eventi notevoli, che lasceremo al lettore di scoprire, insieme alla miriade di personaggi del romanzo, tra quali spiccano il figlio del protagonista, ultralogico e tenero rompiscatole adolescente, e un mirabile docente di "trivia" americani, quello appunto che tiene un corso su Elvis Presley e lo «compara» con l’Hitler del protagonista.
Don DeLillo, Rumore bianco, Einaudi (ex Pironti)
(Il giornale, 11 ottobre 1987)
Nota alla mia traduzione di Rumore bianco in edizione Einaudi.
Un amico scrittore mi ha fatto notare che a pagina 40 c'è un'espressione almeno bizzarra: "canottiera a manica lunga". Come fa una canottiera ad avere le maniche lunghe? Quindi, presunto errore del traduttore.
Attenzione! Il povero traduttore non ha nessuna colpa. Nell'edizione Pironti (originale), a pag. 38, si legge la sua traduzione (originale): "biancheria termica" ("thermal underwear"). Non sarà bella, ma almeno non è ridicola.
II.
"Un campo profughi o la più miserabile delle borgate... Corpi avvoltolati sulle panchine... giacigli stesi ad asciugare... ripari di fortuna... capanne fatte di scatoloni di cartone... gente vestita di stracci, a strati... Sette uomini senza nome posseggono tutto e ci fanno muovere come trottole. La gente viene sbattuta in strada perché i proprietari hanno bisogno di spazio. Poi vengono sbattuti via dalla strada perché qualcuno possiede l’aria che respirano... ci sono corpi ammonticchiati gli uni sugli altri dentro a scatoloni... Poi spazzano via anche gli scatoloni... Sopravvivere significa imparare a ridurre lo spazio che si occupa per paura di suscitare interessi antagonistici... È Beirut, sembra proprio Beirut."
Invece no: questo posto angosciante, questo girone d’inferno postmoderno o prefuturibile è New York come viene descritta nell’ultimo romanzo di Don DeLillo, Mao II. È l’autore stesso a parlarmene. "La New York che vedo ogni giorno, ogni volta che esco. Sono cose visibili a tutti, per esempio nella baraccopoli che è sorta in Tompkins Square Park." Ovvero, nel cuore di Manhattan. Considerato uno dei massimi scrittori americani contemporanei, addirittura oggetto di un discreto culto letterario, capace di circondarsi di un’aura di riservatezza al limite del mistero (vive con la moglie e senza figli in una cittadina del New Jersey, alla larga dalle mille luci di New York), il cinquantaseienne DeLillo — origini molisane, padre e madre di Montagano provincia di Campobasso, nato e cresciuto nell’universo privo di tenerezze denominato Bronx — è un uomo di corporatura minuta, di carnagione sofferta, dagli occhi mobilissimi: chi lo avesse visto soltanto nelle due o tre sue fotografie ufficiali, non lo riconoscerebbe mai. Per lui l’anonimato è, o è stato fino in questi ultimi giorni, una precisa scelta di vita. Si presta all’intervista con grande cortesia ma non appare a suo agio. Ha ceduto malvolentieri alle istanze dei press agent che dopo il grosso successo di Libra — la torbida storia di Lee Oswald e dell’omicidio Kennedy romanzata con gli inquietanti strumenti della sua narrativa — gli hanno praticamente imposto un tour promozionale europeo per il lancio del nuovo libro. Per il resto, esistono pochissime sue interviste. "Sì", ammette, "per me è un’esperienza nuova." E si agita a disagio sul divano.
In queste settimane sono arrivati nelle librerie italiane diversi altri libri di narrativa in cui si criticano le malefatte del sistema politico Usa (Il fantasma di Harlot, di Norman Mailer), o si lamenta con profonda malinconia il declino dell’ormai traballante Mito americano di fronte alla potenza giapponese (Riposa coniglio, di John Updike), o si canta la morte delle reaganomics e della cultura yuppie (Si spengono le luci, di Jay McInerney, dove si leggono altre scene di inferno urbano tratte dal famigerato Tompkins Square Park), ma nessuno di essi appare caratterizzato da una durezza di linguaggio e immagini pari a quella di Mao II.
Con DeLillo parlo dunque di questa New York. Di questa America che costituisce sempre lo scenario fondamentale dei suoi romanzi. Un’America di cui egli appare profondamente critico, e sempre più. Lo humour di cui era pervaso cinque anni fa Rumore bianco (cronaca immaginaria di un disastro ecologico e degli sconquassi psicologici che esso può creare), passando attraverso il profondo pessimismo di Libra (apologo di come l’individuo contemporaneo venga spossessato della stessa realtà attraverso la manipolazione che ne fanno i mass media), in Mao II sembra approdare alla totale perdita di ogni speranza. È così? No, DeLillo non è d’accordo. "Io non mi considero tanto un critico della cultura americana quanto un suo studioso." E dice cultura, non società. Certo, bisogna tenere conto che negli Usa DeLillo ci vive. È il suo paese. Riesce a trarne i mezzi per campare facendo esclusivamente un mestiere complicato come quello di scrittore (in quanti altri paesi è possibile?), "anche se quando ho pubblicato il primo libro, un ventennio fa, ciò ha significato dover tirare la cinghia, cavarsela con duemila dollari all’anno, che era pochissimo anche allora, abitare in un minuscolo appartamento senza stufa e cucina e con il frigo nel cesso, pulire i piatti nel lavabo del bagno. Sta comunque di fatto che la gente continua ad affluire a New York in massa. Vogliono vivere lì e da nessun’altra parte. E in ogni caso non mi pare che il mio ultimo romanzo sia privo di speranza. Pensi al finale."
È opportuno spiegare per sommi capi che in Mao II uno scrittore americano rifugiatosi nella clandestinità (una sorta di miscuglio tra Salinger e Pynchon), a tale clandestinità rinuncia in un empito di generosità per cercare di salvare un oscuro poeta svizzero ostaggio dei terroristi a Beirut. Quella Beirut devastata che — nel libro — sembrerebbe assomigliare tanto alla New York di oggi. Nelle righe finali, che sono di una finissima lievità neokafkiana, nella notte di questa martoriata Beirut, scortato da un vetusto carro armato si vede passare festante un matrimonio, palese simbolo di rinnovamento, di nuova vita. Ma, al di là dei simboli, come avverrà questo ricambio per New York e quindi per l’America? "Non lo so. Il mio impegno, in quanto scrittore, prima che alla storia o alla politica è rivolto al linguaggio, al suo perfezionamento, al suo rinnovamento. Sono però sicuro che New York, come tutta l’America, ce la farà. Ce l’ha fatta tante altre volte, perché non dovrebbe riuscirci ora?"
Ma chi è il nemico, nell’immediato? Contro chi o che cosa bisogna battersi? "Contro la distorsione che del linguaggio fa la televisione, che è distorsione della realtà. I mass media privilegiano unicamente le notizie a fondo oscuro, tragico, violento. Dittature, catastrofi naturali, terrorismo, in un procedimento perverso che non consente più di capire se siano loro a imporre una simile scelta o se è il largo pubblico ad avere fame di sensazioni del genere. È per questo che in Mao II metto in scena una vicenda di terrorismo. Quelli di terrore sono atti calcolati, programmati, strutturati, come i romanzi moderni. È la nuova narrativa che emerge di fatto dalla realtà, l’unica che sembri esercitare una presa sul pubblico.»
Linguaggio come specchio della società, dunque. Entrambi distorti. Da raddrizzare. Da rinnovare. "Sì, io annetto una grandissima importanza al linguaggio. Per lo scrittore la redenzione deve passare di lì. Ne siamo stati espropriati dai mass media e dobbiamo riappropriarcene." Nel romanzo, New York viene infatti descritta come una sorta di Babele, dove si incrociano mille lingue, al limite dell’incomunicabilità. "Non soltanto: a New York c’è tutta una popolazione sotterranea, quella dei “dispossessed”, dei “rag people”, degli straccioni privi di tutto, che parla una lingua misteriosa, totalmente incomprensibile agli altri. È, in un certo senso, la stessa gente tra cui sarebbe potuta finire una persona come il Lee Oswald che ho rappresentato in Libra. Una sorta di Babele, esattamente. Negli Usa si incrociano un numero incredibile di lingue, di culture. Basta prendere un taxi: ogni driver parla una lingua diversa, proveniente dai quattro capi del mondo." Ma la torre di Babele, con le sue mille lingue, è crollata, scomparsa. Dobbiamo pensare che l’America farà la stessa fine? "No, non credo proprio. L’energia per farcela ancora una volta è intatta."
Per quanto concerne la violenza, gli spiego il dibattito in corso in Italia, circa il fatto che essa possa derivare o meno dalla lettura di certi libri o dalla visione di certi film. "Quanto ai libri non credo proprio. Il pubblico è troppo ristretto. Per ciò che riguarda cinema e tv, invece, andrei molto cauto. In America abbiamo avuto un giovane che ha sparato al senatore Wallace, paralizzandolo: ha dichiarato di essere stato istigato dalla visione di Arancia meccanica. Poi c’è stato quello che per fare colpo su Jodie Foster, dopo avere visto Taxi driver, ha attentato a Reagan. È la violenza a generare tali film o sono loro a generare violenza? Tutt’e due le cose direi. Vi è un interscambio. È l’effetto mass media di cui parlavo prima. Tuttavia, per raccontare la conquista dell’indipendenza da parte di una donna, è proprio necessario circondarla dell’orribile scenario di un film come Il silenzio degli innocenti? Qual è il vero problema? La violenza nella società o l’evoluzione di una donna? Non so. Sta di fatto, comunque, che la società è intrisa di violenza."
È ben singolare. Nei suoi romanzi ci sono sangue, violenza, inquinamento, terrorismo. Mentre lei, qui, mi parla essenzialmente di linguaggio. E la politica? "Perché, di che cosa abbiamo discusso fino a ora? Il linguaggio è politica." Ma a che cosa si devono imputare simili gravi fenomeni? La risposta è perlomeno singolare. Da severo molisano vecchio stile quali dovevano essere i suoi antenati: "Dipendono dalla crisi della famiglia. Dai figli che crescono senza genitori". Nient’altro? "Le pare poco? Significa non avere più nessun background culturale, nessun punto di riferimento. È per un simile stato di cose, per esempio, che negli Usa hanno tanto successo sette religiose come quella del Reverendo Moon. Esiste una enorme massa di individui che hanno bisogno di un centro, di certezze, di vivere irreggimentati, di pensare tutti nello stesso modo, di vestirsi tutti nella stessa maniera. Persino di sposarsi tutti insieme, in cerimonie di massa in uno stadio, come quella con cui si apre Mao II.
"È per questo, per sfuggire agli effetti di una simile irregimentazione che scrittori come Salinger o Pynchon si sono ritirati a vivere in un isolamento totale." Ma non significa un po’ scappare di fronte alle proprie responsabilità? "Non so. Dipende dalla sensibilità dell’individuo." Don DeLillo ha già una discreta tendenza alla riservatezza, all’isolamento. Non si nasconderà anche lui nell’anonimato totale, un giorno o l’altro? "È possibile. Non posso escluderlo. Per me però non sarà una fuga dalla società: significherà soltanto lasciare che i miei libri procedano da soli, per ciò che valgono dal punto di vista letterario, senza la contaminazione delle pubbliche relazioni."
La definisca come vuole, ma a me sembra comunque una fuga. Quali rimedi si possono proporre, di fronte a un degrado sociale capace di ingenerare una simile voglia di nascondersi? "Non me li chieda. Non li so." E chi li sa, allora? Gli scrittori è legittimo che non l’abbiano chiaro, che si preoccupino prima di tutto del linguaggio e quindi della comunicazione, della deformazione messa in atto dai mass media, ma il presidente uscito dalle elezioni, almeno lui avrà le idee chiare, no? Almeno lui saprà che cosa si deve fare. "Mah", risponde DeLillo con un sorriso mesto. "Vede, dopo otto anni di Reagan e quattro di Bush ci si è ormai pubblicamente adeguati all’idea che per definizione il presidente sia l’ultimo a sapere ciò che avviene nel suo paese."
Don DeLillo, Mao II, Leonardo
(Europeo, 15 gennaio 1993)
Don DeLillo? Chi è costui? Si lagna forse, impiegando tredici parole e pochissimi congiuntivi, della condizione gay-piccolo-borghese a New York? Si agita e contorce (in quattro, sempre parole, e del tutto senza congiuntivi), per le delinquenziali sciocchezze dei giovinetti californiani? Nulla di tutto ciò: scrive notevolissimi romanzi, che definiremo «di storia contemporanea americana», visto che già qualcuno si affanna a definirli «postmoderni». (Nell’era della «Moda», ciò che ne resta fuori rischia di rimanere non-classificato. Poveri noi!)... Dunque: Don DeLillo. Poco più che cinquantenne, autore, tra gli altri, del romanzo White Noise, ovvero Rumore Bianco. Avendo avuto il vero piacere di tradurlo, ed essendo quindi una delle pochissime persone che lo ha letto fino in fondo e con attenzione in Italia, ne avevo già brevemente riferito alcuni mesi or sono su queste pagine. «Con ben diversa intelligenza e bravura letteraria» - (rispetto ai melensi “fatti minimi” di certi presunti giovani geni letterari americani del sabato sera) scrivevamo, - «nel romanzo White Noise il non più giovanissimo Don DeLillo inserisce pagine assolutamente esilaranti circa la mania dei "trivia", inscenando un favoloso dibattito tra il rettore di un college e lo staff insegnante di "ambienti americani", a base di "e tu che cosa stavi facendo quando è morto James Dean?", "ma ti sei mai fatto togliere la pelle della scottatura da una donna? e in che data? e dove? ed era nuda?" e altre impagabili piacevolezze minime, nonché una stupefacente lezione di vite comparate Adolf Hitler/Elvis Presley. Grande comicità, sublime ironia, intelligenza lucidissima.» Già.
Come ho più volte avuto occasione di ricordare, la giovanissima società americana è pervasa da una fervida ansia di ricerca e fondazione delle proprie brevi radici storiche, cercando di raccogliere e classificare tutto ciò che tale storia riguarda, dai fatti sensazionali ai citati "trivia", ovvero agli eventi minimi, siano essi pubblici, privati o più strettamente autobiografici. Ansia che può anche provocare effetti di un’ingenuità profondamente comica. È appunto su questo, sul paese in cui vive e che ama, sul suo modo di vivere e sulle sue ingenuità che l’italo-americano DeLillo ironizza con sublime finezza. Ma usando il sorriso per castigare i costumi. E, soprattutto, una cultura profonda e viva, non soltanto linguistico-letteraria, ma anche storica, sociale, psicologica.
Rumore bianco, infatti, è ben altro che pura ironia. È, prima di tutto, un sapiente e succoso apologo sulla vita di oggi nella civiltà supertecnologica, con i suoi stress le sue crisi, in mezzo a cento minacce di inquinamenti vari, che lo stesso inquinamento delle notizie non consente quasi mai di capire quanto siano effettivamente reali e quanto inventati a fini propagandistici o di cassetta. Attori della vicenda sono un docente di un’università periferica americana (insegna nientemeno che «Hitler», materia a cui è riuscito a far dedicare un intero dipartimento di studi!), con tutta la sua famiglia. Una famiglia assai complicata, con una terza moglie (o quarta?) e un variegato miscuglio di figli, imparzialmente provenienti dai diversi precedenti matrimoni della coppia, con tutti i loro problemi di crescita, trattati con mano magistrale. Bene: l’intera famiglia si trova coinvolta nella fuga di una nuvola tossica. Esilarante il racconto dell’evacuazione di tutta una città -, in un tragi-comico miscuglio di disagi, disfunzioni, messaggi sballati e fini notazioni psicologiche -, e grandiosa l’invenzione che ne consegue. La mamma - scopre una delle tremende e formidabili figlie-bambine, ferree nella loro logica di esseri umani che intendono prima di tutto sopravvivere - prende di nascosto una sconosciuta medicina di nome Dylar. Si tratta, scoprirà il lettore nel giro di non poche impagabili e grottesche vicende, nientemeno che di una panacea sperimentale contro la paura della morte, cui la donna ha accettato di sottoporsi come cavia. (Dylar, pronunciato più o meno “dailah”, come ha spiegato lo stesso autore in un’intervista, sarebbe una contrazione di die, ovvero «muori» e laugh, ovvero «ridi». «Muori ridendo», insomma). Ma, dopo la fuga della nube tossica, chi non ha paura? Tutto ciò comporta l’evolversi di un’appassionante spirale di eventi notevoli, che lasceremo al lettore di scoprire, insieme alla miriade di personaggi del romanzo, tra quali spiccano il figlio del protagonista, ultralogico e tenero rompiscatole adolescente, e un mirabile docente di "trivia" americani, quello appunto che tiene un corso su Elvis Presley e lo «compara» con l’Hitler del protagonista.
Don DeLillo, Rumore bianco, Einaudi (ex Pironti)
(Il giornale, 11 ottobre 1987)
Nota alla mia traduzione di Rumore bianco in edizione Einaudi.
Un amico scrittore mi ha fatto notare che a pagina 40 c'è un'espressione almeno bizzarra: "canottiera a manica lunga". Come fa una canottiera ad avere le maniche lunghe? Quindi, presunto errore del traduttore.
Attenzione! Il povero traduttore non ha nessuna colpa. Nell'edizione Pironti (originale), a pag. 38, si legge la sua traduzione (originale): "biancheria termica" ("thermal underwear"). Non sarà bella, ma almeno non è ridicola.
II.
"Un campo profughi o la più miserabile delle borgate... Corpi avvoltolati sulle panchine... giacigli stesi ad asciugare... ripari di fortuna... capanne fatte di scatoloni di cartone... gente vestita di stracci, a strati... Sette uomini senza nome posseggono tutto e ci fanno muovere come trottole. La gente viene sbattuta in strada perché i proprietari hanno bisogno di spazio. Poi vengono sbattuti via dalla strada perché qualcuno possiede l’aria che respirano... ci sono corpi ammonticchiati gli uni sugli altri dentro a scatoloni... Poi spazzano via anche gli scatoloni... Sopravvivere significa imparare a ridurre lo spazio che si occupa per paura di suscitare interessi antagonistici... È Beirut, sembra proprio Beirut."
Invece no: questo posto angosciante, questo girone d’inferno postmoderno o prefuturibile è New York come viene descritta nell’ultimo romanzo di Don DeLillo, Mao II. È l’autore stesso a parlarmene. "La New York che vedo ogni giorno, ogni volta che esco. Sono cose visibili a tutti, per esempio nella baraccopoli che è sorta in Tompkins Square Park." Ovvero, nel cuore di Manhattan. Considerato uno dei massimi scrittori americani contemporanei, addirittura oggetto di un discreto culto letterario, capace di circondarsi di un’aura di riservatezza al limite del mistero (vive con la moglie e senza figli in una cittadina del New Jersey, alla larga dalle mille luci di New York), il cinquantaseienne DeLillo — origini molisane, padre e madre di Montagano provincia di Campobasso, nato e cresciuto nell’universo privo di tenerezze denominato Bronx — è un uomo di corporatura minuta, di carnagione sofferta, dagli occhi mobilissimi: chi lo avesse visto soltanto nelle due o tre sue fotografie ufficiali, non lo riconoscerebbe mai. Per lui l’anonimato è, o è stato fino in questi ultimi giorni, una precisa scelta di vita. Si presta all’intervista con grande cortesia ma non appare a suo agio. Ha ceduto malvolentieri alle istanze dei press agent che dopo il grosso successo di Libra — la torbida storia di Lee Oswald e dell’omicidio Kennedy romanzata con gli inquietanti strumenti della sua narrativa — gli hanno praticamente imposto un tour promozionale europeo per il lancio del nuovo libro. Per il resto, esistono pochissime sue interviste. "Sì", ammette, "per me è un’esperienza nuova." E si agita a disagio sul divano.
In queste settimane sono arrivati nelle librerie italiane diversi altri libri di narrativa in cui si criticano le malefatte del sistema politico Usa (Il fantasma di Harlot, di Norman Mailer), o si lamenta con profonda malinconia il declino dell’ormai traballante Mito americano di fronte alla potenza giapponese (Riposa coniglio, di John Updike), o si canta la morte delle reaganomics e della cultura yuppie (Si spengono le luci, di Jay McInerney, dove si leggono altre scene di inferno urbano tratte dal famigerato Tompkins Square Park), ma nessuno di essi appare caratterizzato da una durezza di linguaggio e immagini pari a quella di Mao II.
Con DeLillo parlo dunque di questa New York. Di questa America che costituisce sempre lo scenario fondamentale dei suoi romanzi. Un’America di cui egli appare profondamente critico, e sempre più. Lo humour di cui era pervaso cinque anni fa Rumore bianco (cronaca immaginaria di un disastro ecologico e degli sconquassi psicologici che esso può creare), passando attraverso il profondo pessimismo di Libra (apologo di come l’individuo contemporaneo venga spossessato della stessa realtà attraverso la manipolazione che ne fanno i mass media), in Mao II sembra approdare alla totale perdita di ogni speranza. È così? No, DeLillo non è d’accordo. "Io non mi considero tanto un critico della cultura americana quanto un suo studioso." E dice cultura, non società. Certo, bisogna tenere conto che negli Usa DeLillo ci vive. È il suo paese. Riesce a trarne i mezzi per campare facendo esclusivamente un mestiere complicato come quello di scrittore (in quanti altri paesi è possibile?), "anche se quando ho pubblicato il primo libro, un ventennio fa, ciò ha significato dover tirare la cinghia, cavarsela con duemila dollari all’anno, che era pochissimo anche allora, abitare in un minuscolo appartamento senza stufa e cucina e con il frigo nel cesso, pulire i piatti nel lavabo del bagno. Sta comunque di fatto che la gente continua ad affluire a New York in massa. Vogliono vivere lì e da nessun’altra parte. E in ogni caso non mi pare che il mio ultimo romanzo sia privo di speranza. Pensi al finale."
È opportuno spiegare per sommi capi che in Mao II uno scrittore americano rifugiatosi nella clandestinità (una sorta di miscuglio tra Salinger e Pynchon), a tale clandestinità rinuncia in un empito di generosità per cercare di salvare un oscuro poeta svizzero ostaggio dei terroristi a Beirut. Quella Beirut devastata che — nel libro — sembrerebbe assomigliare tanto alla New York di oggi. Nelle righe finali, che sono di una finissima lievità neokafkiana, nella notte di questa martoriata Beirut, scortato da un vetusto carro armato si vede passare festante un matrimonio, palese simbolo di rinnovamento, di nuova vita. Ma, al di là dei simboli, come avverrà questo ricambio per New York e quindi per l’America? "Non lo so. Il mio impegno, in quanto scrittore, prima che alla storia o alla politica è rivolto al linguaggio, al suo perfezionamento, al suo rinnovamento. Sono però sicuro che New York, come tutta l’America, ce la farà. Ce l’ha fatta tante altre volte, perché non dovrebbe riuscirci ora?"
Ma chi è il nemico, nell’immediato? Contro chi o che cosa bisogna battersi? "Contro la distorsione che del linguaggio fa la televisione, che è distorsione della realtà. I mass media privilegiano unicamente le notizie a fondo oscuro, tragico, violento. Dittature, catastrofi naturali, terrorismo, in un procedimento perverso che non consente più di capire se siano loro a imporre una simile scelta o se è il largo pubblico ad avere fame di sensazioni del genere. È per questo che in Mao II metto in scena una vicenda di terrorismo. Quelli di terrore sono atti calcolati, programmati, strutturati, come i romanzi moderni. È la nuova narrativa che emerge di fatto dalla realtà, l’unica che sembri esercitare una presa sul pubblico.»
Linguaggio come specchio della società, dunque. Entrambi distorti. Da raddrizzare. Da rinnovare. "Sì, io annetto una grandissima importanza al linguaggio. Per lo scrittore la redenzione deve passare di lì. Ne siamo stati espropriati dai mass media e dobbiamo riappropriarcene." Nel romanzo, New York viene infatti descritta come una sorta di Babele, dove si incrociano mille lingue, al limite dell’incomunicabilità. "Non soltanto: a New York c’è tutta una popolazione sotterranea, quella dei “dispossessed”, dei “rag people”, degli straccioni privi di tutto, che parla una lingua misteriosa, totalmente incomprensibile agli altri. È, in un certo senso, la stessa gente tra cui sarebbe potuta finire una persona come il Lee Oswald che ho rappresentato in Libra. Una sorta di Babele, esattamente. Negli Usa si incrociano un numero incredibile di lingue, di culture. Basta prendere un taxi: ogni driver parla una lingua diversa, proveniente dai quattro capi del mondo." Ma la torre di Babele, con le sue mille lingue, è crollata, scomparsa. Dobbiamo pensare che l’America farà la stessa fine? "No, non credo proprio. L’energia per farcela ancora una volta è intatta."
Per quanto concerne la violenza, gli spiego il dibattito in corso in Italia, circa il fatto che essa possa derivare o meno dalla lettura di certi libri o dalla visione di certi film. "Quanto ai libri non credo proprio. Il pubblico è troppo ristretto. Per ciò che riguarda cinema e tv, invece, andrei molto cauto. In America abbiamo avuto un giovane che ha sparato al senatore Wallace, paralizzandolo: ha dichiarato di essere stato istigato dalla visione di Arancia meccanica. Poi c’è stato quello che per fare colpo su Jodie Foster, dopo avere visto Taxi driver, ha attentato a Reagan. È la violenza a generare tali film o sono loro a generare violenza? Tutt’e due le cose direi. Vi è un interscambio. È l’effetto mass media di cui parlavo prima. Tuttavia, per raccontare la conquista dell’indipendenza da parte di una donna, è proprio necessario circondarla dell’orribile scenario di un film come Il silenzio degli innocenti? Qual è il vero problema? La violenza nella società o l’evoluzione di una donna? Non so. Sta di fatto, comunque, che la società è intrisa di violenza."
È ben singolare. Nei suoi romanzi ci sono sangue, violenza, inquinamento, terrorismo. Mentre lei, qui, mi parla essenzialmente di linguaggio. E la politica? "Perché, di che cosa abbiamo discusso fino a ora? Il linguaggio è politica." Ma a che cosa si devono imputare simili gravi fenomeni? La risposta è perlomeno singolare. Da severo molisano vecchio stile quali dovevano essere i suoi antenati: "Dipendono dalla crisi della famiglia. Dai figli che crescono senza genitori". Nient’altro? "Le pare poco? Significa non avere più nessun background culturale, nessun punto di riferimento. È per un simile stato di cose, per esempio, che negli Usa hanno tanto successo sette religiose come quella del Reverendo Moon. Esiste una enorme massa di individui che hanno bisogno di un centro, di certezze, di vivere irreggimentati, di pensare tutti nello stesso modo, di vestirsi tutti nella stessa maniera. Persino di sposarsi tutti insieme, in cerimonie di massa in uno stadio, come quella con cui si apre Mao II.
"È per questo, per sfuggire agli effetti di una simile irregimentazione che scrittori come Salinger o Pynchon si sono ritirati a vivere in un isolamento totale." Ma non significa un po’ scappare di fronte alle proprie responsabilità? "Non so. Dipende dalla sensibilità dell’individuo." Don DeLillo ha già una discreta tendenza alla riservatezza, all’isolamento. Non si nasconderà anche lui nell’anonimato totale, un giorno o l’altro? "È possibile. Non posso escluderlo. Per me però non sarà una fuga dalla società: significherà soltanto lasciare che i miei libri procedano da soli, per ciò che valgono dal punto di vista letterario, senza la contaminazione delle pubbliche relazioni."
La definisca come vuole, ma a me sembra comunque una fuga. Quali rimedi si possono proporre, di fronte a un degrado sociale capace di ingenerare una simile voglia di nascondersi? "Non me li chieda. Non li so." E chi li sa, allora? Gli scrittori è legittimo che non l’abbiano chiaro, che si preoccupino prima di tutto del linguaggio e quindi della comunicazione, della deformazione messa in atto dai mass media, ma il presidente uscito dalle elezioni, almeno lui avrà le idee chiare, no? Almeno lui saprà che cosa si deve fare. "Mah", risponde DeLillo con un sorriso mesto. "Vede, dopo otto anni di Reagan e quattro di Bush ci si è ormai pubblicamente adeguati all’idea che per definizione il presidente sia l’ultimo a sapere ciò che avviene nel suo paese."
Don DeLillo, Mao II, Leonardo
(Europeo, 15 gennaio 1993)