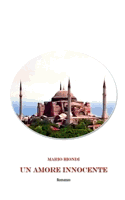Scrive di: Yaşar Kemal
1. Intervista (1987)
2. Recensione: “Il cardo” (1987)
3. Recensione: “Al di là della montagna - Bambini” (1996)
4. Recensione: Tu schiaccerai il serpente (1993)
1. Intervista (1987)
2. Recensione: “Il cardo” (1987)
3. Recensione: “Al di là della montagna - Bambini” (1996)
4. Recensione: Tu schiaccerai il serpente (1993)
© Mario Biondi
Divieto di riproduzione integrale
e obbligo di citazione (per cortesia...)
Istanbul-Costantinopoli festeggia rumorosamente (e con qualche apprensione delle autorità) la squadra di calcio del Galatasaray, campione di Turchia 1987, in un grande esplodere di «cim bom bom!» e con un festival giallorosso: un autentico mare di stendardi, bandiere, gagliardetti, sciarpe, fazzoletti, fusciacche, trecce, bracciali, distintivi, stracci, caccavelle, patacche. Anche in tal modo la bimillenaria metropoli si conferma nel suo ruolo di seconda Roma, e sotto tali colori tenta di ammantare le proprie vetuste rughe, immensa rosa dai petali ammaccatissimi, città mirabile. All’estremo margine di tutto ciò, nel sobborgo di Basimköy, in un luminoso appartamento le cui finestre danno da una parte sul Mar di Marmara e dall’altra sul laghetto di Kücük Cekmece, signorilmente distaccato, poderosamente tonante, calorosamente anatolico, incontrastato sciamano delle lettere turche e grande esponente della narrativa mondiale contemporanea, vive Yaşar Kemal, con la moglie Thilda Serero, alcuni gatti e chilometri di scaffali pieni tra l’altro delle varie edizioni delle proprie opere.
Trentatré volumi, tra romanzi (23), racconti e testi vari (in anni passati è stato anche importante giornalista). Di essi quindici sono stati pubblicati in trentasei paesi, per una gamma di traduzioni che va dall’inglese al cinese, dal francese al kazakh, dal tedesco allo... allo hindi? «No, diciamo al curdo: in India sono stato pubblicato in inglese.» In tutto ciò il contributo dell’Italia appare decisamente misero: un solo romanzo, Il cardo, pubblicato nel ’61 da Garzanti e recentemente ristampato, e un racconto, Il bambino, apparso nello stesso ’61 nell’Almanacco Bompiani. Ma, a quasi sessantacinque anni, Yaşar Kemal è ricco di riconoscimenti internazionali: è stato tra l’altro molto “chiacchierato” per il Nobel del ’73 e poi, nell’84, insignito della francese Legion d’Onore (insieme a Federico Fellini, Elie Wiesel e Joris Ivens). Al momento del nostro incontro è in partenza per Berlino, ufficialmente invitato a presenziare ai festeggiamenti per il 750° della città. Riconoscimenti venuti a premiare un’intera vita dedicata alle lettere e insieme all’impegno civile. Una vita che è stata già in sé un grande romanzo, pieno di avventure, di cui il suo corpo porta anche qualche segno fisico. Assaggiato il carcere nel proprio paese ai tempi della più dura repressione, alla fine dei ’70 ha dovuto «emigrare» per tre anni in Svezia: il suo nome era il terzo di un elenco di persone da “giustiziare” trovato nelle mani di terroristi di estrema destra. Tuttavia il primo di tali eventi romanzeschi (e tragici) non ha riguardato la sua persona, ma quella del padre, ucciso mentre pregava in una moschea. Ai tempi il figlio Yaşar aveva cinque anni. Ha mai scoperto l’autore e i motivi dell’assassinio?
«L’autore materiale fu il figlio adottivo di mio padre, che era molto più grande di me. I motivi che sono riuscito a ricostruire costituiscono materia di una mia trilogia narrativa, di cui sto attualmente scrivendo la terza parte. Una storia di mio padre che diventa una sorta di mia autobiografia fino agli undici anni.» Va infatti precisato che Yaşar Kemal ama procedere per ampie epopee, capaci di estendersi per tre, quattro romanzi, come nel caso della vicenda del “bandito” Ince Memed, ovvero “Memed il Sottile”, arrivata appunto al quarto romanzo (in Francia ne è uscita da qualche tempo presso Gallimard la terza, intitolata Le retour de Mémed le Mince), e la cui prima parte è appunto il citato Cardo.
Vicende in massima parte ambientate nella piana di Çukurova, nel medio sud-est anatolico, sua terra di origine. Una scelta “naturale”? «E’ una domanda che mi hanno fatto recentemente anche a New York. Sono turco, dunque scrivo di vicende e luoghi turchi. Ogni scrittore ha la sua Çukurova. Ce l’aveva Tolstoi. Ce l’aveva Dostoevskij. Ce l’aveva anche Kafka. Sono scelte che non avvengono a livello razionale. È come la definizione di “scrittore epico” che mi viene attribuita. Mi riempie di piacere, ma in realtà non credo di sapere nemmeno bene che cosa significhi l’espressione “epica”. Per quanto mi riguarda, cerco semplicemente di fare un nuovo tipo di romanzo. Tuttavia la struttura del romanzo dipende dal paese nel quale esso viene realizzato, dalla lingua in cui viene scritto. Pensi alle differenze che ci sono per esempio tra quello russo e quello inglese. I miei romanzi sono scritti in lingua turca, una lingua che è altamente poetica. Molto probabilmente è proprio tale qualità poetica a costituire la base della mia connotazione “epica”.»
Un’opera, quindi, fondamentalmente nazional-popolare, che affonda le radici nella cultura del popolo turco. «Guardi, le sorgenti a cui attinge il mio scrivere sono due. Prima di tutto le leggende turche e l’immenso patrimonio di storie orientali. Le Mille e una notte. Il Libro dei re, di Firdusi. Lo so a memoria. Poi il grande romanzo europeo, in particolare quello russo. La Turchia è sempre stata un paradiso delle traduzioni. Non abbiamo carta, ma abbiamo sempre avuto moltissimi libri. A ventitré anni, per esempio, ho letto tutto Verga. Ho letto Pirandello e Cecov, facendo una comparazione tra i loro stili. Forse gli autori turchi pubblicati in Italia non sono più di tre. I vostri contemporanei, invece, sono quasi tutti tradotti nella mia lingua, da Moravia a Eco.» (Infatti, Gülün Adi, ovvero Il nome della rosa, fa bella mostra di sé nelle vetrine di quasi tutte le librerie.)
«Poi ci sono i francesi. Sopra a tutti Stendhal. Mentre non mi piacciono i contemporanei. Comunque il moderno che amo di più è Faulkner. In un’intervista ho dichiarato che, se oggi Omero tornasse, scriverebbe come lui. E anche lui aveva la sua Çukurova.» E tra i classici? «Senza dubbio Cecov.» Quindi in sostanza Yaşar Kemal non si considera uno scrittore medio orientale, o più precisamente turco, staccato dalla tradizione europea. «Come potrei? Il romanzo è una forma letteraria specificamente occidentale. Dunque io sono uno scrittore occidentale. Che però fa tesoro del grande patrimonio di storie orientali. Noi turchi, fin dai tempi ottomani, stiamo a cavallo tra Occidente e Oriente, partecipiamo delle due culture. Perciò forse per voi europei non è facilissimo capire le nostre opere narrative. Pensi, per esempio, che la quarta parte di Ince Memed — un’opera che mi è costata fino a ora trentanove anni di lavoro — inizia con una citazione da una lettera di Leonardo da Vinci. Œ la descrizione della catena del Tauro, della mia terra, fatta da uno dei massimi geni dell’Occidente.»
Qual è la situazione dei narratori giovani in Turchia? Quali nomi indicherebbe? «Una situazione tutt’altro che florida. Mi sentirei di indicare soltanto il nome di Orhan Pamuk, che a trentatré anni ha scritto due romanzi di notevole qualità, dei quali il primo è stato recentemente pubblicato in Francia da Gallimard. Per il resto, come anche sul cinema (che è il nostro prodotto d’arte che conoscete di più), preferisco stendere un velo di silenzio.»
E quali sono i suoi rapporti con questa forma d’arte? «A suo tempo ho scritto le sceneggiature di dieci film. E sono stato il primo a far lavorare, come attore, il futuro regista Yilmaz Güney, quando era ancora un ragazzino affamato, appena arrivato da Adana per studiare scienze politiche. Poi sono stati tratti sette film da miei romanzi. L’ultimo è stato presentato quest’anno da Wim Wenders a Cannes. È Terra di ferro, cielo di rame, diretto dal musicista, scrittore e cineasta Livaneli e tratto dalla seconda parte di un’altra mia trilogia.»
(Il giornale, 20 giugno 1987)
II.
Nel medio sud est dell’Anatolia, poco prima dell’ansa mediterranea formata da quello che era un tempo il sangiaccato di Alessandretta (Iskenderun), la catena del Tauro arretra, cedendo alla vasta piana alluvionale formata da diversi fiumi, tra cui in particolare il Ceyhan. Nel suo cuore si leva misteriosa e inattingibile nell’ardere del sole la rocca romano-bizantina e poi armena di Anazarbus. Sotto, nelle aie delle povere case dei contadini di Anavarza, capita magari di incontrare una colonna, spazzando appena un poco per terra si scopre un mosaico. Più a sud, solitarissimo sulla sua altura si leva intatto il castello armeno di Yilan. Poco più a est, ora parzialmente coperte dal lago formato da una nuova diga, si levano le vestigia ittite di Karatepe e Domuztepe. La Collina nera. La Collina del Porco. In mezzo a tutto ciò sta Çukurova, con le sue terre riarse d’estate e scabre d’inverno, candide di cotone, dorate di grano e verdi di ortaggi nella stagione giusta.
Terra di conflitti insanabili fin dai tempi degli ittiti. In tempi più recenti tra ottomani e bizantini, tra musulmani e cristiani, tra cristiani ortodossi ed eretici monofisiti, tra turchi, armeni, curdi e turcomanni. Tra ricchissimi latifondisti di stampo feudale e miseri coltivatori o pastori nomadi fatti stanziare con la forza. Terra di sangue. Poco più in là si leva Maras, città di tragedie interrazziali. In questa terra, nel 1922, è nato Yaşar Kemal, forse il massimo narratore contemporaneo turco. E in questa terra è ambientato, in un vago periodo di tempo tra le due guerre, il suo romanzo più famoso, quell’Ince Mehmet, ovvero “Mehmet il sottile”, che qualche tempo fa lo ha posto seriamente in lizza per il Premio Nobel. Romanzo uscito in turco nel 1958 e pubblicato con grande tempestività dall’editore Garzanti già nel 1961, con il titolo Il cardo. Quanti italiani lo avranno letto, allora? Nella provinciale ignoranza della nostra cultura nei confronti di ciò che di vitale avviene nei paesi meno sviluppati del nostro, l’oblio era tornato a calare totale sul nome di Yaşar Kemal.
Ora, passato più di un quarto di secolo, molto meritoriamente il medesimo Garzanti ripropone ai nostri lettori la stessa traduzione di Giuseppe Cittone, ottima — e, crediamo, condotta seguendo i consigli della moglie di Yaşar Kemal, sua traduttrice in inglese —, anche se viziata da una singolare italianizzazione di nomi e luoghi, quasi che il turco non fosse una nobile lingua con una sua precisa fonetica (come se in edizione americana fosse, per esempio, lecito leggere Peenokkio). Chissà che accoglienza gli verrà riservata, questa volta? Il terreno dovrebbe essere più fertile, se non altro visto il grandissimo successo (persino un po’ esagerato, quanto a effettiva comprensione di linguaggio e temi) arriso qualche anno fa ai film del defunto giovane regista Yilmaz Güney (Yol, Il gregge, Il muro). Di Güney, Yaşar Kemal è sicuramente stato il maestro letterario. Uguale, nei due artisti, la tensione civile e morale, uguale l’amore per la campagna turca, uguale la passione per lo spirito di rivolta che ne anima da sempre le masse diseredate nei confronti del potere centrale. Non si dimentichi, a quest’ultimo proposito, che il grande gesto politico della “giovane” Turchia di Atatürk fu di riportare la capitale dall’Europa, dalla Costantinopoli bizantina dove aveva voluto istallarsi la Sublime Porta ottomana, corrompendosi, al cuore dell’Anatolia contadina e nomade del “puro” popolo turco, al cuore della “Vatan”, ovvero della “Patria”: ad Ankara.
Yaşar Kemal (come anche Yilmaz Güney) ha vissuto personalmente la durezza di quella terra. Rimasto orfano in giovanissima età di un padre misteriosamente assassinato, fatti mille mestieri umili, conosciuto il carcere della repressione antipopolare turca, è finalmente arrivato a cantare nei propri testi letterari quell’amato popolo da cui non dimentica di essere nato. Racconta la storia del ragazzo Mehmet, nato in un villaggio della piana di Çukurova, rimasto orfano e condannato a vivere da miserrimo contadino su una terra dominata da un signore feudale e resa ancora più tremenda dallo strazio che nelle carni di chi la lavora sanno fare i cardi (da qui il titolo italiano). Racconta di come, per amore e spirito di rivolta, Mehmet diviene brigante, una sorta di Robin Hood del Tauro, temuto dai ricchi e dai malvagi, idolatrato dai contadini più poveri, che lo chiamano “Il falco”. Racconta delle sue azioni temerarie, delle sue fughe disperate, dei suoi inaccessibili rifugi tra i monti, del suo amore, del suo figlio bambino, del nascere della sua leggenda dopo la definitiva scomparsa.
Profondamente ingenuo, generosamente sincero ed epicamente grandioso, com’è tipico dello spirito popolare turco, il romanzo si compone di cento personaggi, vicende, cartigli, canti, segni, come uno di quei kilim che ancora si rinvengono copiosi nei mercati dell’Anatolia e che raccontano un’inesplicabile vicenda di tribù, di clan, di amori sudori dolori, di vita e morte, di eventi reali e credenze magiche, comprensibile fino in fondo soltanto ai membri del clan che lo hanno tessuto, forse unicamente alla donna che tale kilim ha preparato al telaio per il futuro sposo, per la tenda del figlio, per la dote della figlia. C’è soltanto da augurarsi che il lettore italiano sappia abbandonarsi all’emozionante ingenuità dei segni e capirne la sottile arte intrisa di amore e pena.
Il cardo, Garzanti
(Il giornale, 6 aprile 1987)
III.
Se lo aspettavano in molti, laggiù tra Mar di Marmara e Bosforo: si pensava proprio che fosse l’anno buono, che gli accademici di Svezia avessero finalmente deciso di assegnare il Premio Nobel a Yaşar Kemal, il grande guerriero gentiluomo della letteratura turca. È dal 1984 che se ne parla. Con la sua trentina e oltre di libri tradotti in decine di lingue, tra grandi romanzi, racconti, testi per il cinema e vari, e soprattutto con la sua coraggiosa presenza civile e politica in Turchia, lo meriterebbe come pochi. Purtroppo non è stato così, la decisione degli accademici si è rivolta altrove. Peccato. Oltre che un riconoscimento giusto e meritato, sarebbe stato un segnale di quelli che si definiscono “forti” per lo schieramento politico che da qualche mese governa la Turchia in nome di un bigottismo islamico che il paese sembrava avere superato fino dai tempi del laicissimo Atatürk. Un segnale che cultura e laicità sono una componente imprescindibile di una società civile.
In nome di civiltà e laicismo Yaşar Kemal ha pagato molto, prima in gioventù, incarcerato con l’accusa di comunismo, e poi durante i difficilissimi anni (fine Settanta) dell’assalto reazionario al governo laburista, quando in testa a un elenco di “condannati a morte” stilato dai fascisti Lupi Grigi c’era proprio il suo nome. Di questi battaglieri eventi porta persino qualche segno sulla sua persona. L’assegnazione del Nobel avrebbe costituito un segnale inequivocabile: che la cultura mondiale non può tollerare che Kemal rischi di fare la fine di un altro scrittore laico (e amatissimo dal popolo turco), Aziz Nesin, picchiato a morte dalla feccia integralista perché reo di sostenere animosamente le ragioni del progressismo laico contro l’oscurantismo.
Una decina di anni fa, quando conobbi Yaşar Kemal, il suo tranquillo appartamento su una rientranza del Mar di Marmara era dominato dalla presenza di un’energica popolana dell’Anatolia. Era la domestica, ma apparteneva a pieno titolo alla famiglia: pranzava al tavolo con datori di lavoro e ospite straniero, partecipava senza remore alla conversazione. Donna indomabile e Anatolia: un concentrato di poetiche di Yaşar Kemal. Le ritroviamo anche nel bellissimo, dolente romanzo Al di là della montagna pubblicato da Tranchida, piccolo e coraggioso editore che sembra intenzionato a fare finalmente conoscere in una giusta misura (e in traduzioni adeguate) anche al pubblico italiano il grande cantore — forse curdo, forse turkmeno, chi lo saprà mai con certezza? — del Sudest turco e delle sue infinite tribolazioni ed etnie.
Yaşar Kemal ama procedere per sterminati affreschi narrativi: la battaglia civile del ribelle Mehmet il Sottile nell’interminabile saga epica di cui in italiano conosciamo soltanto Il cardo; le disperate vicende di Alì il Lungo nella trilogia che comincia appunto con Al di là della montagna. L’eroica figura di Mehmet il Sottile (chiamato “lo Smilzo" non so con quanta precisione, a meno che non siano “smilzi” anche gli “Ince Minare”, ovvero “Minareti Sottili” che costellano le terre turche) ricompare fuggevolmente anche in Al di là della montagna, luce di speranza per le diseredate folle contadine che Alì il Lungo epitomizza nella sua infelice odissea tra i monti del Tauro.
La Çukurova, la piana attorno ad Adana, dove Kemal è cresciuto, terra di violenti contrasti etnici, religiosi e politici — tra armeni e curdi, tra musulmani e cristiani, tra sunniti e sciiti, tra braccianti agricoli e latifondisti —, in autunno si copre di un biancore che da lontano potrebbe sembrare neve e che invece è la fioritura del cotone. Verso il raccolto, poco meno che l’unica risorsa lavorativa annuale, dai retrostanti monti, per le strade percorse da Senofonte (già a quei tempi tra insidie di armeni e “carduchi”), scendono i braccianti. Chi prima arriva meglio trova da raccogliere e più guadagna. Ma sull’ambiguo gioco di anticipi e ritardi speculano sordidamente latifondisti, mediatori e politici, favorendo sfacciatamente i loro galoppini e punendo chi ha osato in qualsiasi modo sgarrare. È la sfortunata sorte che tocca ad Alì il Lungo e ai suoi compagni di abortita ribellione: fatti aspettare con l’inganno, troveranno soltanto un raccolto magrissimo, anticipatore di un inverno di fame e stenti. Hanno osato ribellarsi, paghino. Ma il romanzo oltrepassa la figura e le vicende di Alì per diventare un vastissimo affresco di vita e leggenda nelle campagne del Sudest turco. Con straordinarie figure di donne, remissive e sottomesse quando fanciulle e mogli, indomabili quando madri, nell’antica logica della “donna ottomana”, che ha imparato a difendere se stessa e la propria prole nell’harem e a farne un campo di battaglia.
Tutto attorno, poi, un intero repertorio di vicende piccole e grandi, private e pubbliche, storiche e leggendarie, a formare un variegatissimo kilim (il tappeto tessuto della campagna anatolica) narrativo alle cui spalle stanno i grandi narratori dell’Ottocento europeo ma anche le arabe Mille e una notte e il persiano Libro dei Re, più il lirismo di Yunus Emre e dei grandi poeti ottomani e la saggezza popolare turca rappresentata nella figura del bonario narratore campagnolo itinerante Nasrettin Hoca (Hogia), sempre in groppa al suo asinello.
Insieme al romanzo, Tranchida pubblica una straordinaria raccolta di tre racconti intitolata Bambini. Un piccolo grande libro: speranze disilluse di bambini, sfruttamento di bambini, dolore di bambini, un universo di condizione infantile ritratto oltre quarant’anni or sono ma ancora oggi di assoluta attualità: in certe terre sfortunate il tempo “sociale” sembra non trovare mai la forza di muoversi se non in termini di caotica esplosione di consumi e inflazione.
Al di là della montagna, Tranchida
Bambini, Tranchida
(L’unità, settembre 1996)
IV.
In un gradevole sobborgo istanbulino su un’ansa del Mar di Marmara, incontrastato sciamano delle lettere turche, vive Yashar Kemal con la moglie Thilda Serero (antica stirpe sefardita, sua appassionata propagandista e traduttrice in inglese), tra scaffali pieni delle varie edizioni delle sue opere. Più di trenta volumi, in buona parte pubblicati in trentasei paesi, per una gamma di traduzioni che va dall’inglese (Collins & Harvill) al cinese, dal francese (Gallimard) al kazakh. Un vastissimo consenso internazionale, cui per altro l’Italia ha finora dato un contributo veramente misero: un solo romanzo, Il cardo (Garzanti), e un racconto, Il bambino, apparso nell’Almanacco Bompiani. Eppure, a settant’anni, Kemal è ricco di riconoscimenti internazionali — è stato in lizza per il Nobel, nell’84 ha ricevuto la Legion d’Onore —, venuti a premiare una vita dedicata alle lettere e all’impegno civile. Una vita che è stata già in sé un periglioso romanzo, di cui il viso di Kemal porta anche qualche segno fisico. Assaggiato il carcere turco ai tempi di Menderes, alla fine degli anni ’70 ha dovuto rifugiarsi per tre anni in Svezia: su un elenco di persone da “giustiziare” trovato nelle mani di estremisti di destra, il suo nome compariva tra i primi.
Yashar Kemal ama procedere per ampie epopee, capaci di estendersi per diversi volumi, come nel caso della vicenda del bandito Memed il Sottile — la cui prima parte è appunto il citato Cardo — arrivata al quarto romanzo. Vicende in larga parte ambientate nella piana di Çukurova, sua terra di origine, nel medio sud-est anatolico, ai piedi della catena del Tauro. Terra di conflitti insanabili. Già ai tempi di Senofonte vi si scontravano carduchi (curdi) e armeni. Poi ottomani e bizantini, musulmani e cristiani, cristiani ortodossi ed eretici monofisiti. Terra ricca di cotone, abitata da latifondisti di stampo feudale e da contadini o pastori nomadi. Terra di sangue.
Lì (o comunque nello spirito ardente di quelle genti), oltre alle epopee di Kemal sono in parte ambientati anche i film del defunto regista Yilmaz Güney (Yol, Il gregge, Il muro), di cui lo scrittore è stato il padre putativo. Uguale, nei due artisti, la tensione civile, uguale l’amore per la campagna turca, uguale la passione per lo spirito di rivolta che ne anima le masse diseredate. E in Cukurova è ambietato anche Tu schiaccerai il serpente, squisita novella che in questi giorni è andata ad arricchire la troppo modesta presenza di Kemal nei cataloghi librari italiani. Un’altra vicenda di epos e sangue, intrisa di poesia (ma tradotta dall’inglese), in cui Kemal canta le peripezie di Hasan, bambino chiamato dalla famiglia a punire la madre, ritenuta adultera e assassina del marito, in nome di una spietata legge d’onore (qualcuno ricorderà un episodio analogo nel film Yol).
Yashar Kemal, Tu schiaccerai il serpente, Tranchida
(Corriere della sera, 26 luglio 1993)
Trentatré volumi, tra romanzi (23), racconti e testi vari (in anni passati è stato anche importante giornalista). Di essi quindici sono stati pubblicati in trentasei paesi, per una gamma di traduzioni che va dall’inglese al cinese, dal francese al kazakh, dal tedesco allo... allo hindi? «No, diciamo al curdo: in India sono stato pubblicato in inglese.» In tutto ciò il contributo dell’Italia appare decisamente misero: un solo romanzo, Il cardo, pubblicato nel ’61 da Garzanti e recentemente ristampato, e un racconto, Il bambino, apparso nello stesso ’61 nell’Almanacco Bompiani. Ma, a quasi sessantacinque anni, Yaşar Kemal è ricco di riconoscimenti internazionali: è stato tra l’altro molto “chiacchierato” per il Nobel del ’73 e poi, nell’84, insignito della francese Legion d’Onore (insieme a Federico Fellini, Elie Wiesel e Joris Ivens). Al momento del nostro incontro è in partenza per Berlino, ufficialmente invitato a presenziare ai festeggiamenti per il 750° della città. Riconoscimenti venuti a premiare un’intera vita dedicata alle lettere e insieme all’impegno civile. Una vita che è stata già in sé un grande romanzo, pieno di avventure, di cui il suo corpo porta anche qualche segno fisico. Assaggiato il carcere nel proprio paese ai tempi della più dura repressione, alla fine dei ’70 ha dovuto «emigrare» per tre anni in Svezia: il suo nome era il terzo di un elenco di persone da “giustiziare” trovato nelle mani di terroristi di estrema destra. Tuttavia il primo di tali eventi romanzeschi (e tragici) non ha riguardato la sua persona, ma quella del padre, ucciso mentre pregava in una moschea. Ai tempi il figlio Yaşar aveva cinque anni. Ha mai scoperto l’autore e i motivi dell’assassinio?
«L’autore materiale fu il figlio adottivo di mio padre, che era molto più grande di me. I motivi che sono riuscito a ricostruire costituiscono materia di una mia trilogia narrativa, di cui sto attualmente scrivendo la terza parte. Una storia di mio padre che diventa una sorta di mia autobiografia fino agli undici anni.» Va infatti precisato che Yaşar Kemal ama procedere per ampie epopee, capaci di estendersi per tre, quattro romanzi, come nel caso della vicenda del “bandito” Ince Memed, ovvero “Memed il Sottile”, arrivata appunto al quarto romanzo (in Francia ne è uscita da qualche tempo presso Gallimard la terza, intitolata Le retour de Mémed le Mince), e la cui prima parte è appunto il citato Cardo.
Vicende in massima parte ambientate nella piana di Çukurova, nel medio sud-est anatolico, sua terra di origine. Una scelta “naturale”? «E’ una domanda che mi hanno fatto recentemente anche a New York. Sono turco, dunque scrivo di vicende e luoghi turchi. Ogni scrittore ha la sua Çukurova. Ce l’aveva Tolstoi. Ce l’aveva Dostoevskij. Ce l’aveva anche Kafka. Sono scelte che non avvengono a livello razionale. È come la definizione di “scrittore epico” che mi viene attribuita. Mi riempie di piacere, ma in realtà non credo di sapere nemmeno bene che cosa significhi l’espressione “epica”. Per quanto mi riguarda, cerco semplicemente di fare un nuovo tipo di romanzo. Tuttavia la struttura del romanzo dipende dal paese nel quale esso viene realizzato, dalla lingua in cui viene scritto. Pensi alle differenze che ci sono per esempio tra quello russo e quello inglese. I miei romanzi sono scritti in lingua turca, una lingua che è altamente poetica. Molto probabilmente è proprio tale qualità poetica a costituire la base della mia connotazione “epica”.»
Un’opera, quindi, fondamentalmente nazional-popolare, che affonda le radici nella cultura del popolo turco. «Guardi, le sorgenti a cui attinge il mio scrivere sono due. Prima di tutto le leggende turche e l’immenso patrimonio di storie orientali. Le Mille e una notte. Il Libro dei re, di Firdusi. Lo so a memoria. Poi il grande romanzo europeo, in particolare quello russo. La Turchia è sempre stata un paradiso delle traduzioni. Non abbiamo carta, ma abbiamo sempre avuto moltissimi libri. A ventitré anni, per esempio, ho letto tutto Verga. Ho letto Pirandello e Cecov, facendo una comparazione tra i loro stili. Forse gli autori turchi pubblicati in Italia non sono più di tre. I vostri contemporanei, invece, sono quasi tutti tradotti nella mia lingua, da Moravia a Eco.» (Infatti, Gülün Adi, ovvero Il nome della rosa, fa bella mostra di sé nelle vetrine di quasi tutte le librerie.)
«Poi ci sono i francesi. Sopra a tutti Stendhal. Mentre non mi piacciono i contemporanei. Comunque il moderno che amo di più è Faulkner. In un’intervista ho dichiarato che, se oggi Omero tornasse, scriverebbe come lui. E anche lui aveva la sua Çukurova.» E tra i classici? «Senza dubbio Cecov.» Quindi in sostanza Yaşar Kemal non si considera uno scrittore medio orientale, o più precisamente turco, staccato dalla tradizione europea. «Come potrei? Il romanzo è una forma letteraria specificamente occidentale. Dunque io sono uno scrittore occidentale. Che però fa tesoro del grande patrimonio di storie orientali. Noi turchi, fin dai tempi ottomani, stiamo a cavallo tra Occidente e Oriente, partecipiamo delle due culture. Perciò forse per voi europei non è facilissimo capire le nostre opere narrative. Pensi, per esempio, che la quarta parte di Ince Memed — un’opera che mi è costata fino a ora trentanove anni di lavoro — inizia con una citazione da una lettera di Leonardo da Vinci. Œ la descrizione della catena del Tauro, della mia terra, fatta da uno dei massimi geni dell’Occidente.»
Qual è la situazione dei narratori giovani in Turchia? Quali nomi indicherebbe? «Una situazione tutt’altro che florida. Mi sentirei di indicare soltanto il nome di Orhan Pamuk, che a trentatré anni ha scritto due romanzi di notevole qualità, dei quali il primo è stato recentemente pubblicato in Francia da Gallimard. Per il resto, come anche sul cinema (che è il nostro prodotto d’arte che conoscete di più), preferisco stendere un velo di silenzio.»
E quali sono i suoi rapporti con questa forma d’arte? «A suo tempo ho scritto le sceneggiature di dieci film. E sono stato il primo a far lavorare, come attore, il futuro regista Yilmaz Güney, quando era ancora un ragazzino affamato, appena arrivato da Adana per studiare scienze politiche. Poi sono stati tratti sette film da miei romanzi. L’ultimo è stato presentato quest’anno da Wim Wenders a Cannes. È Terra di ferro, cielo di rame, diretto dal musicista, scrittore e cineasta Livaneli e tratto dalla seconda parte di un’altra mia trilogia.»
(Il giornale, 20 giugno 1987)
II.
Nel medio sud est dell’Anatolia, poco prima dell’ansa mediterranea formata da quello che era un tempo il sangiaccato di Alessandretta (Iskenderun), la catena del Tauro arretra, cedendo alla vasta piana alluvionale formata da diversi fiumi, tra cui in particolare il Ceyhan. Nel suo cuore si leva misteriosa e inattingibile nell’ardere del sole la rocca romano-bizantina e poi armena di Anazarbus. Sotto, nelle aie delle povere case dei contadini di Anavarza, capita magari di incontrare una colonna, spazzando appena un poco per terra si scopre un mosaico. Più a sud, solitarissimo sulla sua altura si leva intatto il castello armeno di Yilan. Poco più a est, ora parzialmente coperte dal lago formato da una nuova diga, si levano le vestigia ittite di Karatepe e Domuztepe. La Collina nera. La Collina del Porco. In mezzo a tutto ciò sta Çukurova, con le sue terre riarse d’estate e scabre d’inverno, candide di cotone, dorate di grano e verdi di ortaggi nella stagione giusta.
Terra di conflitti insanabili fin dai tempi degli ittiti. In tempi più recenti tra ottomani e bizantini, tra musulmani e cristiani, tra cristiani ortodossi ed eretici monofisiti, tra turchi, armeni, curdi e turcomanni. Tra ricchissimi latifondisti di stampo feudale e miseri coltivatori o pastori nomadi fatti stanziare con la forza. Terra di sangue. Poco più in là si leva Maras, città di tragedie interrazziali. In questa terra, nel 1922, è nato Yaşar Kemal, forse il massimo narratore contemporaneo turco. E in questa terra è ambientato, in un vago periodo di tempo tra le due guerre, il suo romanzo più famoso, quell’Ince Mehmet, ovvero “Mehmet il sottile”, che qualche tempo fa lo ha posto seriamente in lizza per il Premio Nobel. Romanzo uscito in turco nel 1958 e pubblicato con grande tempestività dall’editore Garzanti già nel 1961, con il titolo Il cardo. Quanti italiani lo avranno letto, allora? Nella provinciale ignoranza della nostra cultura nei confronti di ciò che di vitale avviene nei paesi meno sviluppati del nostro, l’oblio era tornato a calare totale sul nome di Yaşar Kemal.
Ora, passato più di un quarto di secolo, molto meritoriamente il medesimo Garzanti ripropone ai nostri lettori la stessa traduzione di Giuseppe Cittone, ottima — e, crediamo, condotta seguendo i consigli della moglie di Yaşar Kemal, sua traduttrice in inglese —, anche se viziata da una singolare italianizzazione di nomi e luoghi, quasi che il turco non fosse una nobile lingua con una sua precisa fonetica (come se in edizione americana fosse, per esempio, lecito leggere Peenokkio). Chissà che accoglienza gli verrà riservata, questa volta? Il terreno dovrebbe essere più fertile, se non altro visto il grandissimo successo (persino un po’ esagerato, quanto a effettiva comprensione di linguaggio e temi) arriso qualche anno fa ai film del defunto giovane regista Yilmaz Güney (Yol, Il gregge, Il muro). Di Güney, Yaşar Kemal è sicuramente stato il maestro letterario. Uguale, nei due artisti, la tensione civile e morale, uguale l’amore per la campagna turca, uguale la passione per lo spirito di rivolta che ne anima da sempre le masse diseredate nei confronti del potere centrale. Non si dimentichi, a quest’ultimo proposito, che il grande gesto politico della “giovane” Turchia di Atatürk fu di riportare la capitale dall’Europa, dalla Costantinopoli bizantina dove aveva voluto istallarsi la Sublime Porta ottomana, corrompendosi, al cuore dell’Anatolia contadina e nomade del “puro” popolo turco, al cuore della “Vatan”, ovvero della “Patria”: ad Ankara.
Yaşar Kemal (come anche Yilmaz Güney) ha vissuto personalmente la durezza di quella terra. Rimasto orfano in giovanissima età di un padre misteriosamente assassinato, fatti mille mestieri umili, conosciuto il carcere della repressione antipopolare turca, è finalmente arrivato a cantare nei propri testi letterari quell’amato popolo da cui non dimentica di essere nato. Racconta la storia del ragazzo Mehmet, nato in un villaggio della piana di Çukurova, rimasto orfano e condannato a vivere da miserrimo contadino su una terra dominata da un signore feudale e resa ancora più tremenda dallo strazio che nelle carni di chi la lavora sanno fare i cardi (da qui il titolo italiano). Racconta di come, per amore e spirito di rivolta, Mehmet diviene brigante, una sorta di Robin Hood del Tauro, temuto dai ricchi e dai malvagi, idolatrato dai contadini più poveri, che lo chiamano “Il falco”. Racconta delle sue azioni temerarie, delle sue fughe disperate, dei suoi inaccessibili rifugi tra i monti, del suo amore, del suo figlio bambino, del nascere della sua leggenda dopo la definitiva scomparsa.
Profondamente ingenuo, generosamente sincero ed epicamente grandioso, com’è tipico dello spirito popolare turco, il romanzo si compone di cento personaggi, vicende, cartigli, canti, segni, come uno di quei kilim che ancora si rinvengono copiosi nei mercati dell’Anatolia e che raccontano un’inesplicabile vicenda di tribù, di clan, di amori sudori dolori, di vita e morte, di eventi reali e credenze magiche, comprensibile fino in fondo soltanto ai membri del clan che lo hanno tessuto, forse unicamente alla donna che tale kilim ha preparato al telaio per il futuro sposo, per la tenda del figlio, per la dote della figlia. C’è soltanto da augurarsi che il lettore italiano sappia abbandonarsi all’emozionante ingenuità dei segni e capirne la sottile arte intrisa di amore e pena.
Il cardo, Garzanti
(Il giornale, 6 aprile 1987)
III.
Se lo aspettavano in molti, laggiù tra Mar di Marmara e Bosforo: si pensava proprio che fosse l’anno buono, che gli accademici di Svezia avessero finalmente deciso di assegnare il Premio Nobel a Yaşar Kemal, il grande guerriero gentiluomo della letteratura turca. È dal 1984 che se ne parla. Con la sua trentina e oltre di libri tradotti in decine di lingue, tra grandi romanzi, racconti, testi per il cinema e vari, e soprattutto con la sua coraggiosa presenza civile e politica in Turchia, lo meriterebbe come pochi. Purtroppo non è stato così, la decisione degli accademici si è rivolta altrove. Peccato. Oltre che un riconoscimento giusto e meritato, sarebbe stato un segnale di quelli che si definiscono “forti” per lo schieramento politico che da qualche mese governa la Turchia in nome di un bigottismo islamico che il paese sembrava avere superato fino dai tempi del laicissimo Atatürk. Un segnale che cultura e laicità sono una componente imprescindibile di una società civile.
In nome di civiltà e laicismo Yaşar Kemal ha pagato molto, prima in gioventù, incarcerato con l’accusa di comunismo, e poi durante i difficilissimi anni (fine Settanta) dell’assalto reazionario al governo laburista, quando in testa a un elenco di “condannati a morte” stilato dai fascisti Lupi Grigi c’era proprio il suo nome. Di questi battaglieri eventi porta persino qualche segno sulla sua persona. L’assegnazione del Nobel avrebbe costituito un segnale inequivocabile: che la cultura mondiale non può tollerare che Kemal rischi di fare la fine di un altro scrittore laico (e amatissimo dal popolo turco), Aziz Nesin, picchiato a morte dalla feccia integralista perché reo di sostenere animosamente le ragioni del progressismo laico contro l’oscurantismo.
Una decina di anni fa, quando conobbi Yaşar Kemal, il suo tranquillo appartamento su una rientranza del Mar di Marmara era dominato dalla presenza di un’energica popolana dell’Anatolia. Era la domestica, ma apparteneva a pieno titolo alla famiglia: pranzava al tavolo con datori di lavoro e ospite straniero, partecipava senza remore alla conversazione. Donna indomabile e Anatolia: un concentrato di poetiche di Yaşar Kemal. Le ritroviamo anche nel bellissimo, dolente romanzo Al di là della montagna pubblicato da Tranchida, piccolo e coraggioso editore che sembra intenzionato a fare finalmente conoscere in una giusta misura (e in traduzioni adeguate) anche al pubblico italiano il grande cantore — forse curdo, forse turkmeno, chi lo saprà mai con certezza? — del Sudest turco e delle sue infinite tribolazioni ed etnie.
Yaşar Kemal ama procedere per sterminati affreschi narrativi: la battaglia civile del ribelle Mehmet il Sottile nell’interminabile saga epica di cui in italiano conosciamo soltanto Il cardo; le disperate vicende di Alì il Lungo nella trilogia che comincia appunto con Al di là della montagna. L’eroica figura di Mehmet il Sottile (chiamato “lo Smilzo" non so con quanta precisione, a meno che non siano “smilzi” anche gli “Ince Minare”, ovvero “Minareti Sottili” che costellano le terre turche) ricompare fuggevolmente anche in Al di là della montagna, luce di speranza per le diseredate folle contadine che Alì il Lungo epitomizza nella sua infelice odissea tra i monti del Tauro.
La Çukurova, la piana attorno ad Adana, dove Kemal è cresciuto, terra di violenti contrasti etnici, religiosi e politici — tra armeni e curdi, tra musulmani e cristiani, tra sunniti e sciiti, tra braccianti agricoli e latifondisti —, in autunno si copre di un biancore che da lontano potrebbe sembrare neve e che invece è la fioritura del cotone. Verso il raccolto, poco meno che l’unica risorsa lavorativa annuale, dai retrostanti monti, per le strade percorse da Senofonte (già a quei tempi tra insidie di armeni e “carduchi”), scendono i braccianti. Chi prima arriva meglio trova da raccogliere e più guadagna. Ma sull’ambiguo gioco di anticipi e ritardi speculano sordidamente latifondisti, mediatori e politici, favorendo sfacciatamente i loro galoppini e punendo chi ha osato in qualsiasi modo sgarrare. È la sfortunata sorte che tocca ad Alì il Lungo e ai suoi compagni di abortita ribellione: fatti aspettare con l’inganno, troveranno soltanto un raccolto magrissimo, anticipatore di un inverno di fame e stenti. Hanno osato ribellarsi, paghino. Ma il romanzo oltrepassa la figura e le vicende di Alì per diventare un vastissimo affresco di vita e leggenda nelle campagne del Sudest turco. Con straordinarie figure di donne, remissive e sottomesse quando fanciulle e mogli, indomabili quando madri, nell’antica logica della “donna ottomana”, che ha imparato a difendere se stessa e la propria prole nell’harem e a farne un campo di battaglia.
Tutto attorno, poi, un intero repertorio di vicende piccole e grandi, private e pubbliche, storiche e leggendarie, a formare un variegatissimo kilim (il tappeto tessuto della campagna anatolica) narrativo alle cui spalle stanno i grandi narratori dell’Ottocento europeo ma anche le arabe Mille e una notte e il persiano Libro dei Re, più il lirismo di Yunus Emre e dei grandi poeti ottomani e la saggezza popolare turca rappresentata nella figura del bonario narratore campagnolo itinerante Nasrettin Hoca (Hogia), sempre in groppa al suo asinello.
Insieme al romanzo, Tranchida pubblica una straordinaria raccolta di tre racconti intitolata Bambini. Un piccolo grande libro: speranze disilluse di bambini, sfruttamento di bambini, dolore di bambini, un universo di condizione infantile ritratto oltre quarant’anni or sono ma ancora oggi di assoluta attualità: in certe terre sfortunate il tempo “sociale” sembra non trovare mai la forza di muoversi se non in termini di caotica esplosione di consumi e inflazione.
Al di là della montagna, Tranchida
Bambini, Tranchida
(L’unità, settembre 1996)
IV.
In un gradevole sobborgo istanbulino su un’ansa del Mar di Marmara, incontrastato sciamano delle lettere turche, vive Yashar Kemal con la moglie Thilda Serero (antica stirpe sefardita, sua appassionata propagandista e traduttrice in inglese), tra scaffali pieni delle varie edizioni delle sue opere. Più di trenta volumi, in buona parte pubblicati in trentasei paesi, per una gamma di traduzioni che va dall’inglese (Collins & Harvill) al cinese, dal francese (Gallimard) al kazakh. Un vastissimo consenso internazionale, cui per altro l’Italia ha finora dato un contributo veramente misero: un solo romanzo, Il cardo (Garzanti), e un racconto, Il bambino, apparso nell’Almanacco Bompiani. Eppure, a settant’anni, Kemal è ricco di riconoscimenti internazionali — è stato in lizza per il Nobel, nell’84 ha ricevuto la Legion d’Onore —, venuti a premiare una vita dedicata alle lettere e all’impegno civile. Una vita che è stata già in sé un periglioso romanzo, di cui il viso di Kemal porta anche qualche segno fisico. Assaggiato il carcere turco ai tempi di Menderes, alla fine degli anni ’70 ha dovuto rifugiarsi per tre anni in Svezia: su un elenco di persone da “giustiziare” trovato nelle mani di estremisti di destra, il suo nome compariva tra i primi.
Yashar Kemal ama procedere per ampie epopee, capaci di estendersi per diversi volumi, come nel caso della vicenda del bandito Memed il Sottile — la cui prima parte è appunto il citato Cardo — arrivata al quarto romanzo. Vicende in larga parte ambientate nella piana di Çukurova, sua terra di origine, nel medio sud-est anatolico, ai piedi della catena del Tauro. Terra di conflitti insanabili. Già ai tempi di Senofonte vi si scontravano carduchi (curdi) e armeni. Poi ottomani e bizantini, musulmani e cristiani, cristiani ortodossi ed eretici monofisiti. Terra ricca di cotone, abitata da latifondisti di stampo feudale e da contadini o pastori nomadi. Terra di sangue.
Lì (o comunque nello spirito ardente di quelle genti), oltre alle epopee di Kemal sono in parte ambientati anche i film del defunto regista Yilmaz Güney (Yol, Il gregge, Il muro), di cui lo scrittore è stato il padre putativo. Uguale, nei due artisti, la tensione civile, uguale l’amore per la campagna turca, uguale la passione per lo spirito di rivolta che ne anima le masse diseredate. E in Cukurova è ambietato anche Tu schiaccerai il serpente, squisita novella che in questi giorni è andata ad arricchire la troppo modesta presenza di Kemal nei cataloghi librari italiani. Un’altra vicenda di epos e sangue, intrisa di poesia (ma tradotta dall’inglese), in cui Kemal canta le peripezie di Hasan, bambino chiamato dalla famiglia a punire la madre, ritenuta adultera e assassina del marito, in nome di una spietata legge d’onore (qualcuno ricorderà un episodio analogo nel film Yol).
Yashar Kemal, Tu schiaccerai il serpente, Tranchida
(Corriere della sera, 26 luglio 1993)